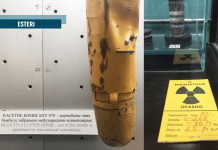Niente che non sia già stato detto – ma ha bisogno di essere ripetuto – verrà scritto in queste pagine su una morte italiana nel Paese che Reporter sans frontiers colloca al secondo posto nel mondo per numero di giornalisti arrestati, corrispondenti che adesso si trovano dietro le sbarre del sistema Egitto, in carceri che esistono da molto più tempo del regime dell’ultimo golpista sul Nilo. Prima che ricorresse l’anniversario della rivoluzione di Tahrir, prima che Giulio morisse, 5mila case erano già state perquisite dalle divise: «È molto peggio dell’era Mubarak», lo ripetono tutti, ma Halem Henish è uno dei pochi che lo fa ad alta voce con in mano una lista di desaparecidos, scomparse che seguono ad arresti arbitrari, stupri della polizia ed ergastoli a dissidenti. Secondo lui e l’Ecfr, Egyptian commission rights and freedom, sono 340 i desaparecidos egiziani da ottobre a dicembre, 163 da aprile a giugno 2015.
Mentre si agita lo spauracchio della lotta al jihad e “antiterrorismo” è l’etichetta che si usa per reprimere i diritti civili, in Egitto si schiaccia, si annega e si ammazza la comunità sociale laica insieme a quella religiosa: più di 40mila arresti dal 2013, 1.700 condanne a morte (a volte eseguite, a volte solo emesse), giustizia sommaria per blogger, sindacalisti, attivisti perseguitati oggi da Al Sisi, ieri da Mubarak, poi dai Fratelli musulmani, adesso a loro volta arrestati. Secondo gli Usa, ci sono 62mila persone nelle 42 carceri egiziane. Secondo chi è rimasto fuori a urlare il nome di chi è dentro, molti di più.
In questi giorni a parlare di questo regime militare, alleato internazionale dell’Italia, è un lenzuolo bianco che contiene la salma di un dottorando di Cambridge. Orecchie tagliate, pugni, bruciature sul corpo, 31 fratture e una letale alla vertebra cervicale: quelli che hanno torturato Giulio volevano conoscere forse il nome delle sue fonti, di chi gli aveva passato le informazioni. Non l’ha protetto uno pseudonimo, un nom de plume di copertura. Se ne va dall’Egitto da martire dell’informazione, perché martoriato da un potere oppressivo dove basta un sorriso, una lingua straniera parlata troppo e troppo bene – o anche una parola sola – per diventare, sotto gli occhi vigili della paranoia militare, una spia, un sabotatore. Un informatore straniero. Nel migliore dei casi, un disturbatore.
In un fosso sotto il cavalcavia Hazem Hassan, lungo la strada che collega Alessandria al Cairo, Giulio è stato trovato per caso da uno di quei lavoratori senza diritti sindacali di cui scriveva. Un tassista con un guasto al motore. Raccontava di loro, dei venditori ambulanti, degli ultimi che nelle riunioni sindacali avanzavano rivendicazioni socialiste. Ne scriveva negli articoli pubblicati pre e post mortem, inviati a giornali che si affannano solo ora a sbatterlo in prima pagina. Tanto costa la verità d’inchiostro se finisci nelle mani delle squadracce del Cairo. Ed è dal governo Al Sisi, che ora dice di voler far luce sulla faccenda, che i primi depistaggi sull’indagine sono stati fatti trapelare. Le accuse sul coinvolgimento del governo vengono negate dal ministro dell’Interno egiziano, il generale Magdi Abdel Gheffar: «Il 25 gennaio Regeni non è stato arrestato da nessun apparato dello Stato, ci offende che vengano accusati i nostri servizi segreti».
Questo editoriale lo trovi sul n. 7 di Left in edicola dal 13 febbraio