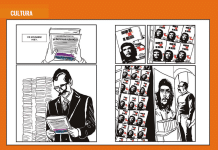Di Carlo Giuliani preferisce non parlare, Daniele Vicari. «Non ne parlo per puro pudore, ma sono accanto alla sua famiglia». Di quelle giornate «ho scelto di raccontare la sospensione dei diritti della persona, ho raccontato la tortura attraverso atti incontrovertibili. Raccontare l’indicibile, sia per i poliziotti che per le vittime». E l’indicibile è quanto accaduto a Genova 2001: «Non è stata semplicemente la rottura di un patto sociale ma la riemersione degli elementi più reazionari dello Stato che per un momento, per un giorno, per una settimana, hanno mostrato a tutti cos’è uno Stato autoritario. E i cittadini si sono schierati da una parte o dall’altra, come in un colpo di Stato». Dice Daniele Vicari, quindici anni dopo i fatti di Genova 2001: 7 processi, 100 imputati condannati, più di 300 udienze, 170 anni di reclusione comminati, 8 pubblici ministeri impegnati, 120 avvocati. E 12 milioni di euro di danno patrimoniale e all’immagine dello Stato provocato dal comportamento della polizia, quantifica la Corte dei Conti.
Proprio in queste ore, il ministro dell’Interno Alfano ha chiesto che il testo della legge sul reato di tortura venga rivisto alla Camera, «per evitare ogni possibile fraintendimento riguardo l’uso legittimo della forza da parte delle forze di polizia».
Se la traduciamo, la frase del ministro significa: dobbiamo usare la tortura perché siamo in guerra. Ha rivendicato la necessità della tortura, una cosa di una gravità incredibile.
Resto convinto che la tortura – e la pratica della tortura di massa da parte di centinaia di persone in divisa, che rappresentano lo Stato italiano – sia un vulnus alla democrazia così macroscopico da diventare uno dei motivi per cui oggi lo Stato è in crisi. E la politica è in crisi, perché ha perso totalmente di credibilità e non solo agli occhi delle vittime. È il segno di un periodo storico nel quale i diritti della persona umana passano in secondo piano rispetto a questioni come l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Siamo nel bel mezzo di uno “Stato di eccezione”, e Genova è uno dei pilastri della sua costruzione. Genova ci ha fatto vedere l’abisso.
E noi abbiamo avuto paura di guardarci dentro, giusto?
Il nucleo fondante della questione di Genova va al di là del merito delle questioni politiche poste dal movimento in quei giorni. Anche perché il movimento si muoveva dentro una compatibilità politica ampiamente accettata: il Genoa Social Forum prese anche finanziamenti pubblici per organizzare quella manifestazione, venne finanziato dall’allora governo Prodi e la stessa Diaz non era occupata ma era stata data in concessione dalla Provincia. Era tutto legale quello che avveniva a Genova in quei giorni, mentre quello che è accaduto dentro la Diaz quella notte e dentro la caserma di Bolzaneto nei due o tre giorni dopo appartiene al baratro che abbiamo fatto fatica a individuare come il nocciolo della questione.
Ti riferisci a noi italiani o anche al movimento e alle vittime?
Per motivi anche etico-politici, le vittime hanno posto in secondo piano questo aspetto sostenendo di essere stati massacrati perché avevano ragione politicamente. Ma se questo fosse vero vorrebbe dire che nell’azione di queste centinaia di poliziotti c’era una ratio, e non credo ci fosse una ratio se non quella di interpretare l’intento liquidatorio di un problema, qualunque esso sia, che si era presentato in un determinato momento storico. Non è stato un atto specificatamente contro quelle persone lì, ma contro una certa idea di democrazia partecipata e contro il desiderio dei cittadini di partecipare alla distribuzione di diritti e doveri di una società. Quindi, qualcosa di ancora più grande.
«Questo è il primo movimento di massa della storia che non sta chiedendo niente per se stesso». Del resto, è a queste parole che hai affidato l’incipit del tuo film.
Sì, perché quel movimento non faceva una lotta per il potere, era un movimento diseguale e frastagliato, anche pieno di contraddizioni, ma che non chiedeva nulla per sé. Non pretendeva di andare al governo o di partecipare alle elezioni, poneva problemi sul fatto che le merci siano libere di muoversi e gli uomini no. Lo chiamerei movimento “umanistico”. E se un movimento di questo tipo viene schiacciato nel sangue vuol dire che la logica adottata a Genova è intrinseca a uno Stato che non è completamente uno Stato di diritto, e che avrebbe potuto manifestare quell’attitudine autoritaria anche in altri contesti. Cosa che poi effettivamente avviene tutti i giorni all’interno delle caserme o degli ospedali psichiatrici, certo non sotto gli occhi delle telecamere. La nostra è una democrazia incompiuta. E quando dico la nostra non intendo solo italiana, ma europea. La sospensione dei diritti civili all’interno dei Paesi democratici è avvenuta con il benestare di tutti i capi di Stato, quantomeno europei.
E sulla pelle di manifestanti di ogni parte del mondo.
Quando sono andato a Seattle a presentare il mio film era presente in sala il padre di una ragazza americana. Aveva da poco ingaggiato una grossa polemica con un giornalista che recensendo il mio film aveva scritto che i fatti riportati non erano veri e lui era anche intervenuto sul giornale per replicare. Venne alla presentazione di Diaz per raccontare che sua figlia era lì e che le erano state massacrate le mani, che fino ad allora quella splendida ragazza era una grafica e una musicista, e che non ha più potuto esercitare nessuna delle sue due passioni a causa delle torture ricevute dentro la Diaz. Vedi? Per questo penso che nel caso Regeni noi italiani possiamo manifestare fino a un certo punto la nostra disapprovazione nei confronti dello Stato egiziano per aver praticato la tortura. Noi siamo uno degli Stati del mondo che non ha ancora introdotto il reato di tortura.
Insomma, siamo un Paese incoerente, e ipocrita. E le piazza si sono svuotate. Genova rappresenta anche la fine del movimento No Global, la sua sconfitta?
Si è sconfitti finché non si riconosce fino a che punto si è stati vittime. Se si finge di non essere stati torturati, si rifiuta questo fatto non solo psicologicamente ma anche politicamente. Le ragioni del movimento No Global non potevano bastare a giustificare quella reazione, quel movimento non esprimeva nessun tipo di conflittualità militare. Sì, è vero che una parte di questo movimento – quelli che sono stati definiti Black bloc – la praticava, ma era indubbiamente una parte minoritaria. Eppure quella minoranza è servita a dare il via da parte delle forze dell’ordine alla repressione generalizzata.
Da anni ripeti che «è necessario guardare in faccia l’inguardabile». Qualcuno lo ha fatto?
Una resistenza civile è stata messa in campo. La cosa più importante accaduta durante i processi non è tanto che alcuni magistrati, ai quali dobbiamo senz’altro dire grazie, hanno istruito dei processi. Ma che siano venuti a testimoniare da tutta Europa degli anarchici, nonostante non credano nelle istituzioni borghesi e quindi nello Stato così come lo conosciamo noi oggi. Eppure, nonostante questo, hanno testimoniato la propria sofferenza inflitta atrocemente da organi pubblici: io testimonio sul mio corpo i segni di questa attitudine a essere non-democratico. Segni che dopo anni hanno ancora addosso, all’interno dei tessuti del proprio corpo: i polmoni sfondati, i testicoli schiacciati. Scusa se parlo di queste cose, ma è di questo che stiamo parlando… e perciò bisogna ringraziare questi anarchici, perché hanno superato la vergogna di essere vittime e di essere stati umiliati. E così facendo hanno fatto un regalo alla civiltà di diritto alla quale nemmeno credono. Mentre molti poliziotti hanno mentito durante il processo.
E per questo sono stati puniti: il capo della polizia ha comminato una sanzione di 47 euro e 57 centesimi, l’equivalente di una giornata di retribuzione…
Non è questo che rimprovero al capo della polizia, ma di non aver smentito il comunicato stampa che i dirigenti nazionali della polizia hanno diramato quella notte, secondo cui dentro la Diaz c’erano solo Black bloc e persone con ferite pregresse. Durante il processo si è dimostrato che era falso, ma la verità giudiziaria non è sufficiente, per sanare la ferità tra lo Stato e i cittadini è necessario che quel comunicato venga smentito, che venga ammesso che era diffamatorio nei confronti delle vittime. Solo allora crederò nelle loro parole.
A proposito di credere nelle parole altrui, il tuo film ha fatto informazione su fatti che rischiavano di essere raccontati – da dietro le scrivanie dei giornali – solo attraverso comunicati come quello…
Pensa che quando Mark Covell (giornalista inglese, ndr) è tornato in Inghilterra sua madre aveva letto sui giornali che era un terrorista e che aveva preso le botte per questo. Ancora oggi chi era dentro la Diaz è visto come un “terrorista”. Perciò quel comunicato è grave, quanto le torture, perché resta sulla testa di queste persone per tutta la vita.
Come lo rifaresti oggi Diaz?
Mi è sempre più chiaro che abbiamo indovinato il nocciolo della questione, perciò oggi lo farei più asciutto, ma non so dirti cosa toglierei perché non l’ho più rivisto. Questo film mi è costato non poco dal punto di vita umano e professionale, è stato un film problematico per me. Ma resto convinto di un’idea di cinema che non accetta alcuna mediazione se non quella che il film sia il più efficace possibile.
Da quattro anni viene proiettato in scuole, piazze e centri sociali. Ha cambiato la visione a molti, Diaz. Ha cambiato anche te?
Non il film, Genova mi ha cambiato. Ero molto meno disilluso prima, dopo Genova faccio fatica a credere nella politica, ad andare a votare. E questo “stato di eccezione” coinvolge anche chi in Italia è solo di passaggio, viene dall’Africa ed è diretto al Nord Europa. Penso alle persone che vivono sull’asfalto in Via Cupa, a Roma. È questa mancanza di vicinanza con i cittadini tutti, italiani e stranieri, mette in crisi la civiltà in cui noi dovremmo credere. Anche la cittadinanza, con uno Stato così, diventa subito oppositivo, perché uno Stato che non comprende i conflitti e manda avanti la polizia, non è uno Stato democratico. Da almeno 25 anni viene delegata alla polizia la risoluzione dei conflitti, i partiti politici se ne lavano le mani, ed ecco che gli organi dello Stato suppliscono e, a quel punto, rivendicano un primato, se non una supremazia. Persino dinanzi alla democrazia.
A cosa ti aggrappi per resistere alla disillusione?
Resto in via Cupa: al Baobab centinaia di persone si occupano tutti i giorni di alleviare le sofferenze di altre persone. È questo per me il riferimento, sono loro.