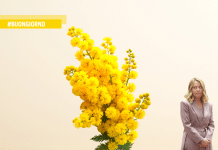Li incontriamo ogni giorno, eppure non riusciamo a guardarli negli occhi. Ci spaventa più di tutto l’impaccio, e la vergogna, per averli costretti a stendere sotto i nostri piedi tappeti puliti dalle foglie imbrunite. Vengono per lo più dall’Africa, ma hanno troppa dignità per chiedere l’elemosina. E così puliscono le strade, senza diritti, senza orari, ma loro ogni mattina su quelle strade si presentano puntuali. Stiamo parlando dei migranti, gli stessi che avrebbero dovuto rubarci il lavoro, come minacciavano alcuni, e invece spesso finiscono per pulire le strade. Di loro sappiamo ben poco, eppure li incontriamo ogni giorno. Per questo abbiamo deciso di intervistare Sara Forcella, arabista mediatrice culturale, da molti anni è impegnata con l’accoglienza.
Quanto ne sappiamo di questo “lavoro” nel quale vediamo sempre più spesso coinvolti i ragazzi africani? Loro sostengono di svolgere spontanemente questo servizio, che non ci siano altre persone che gestiscono quella che sembra una vera e propria rete. È realmente così? E quanta libertà hanno effettivamente nello scegliere questo lavoro a un altro, quali le possibilità lavorative che la città offre loro?
I pulitori di marciapiedi sono comparsi per la prima volta nelle strade di Roma la scorsa primavera. Da quel che sappiamo è un’iniziativa nata spontaneamente. Qualcuno ha sollevato il dubbio che si trattasse di una nuova forma di racket per sfruttare ancora una volta i migranti, ma finora non c’è stato riscontro. Sembra piuttosto un’iniziativa felice che ha naturalmente preso piede, diffondendosi nella capitale e non solo. Di fatto, le opportunità lavorative per i migranti in attesa di documenti – ma anche per quelli che hanno ottenuto un permesso – non sono molte nella capitale.
Un insieme di fattori concorrono a rendere la ricerca del lavoro difficilissima. Ci sono la lenta burocrazia che accompagna la domanda d’asilo e l’accoglienza emergenziale carente in fatto di misure quantitativamente e qualitativamente efficaci per l’inserimento lavorativo dei migranti sul territorio; le difficoltà linguistiche spesso dovute a situazioni di analfabetismo e alla frequenza insufficiente, tardiva e poco motivata ai corsi di italiano. Manca un adeguato meccanismo di riconoscimento delle esperienze dei migranti nei propri Paesi d’origine laddove (e spessissimo) sprovvisti di certificazioni. E, non ultimo, c’è il contesto lavorativo romano ostico, respingente, che funziona a “conoscenze”, e il fatto che i mestieri solitamente “scelti” dai migranti spesso sono svolti “a nero”. Tutto ciò spinge i ragazzi a cercare altre strade. Tanti partono, altri non possono o non vogliono. Chiedere l’elemosina, però, non piace a nessuno, sembra portarti via anche l’ultima briciola di dignità che a fatica sei riuscito a salvare. E allora inventarsi “un servizio”, anche minimo, è mantenere la propria identità. È conservare il diritto-speranza, ad una vita dignitosa e onesta. È, anche, una forma di rispetto verso il Paese che li ha accolti, accompagnata da una profonda richiesta di fiducia nei confronti dell’altro.
Sul cartello appoggiato vicino a una ciotola dove i passanti lasciano la loro offerta, uno di questi ragazzi aveva scritto: «Gentili signori, voglio integrarmi onestamente nella vostrà città, senza dare fastidi». Quello stesso ragazzo, dopo aver chiacchierato con lui qualche minuto, prima che andassi via mi ha chiesto se potevamo rivederci, anche solo una volta, anche solo per scambiare due chiacchiere e basta. Quanto è difficile per questi ragazzi integrarsi in una città come Roma, come vivono non solo l’impatto economico e lavorativo, ma soprattutto quello sociale ed emotivo?
Il discorso viaggia su due binari. C’è il primo piano dei bisogni materiali, che per i migranti è questione di sopravvivenza. Non è un caso che i pulitori di marciapiedi compaiono quasi in contemporanea al decreto Minniti sui “lavori socialmente utili”, non pagati. Già la confusione nel chiamare lavoro qualcosa di non retribuito, la dice lunga. L’inganno è sottile: invece di ripensare l’accoglienza, di lavorare a misure reali di scolarizzazione, formazione e lavoro che la rendano effettivamente emancipante, come indicato nel Manuale operativo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), si propinano soluzioni che tutto fanno tranne che supportare le persone perché diventino economicamente indipendenti. Per i ragazzi, è una frustrazione continua. E le conseguenze sono che solo chi ha le risorse interne è capace di resistere, venirne fuori indenne. Per chi, invece, è in difficoltà, con storie difficili alle spalle come spesso e volentieri accade, rimane una condanna alla subalternità che pesa come un macigno. A ciò si aggiunge l’incertezza dell’ottenimento di un permesso, la vita piatta e isolata all’interno dei centri, un contesto sociale vissuto come lontano, a volte pauroso, respingente. È carente l’interesse per quanto di intimo e personalissimo c’è nell’essere umano, i suoi affetti, i rapporti significativi, l’interazione con gli altri, che rappresentano la base su cui fondare la rete di relazioni che sosterrà il cambiamento di vita in corso. Così come quell’insieme di cose “inutili” che fanno però l’esistenza di ognuno, le passioni, gli interessi, la curiosità che ci rende vivi nel rapporto con il mondo esterno. Sono le esigenze di cui ci ha parlato lo psichiatra Massimo Fagioli. Alimentare le esigenze restituisce quella speranza che la situazione materiale oggettiva, la condizione economica, momentaneamente non garantisce.
Oggi sei impegnata in un’iniziativa bellissima, che porti avanti da sola, con le tue forze, un progetto del quale hai parlato l’anno passato presso l’Università di Parma. Ti andrebbe di parlarcene brevemente e di spiegarci quanto sia importante dare loro una risposta diversa alla loro richiesta d’asilo?
Si tratta in realtà di una sperimentazione, attuata finora con piccoli gruppi, ma con l’obiettivo di vederla crescere all’interno dei centri di accoglienza. L’idea è quella di restituire ai migranti un’immagine completa, reale e viva dell’ambiente in cui si trovano, che vada oltre i pochi luoghi che solitamente, per necessità, conoscono. Ciò avviene attraverso attività culturali, cinema, teatro, mostre e concerti, scelte per l’intelligenza e la bellezza dei contenuti, capaci di raccontare una storia di tutti, nata da questa parte del mondo ma che attraverso l’arte e il suo linguaggio universale arriva ad ognuno. Questo vuol dire conoscere davvero il territorio: mostrare una società fatta di persone, con le loro storie e con ciò che esse hanno realizzato, con il loro modo di impiegare il tempo. Si può scoprire così qualcosa che piace, in cui forse ci si riconosce, che risuona dentro perché parte anche del proprio bagaglio culturale. Una corrispondenza che permette lo scambio. La dialettica è possibile.