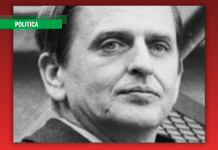Pochi giorni fa, il 16 gennaio, Oliver Ivanovic è stato ucciso in Kosovo. È accaduto poco lontano dal monastero di Mitrovica, la città divisa in due da un ponte: da una parte vive la minoranza serba, dall’altra quella kosovara. Ivanovic aveva 64 anni e tre figli, quando gli hanno sparato sei pallottole in petto, per strada, dove si è accasciato per sempre, a pochi passi dalla sede del partito di cui era a capo. Era il leader dei serbi che vivono ancora nella regione dalla fine della guerra, a capo della minoranza di una manciata di uomini, donne e bambini che si rifiutano di abbandonare le loro case, le loro fattorie nonostante vivano nelle enclavi video sorvegliate, in condizioni precarie, in città e paesini dove spesso manca acqua e luce.
Ivanovic, dopo i colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti da un’auto che è sfrecciata via, è stato portato in ospedale, ma era ormai impossibile salvarlo. Sulla sua tomba di marmo ci sarà per sempre la data del 16 gennaio, proprio il giorno in cui Belgrado e Pristina, le capitali nemiche, avevano cominciato i negoziati per la normalizzazione dei loro rapporti a Bruxelles e che si sono subito interrotti.
I contatti tra Serbia e Kosovo comunque non esistevano già da più di un anno. Ora che la bara di Ivanovic è stata accompagnata da una folla commossa, poi seppellita nel cimitero della capitale slava, nella nebbia invernale dei Balcani diventa chiaro che questo omicidio metterà in pericolo gli accordi raggiunti dopo le trattative con l’Unione Europea e, ancora peggio, l’intera stabilità dei Balcani. Per questo, appena appresa la notizia dell’omicidio, Marko Djurich, – politico serbo, membro del Consiglio di Sicurezza per la riconciliazione-, a Bruxelles ha deciso di allontanarsi dal tavolo dei negoziati e ritirare l’intera delegazione slava dai colloqui con i kosovari. Sono tutti tornati a Belgrado, mentre a Pristina si preparano comunque a festeggiare a febbraio l’anniversario per i dieci anni di indipendenza del loro Stato, un’autonomia post bellica non riconosciuta ancora da Russia, Serbia, Spagna, Romania, Cina.
Dopo la morte di Ivanovic e l’interruzione del dialogo, Oana Lungescu, portavoce Nato, ha detto che è urgente che Pristina e Belgrado tornino ai colloqui per normalizzare le relazioni: «il dialogo deve continuare il prima possibile, è un punto critico per la pace regionale e la sicurezza, tutte le parti in causa devono collaborare per garantire pace e sicurezza». Ma dopo questo omicidio nulla tornerà uguale.
Ivanovic si batteva per un pragmatico miglioramento che regolarizzasse i rapporti tra i due Stati ancora in guerra silenziosa. Una corte kosovara lo aveva condannato per crimini di guerra e l’omicidio di quattro kosovari albanesi nel 1999, ma, dopo nove anni di prigione, il verdetto poi era stato annullato e l’anno scorso era tornato libero. Ivanovic era un moderato, che manteneva aperto il dialogo con la Nato e gli ufficiali europei, nonostante la maggioranza dei leader serbi non l’abbia fatto dopo i bombardamenti americani del 1999. Lui stesso, prima di morire, aveva ammesso che per questo atteggiamento politico si era assicurato abbastanza nemici da una parte e dall’altra, tra i nazionalisti serbi, per i quali non era abbastanza ortodosso, e tra gli albanesi kosovari, per le sue politiche moderate.
A chi darà informazioni sui suoi assassini la polizia kosovara ha promesso 10mila euro di ricompensa. Questa morte è «un attacco agli sforzi per ristabilire la legge in tutto il territorio del Kosovo» hanno detto a Pristina. «Atto terroristico» continuano a dire a Belgrado. La sfida che ora deve sostenere il presidente serbo Aleksandar Vucic è diventata ancora più grande.
Dopo aver convocato una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza serbo per la morte di Ivanovic, il presidente ha deciso di visitare la città divisa, Mitrovica, nel territorio di uno stato la cui indipendenza non è mai stata riconosciuta da quello di cui lui è a capo. «La Serbia compirà i passi necessari per trovare gli assassini» ha detto Vucic. Quest’assassinio è una minaccia non solo per il nord del Kosovo, ma per l’intera regione balcanica, ha commentato il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic.
Alla minoranza che vive nelle enclavi in terra ormai musulmana, Vucic ha sempre tentato di presentarsi come un salvatore, un protettore, per rafforzare la sua immagine e il suo potere agli occhi dei nazionalisti in patria. «Ecco perché è andato lì immediatamente dopo quella morte» ha detto l’esperto Dragan Popovic del Policy Institute. Quando il presidente è arrivato nella città divisa dal ponte, la folla era scettica, ma continuava ad urlare: «aiutaci, aiutaci tutti, siamo un bersaglio, abbiamo una colpa, siamo serbi». Uno ha chiesto: «può garantire la nostra sicurezza nella nostra stessa terra?». E Vucic alla fine ha risposto di sì: «i serbi devono rimanere e sopravvivere nelle loro case in Kosovo, non possiamo permettere che i numeri diminuiscano nella terra che abitiamo sin dai tempi antichi». Ma questa è forse l’unica promessa che il presidente non può mantenere, perché è proprio il Kosovo che bisogna cedere alla soglia d’ingresso d’Europa.
Il 2025 è l’anno in cui la Serbia, si prevede, entrerà a far parte dell’Unione Europea, insieme al Montenegro. È una decisione che verrà annunciata a breve, dopo il 6 febbraio, parte di una nuova strategia che porterà dentro la mappa della Nuova Europa gli ultimi Paesi dell’Est rimasti fuori dal blocco. Ma per entrare a far parte della nuova famiglia europea, la Serbia «ha bisogno di normalizzare le sue relazioni col Kosovo, per fare progressi nel percorso di integrazione europeo». Il dialogo tra Pristina e Belgrado è cominciato nel 2011 sotto l’egida della bandiera blu con le stelle dorate in Belgio. Ora è di nuovo interrotto, bagnato di un nuovo sangue in quei Balcani dove la guerra è finita, ma la pace non è arrivata ancora.