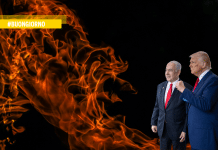Non c’è alcun dubbio: che piaccia o no, è il rap a detenere lo scettro dell’egemonia culturale musicale tra ragazze e ragazzi che frequentano le scuole italiane, i cosiddetti Millennials e la successiva Generazione Z, dei nati dopo il 2000. Il genere – che sta vivendo un nuovo boom, dopo l’exploit degli anni 90 – maneggia le parole più comuni tra i giovani, quelle da loro avvertite come più proprie, e che meglio risuonano con l’immaginario 2.0, destreggiandosi spesso sull’esile crinale che separa lo spirito di ribellione dall’individualismo menefreghista più spinto.
Proprio la ribellione allo status quo, infatti, è stata la matrice di buona parte della cultura hip hop delle origini, quella dei sobborghi afroamericani e ispanici di New York. «Il rap è la Cnn del ghetto» diceva Chuck D, celebre leader dei Public Enemy, in lotta aperta col mainstream mediatico. Quell’ambiente che, viceversa, viene blandito, in modo più o meno spudorato, da chi ha fiutato il business, e verga rime fatte di nichilismo a buon mercato. Consumiste e becere nel migliore dei casi, misogine e razziste nel peggiore. Ma c’è di più. Persino l’estrema destra, da sempre campionessa indiscussa nell’appropriarsi di culture altrui cambiandole di segno (o meglio, nel provarci, con risultati quasi sempre imbarazzanti) ha iniziato a interessarsi e praticare il rap. Lo chiamano “rap identitario”, parla di difesa del sacro suolo patrio, impero romano, sol invictus, lame verso chi non rispetta i “veri valori”, eccetera. Ma come si è potuti arrivare a questo? E come reagire?
«Semplicemente: non bisogna dare nessuno spazio e nessun tipo di agibilità ai fascisti». Kento, rapper reggino che ama flirtare col blues, da sempre attivista impegnato e scrittore – in libreria con Resistenza Rap (Round Robin Editrice) – non usa mezzi termini.
«I video di certi “nazi rapper” non vanno condivisi, non solo perché sono scarsissimi e hanno un messaggio aberrante, ma anche perché non bisogna concedere loro la dignità di nominarli o di dargli visualizzazioni online. I neofascisti hanno cominciato rivendicando – in modo ridicolo – Rino Gaetano e perfino Che Guevara. Da lì a organizzare delle pseudoserate rap, il passo è breve. Mi chiedo se si siano resi conto delle loro azioni, i politici e i giornalisti che sono andati ospiti a parlare nelle loro sedi, legittimandole».
Già, lo sdoganamento di questa cultura criminale è merito anche della stampa, come abbiamo denunciato più volte nelle nostre pagine. Ma il rap potrebbe mettere un argine all’intolleranza.
«Il rap è il rock dei nostri anni, quindi può fare moltissimo, ma dobbiamo essere più esigenti, sia noi musicisti che gli ascoltatori – spiega Kento -. La scena rap deve prendere coscienza di sé e diventare un movimento, abbandonando l’individualismo, se vuole costruire qualcosa di importante». E sulle origini, sulle radici, prosegue: «Il rap è un “contenitore neutro”, si, ma fino a un certo punto. Perché la verità storica innegabile è che nasce nelle periferie povere e meticce della Grande mela, e quindi dovrebbe rifiutare razzismo e intolleranza già nel suo Dna».
In questa direzione, nella ripresa cioè di queste radici riot, nell’accezione migliore del termine, qualcosa tra i rapper emergenti si sta muovendo.
«Ho grande fiducia nei giovani colleghi – ci confida il rapper di Reggio Calabria – che crescono e maturano con rapidità mostruosa e che giustamente si stanno prendendo lo spazio che meritano. Spazi la cui disponibilità è variabile e non sempre legata a logiche limpide e disinteressate. Ma gli spazi, fisici e metaforici, bisogna prenderseli. E questa è da sempre una prerogativa dell’hip hop: creare arte, opportunità e cultura in luoghi nuovi, dove spesso magari non si percepiva che degrado e povertà».
E per fare in modo che sempre più giovani abbiano questa chance, Kento parte dalle scuole, nelle queli tiene laboratori rap coi bambini. «I progetti vanno alla grande, i ragazzi sono straordinari, ma l’impressione che ho della scuola italiana è un po’ frammentaria: molto spesso ci si deve affidare quasi esclusivamente alla buona volontà e al cuore degli insegnanti, gli stessi che stanno subendo un attacco senza precedenti da parte degli ultimi governi, che hanno sminuito la loro professionalità e il loro ruolo. Ad ogni laboratorio che faccio, tocco con mano queste difficoltà ed aumenta la mia stima (con qualche eccezione, ovvio) nei confronti della loro categoria».
Muruburu – Alessio Mariani nella vita reale -, “cantautorapper” che unisce le sue passioni, narrativa e rap, riuscendo magistralmente a mettere in rima miti e personaggi della letteratura e dell’epica moderna, questa categoria la conosce bene: è lui stesso professore al Liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia. «Insegno storia e filosofia e, anche per far fronte a questa ondata di intolleranza, credo che i programmi di storia dovrebbero essere un po’ aggiornati. Ma è vero, molto possono fare gli insegnanti, e coloro che vogliono possono spingersi un po’ più avanti. Io l’anno scorso in quinta sono riuscito ad arrivare fino a Berlusconi», ci racconta. E il rap, nei confronti della scuola, può divenire il miglior alleato. «È il genere più fruito dagli adolescenti – prosegue Murubutu – e proprio per questo ha delle responsabilità morali: deve propagandare dei modelli educativi corretti, di tolleranza, di equilibrio e di convivenza pacifica nelle nostre società e nelle nostre periferie, che sono sempre più multietniche. Il fatto stesso che il rap spopoli proprio in questi luoghi meticci, in un certo senso, mi rassicura: è un baluardo concreto contro le sbandate razziste della cultura hip hop».
Per far passare il suo messaggio, il professor Mariani – di cui è da poco uscito il mixtape La penna e il grammofono – ha lavorato molto sulla sua poetica. «Io vengo dal rap antagonista, di protesta, quello nato nei centri sociali, luoghi a me cari, che tuttora frequento e conosco anche grazie ai miei tour. Ma quel tipo di rap, a mio avviso, è limitato dalla retorica “sloganistica” che talvolta lo caratterizza, che rischia di danneggiare il messaggio positivo che vuole portare. La “sloganistica” penso sia una restrizione del pensiero. Io ho fatto in passsato questo tipo di rap e quindi la mia è anche un’autocritica».
Ad attendere con ansia un rinnovamento del linguaggio del rap inteso come musica di denuncia sociale c’è anche Emiliano Rubbi, produttore discografico (tra gli altri, del rapper Piotta), sceneggiatore della allegoria horror Go Home, profondo conoscitore del panorama musicale italiano e non: «Mi aspettavo che con l’elezione di Trump, dagli Stati Uniti sarebbe arrivata una nuova ondata di musica di protesta – spiega Rubbi – perché storicamente funziona così: le tendenze musicali Usa dopo un po’ si ripercuotono a cascata anche da noi. Ora, oltre oceano qualche novità c’è stata, rimanendo in ambito black, penso ad esempio ai testi di Kendrick Lamar. E persino Eminem, non certo noto per fare rap conscious, si è lanciato contro il presidente. Ma da noi ancora nulla: mentre sono all’opera molti rapper virtuosi, per il momento il mainstream continua a scimmiottare il rap gangsta, che non ha nulla di sociale. È un egotrip autoriferito, per così dire, tutto polarizzato sul personaggio che lo fa, che può colpire alcuni giovani, ma dietro non c’è niente di più».
Il problema, forse, è più profondo di quanto possa sembrare. Mancano ancora le parole, per una nuova vera era di rap “battagliero”, che torni a prendersi a cuore il destino delle minoranze.
«Passata la cosiddetta “prima scuola”, quella degli anni 90, delle Posse, il rap italiano ha continuato ad avere alcuni rapper conscious mainstream, penso a Caparezza, ma sono lontani i tempi in cui i 99 Posse andavano in classifica – prosegue il produttore discografico -. E, se scarseggia in generale la musica di protesta, è anche perché il vocabolario tradizionale della sinistra viene considerato dai giovanissimi, principali consumatori del rap, come vecchio, noioso, difficile, respingente, che sa di muffa. La sinistra di oggi è post ideologica, ha rifiutato un certo tipo di ideali, ed è finita con lo scomparire per decenni. Per questo quelle parole d’ordine sono divenute incomprensibili. E poi i ragazzi oggi pensano la politica come una cosa per vecchi, chiusa nei palazzi, inutile: per questo, in un mondo molto modaiolo come quello del rap di oggi, è difficile trovare parole “altre”, sperimentare». Kento e Murubutu, intanto, sono un esempio. E i semi della loro poetica sono sparsi tra i giovani. Qualcosa, prima o poi, dovrà nascere.