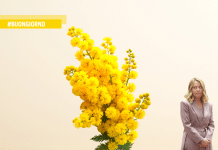I festival del cinema, ora sospesi a causa della pandemia, spesso hanno veicolato notizie e messaggi su guerre lontane dai nostri occhi e di cui solo pochissime testate si occupano.
Ricordo che al festival Middleast now del 2017, dopo la proiezione di The last men in Aleppo – un capolavoro, con incredibili personaggi e belle immagini – il regista siriano Feras Fayyad si rivolse al mondo chiedendo aiuto per la Siria. Disse che i giornalisti potevano aiutarlo scrivendo del suo film e del messaggio di fortissima lotta intrapresa quotidianamente dai cittadini per non soccombere.
Louis Sayad De Caprio, americano di origine italo-siriana, regista insieme con Khawla Al Hammouri e direttore della fotografia di Una donna siriana, documentario già presentato al St. Louis International Film Festival e al Big Sky Documentary Film Festival, per non bloccarne l’ulteriore circolazione, ha incaricato un ufficio stampa londinese di farlo conoscere fra i media. Proprio per il contenuto e il messaggio che propone.
Il film infatti ricorda che la guerra in Siria continua, attraverso le voci e i volti di donne che hanno avuto il coraggio di trasferirsi in Giordania e di allontanarsi da quella terra dilaniata da 9 anni di conflitti e retta da un regime che da quasi mezzo secolo la tiene in pugno.
De Caprio è un giramondo alla ricerca di storie sulla resistenza umana di fronte a traumi, morti ed esodi forzati, da filmare e condividere. Tenere questo film nel cassetto, equivale a spegnere la voce che, circolando, tiene desto il movimento internazionale che cerca (con pochi risultati) di fermare la sciagura che si svolge in Siria da troppi anni, rendendola un Paese inabitabile.
Questo breve documentario, frutto di una lunga ricerca, con il titolo al singolare, ma con molte donne filmate, ci parla della donna simbolo di coraggio, determinazione, riscatto.
E sono diversi i racconti sui modi di vivere la separazione dalla Siria, un viaggio verso l’ignoto reso necessario per dare un futuro ai figli, lasciando un Paese dilaniato da guerre che non risparmiano i civili.
C’è chi è straziata per avere lasciato la casa, costruita con grande cura, e che non riesce a pensare ai profumi dei fiori del giardino senza piangere; chi è in ansia per i pericoli che, nel territorio giordano, corrono le figlie adolescenti senza la protezione di un uomo. Chi, sposa bambina, ha avuto la forza di lasciare il marito portandosi dietro una figlia, vincendo la disapprovazione sociale. Ed ha trovato, grazie ad un’amica la voglia di tornare a scuola e vuole approfondire le scienze, mentre la sua amica vuole diventare astronoma.
Fin qui le donne che parlano sono filmate in penombra, ad indicare la loro difficoltà ad aprirsi.
Dopo compare Amal, di 27 anni, in piena luce, in un primo piano deciso, scandendo con dolcezza il suo nome. È l’unica del documentario che ha scelto di venire a lavorare in Giordania per la Jordan River Foundation. Aiuta i bimbi siriani espatriati. Con orgoglio dice che, attraverso i disegni, ha visto che il ritrovarsi a scuola, luogo di incontro fisico, di giochi, di parole, cui i piccoli avevano dovuto rinunciare in Siria, piano piano li guarisce dai ricordi terrorizzanti della prima infanzia.
Dopo Amal le donne filmate sono immagini veloci commentate dalla voce fuori campo che le unifica in una storia corale di coraggio. Queste donne profughe sono riuscite a salvare una generazione di bambini nati durante la guerra e a dare loro l’istruzione che trasmette la speranza in un futuro possibile. Salta all’occhio l’importanza della scuola in questi contesti, come ha raccontato nel n. 17 di Left Lorenzo Fargnoli, a proposito degli “invisibili di Samos”.
Da dove viene la forza d’animo di queste donne, la loro voglia di vivere, la speranza che non le abbandona? La Siria è stata per secoli una terra di grande cultura, arte e scienza, famosa per la tolleranza nei confronti di etnie e professioni religiose diverse. Un background che, se non le difende dalle armi, le rende capaci di superare la violenza psicologica di chi le vorrebbe mortificate e passive.