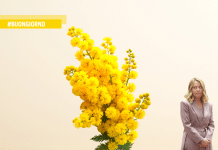In questi momenti sono estremamente drammatiche le notizie che ci arrivano dall’Afghanistan: l’attentato kamikaze, all’aeroporto di Kabul registra un numero altissimo e ancora imprecisato di vittime. Le esplosioni che sono seguite in città rendono ancora più dura e quasi impossibile la resistenza e la vita della popolazione civile in Afghanistan, a cui ora sono chiuse tutte le porte. I talebani rivali dell’Isis che hanno commesso l’attentato, e loro complici nel distruggere i diritti umani, non sono mai stati interlocutori accettabili, come invece proposto da Trump che con loro aveva fatto gli accordi di Doha. E di fronte a questa immane tragedia è evidente la totale disfatta di Biden, della Nato, che non ha saputo o voluto prevenire.
E’ una storia purtroppo che continua da molti anni. E’ sempre la stessa storia. I fondamentalisti religiosi colpiscono le donne, i bambini, di diritti umani, l’arte. E l’Occidente che schizofrenicamente voleva esportare la democrazia con mezzi violenti alla fine è diventato loro complice, perfino sacrificando ora come ha fatto l’amministrazione Biden le vite di soldati americani in ritirata.
«Fuori piove, senti il fragore della pioggia battente che si schianta contro la finestra, e si schianta anche la tua voglia di alzarti dal letto, di andare. Hai freddo, anche il sole ha freddo. L’alba indecisa come te, fatica a sorgere». Ci torna alla mente l’incipit potente de I portatori d’acqua (Einaudi) dello scrittore afgano Atiq Rahimi che nel 2019 rievocava la grande ferita, collettiva, della cancellazione di uno straordinario melting pot culturale, rimasto intatto per secoli e simboleggiato dai Buddha del Bamiyan; una ferita inferta lucidamente dai talebani che nel 2001 vollero colpire non solo sculture patrimonio dell’umanità, ma anche i valori che incarnavano, un meticciato, una compresenza laica e pacifica di culture che nel tempo si era sviluppata lungo la via della seta. Era una ferita che colpiva la più alta espressione umana, l’arte. E che colpiva insieme le persone in carne d’ossa come accade drammaticamente anche oggi.
L’iconoclastia, quella furia distruttiva verso le immagini che hanno un senso emotivo profondo e rappresentano valori umani universali è da sempre bersaglio dei fondamentalisti. Che non sopportano l’arte, l’immagine e la libertà delle donne, la bellezza di una identità umana profonda e irrazionale.
La storia ci ricorda che nel IV secolo i parabolani del vescovo Cirillo uccisero la filosofa e scienziata Ipazia perché osava insegnare, liberamente, per strada. Nell’VIII secolo gli iconoclasti cristiani a Bisanzio cavavano gli occhi a chi aveva in casa immagini di santi appena un poco incarnati. La ferocia dell’iconoclastia cristiana e di quella islamica non sono troppo diverse, come ben sappiamo. Uguale è la loro ferocia contro donne e bambini, negati, annullati oppure fisicamente aggrediti. La furia a cui stiamo assistendo parla chiaro: le donne afgane ricacciate in casa, costrette al burqua per uscire al sole, braccate, rastrellate di casa in casa per violentarle e sposarle a forza, non importa se sono poco più che bambine. Già nei mesi scorsi avevamo denunciato con Save the children che i talebani prendevano di mira le scuole (ricordiamo la strage di maggio in cui hanno perso la vita almeno 25 ragazze che volevano studiare, che sognavano un futuro diverso). Dove erano gli Occidentali e le truppe Nato?
Perché in vent’anni di occupazione nonostante i trilioni spesi dagli Usa e gli 8 miliardi e mezzo spesi da noi non siamo riusciti a metterle in sicurezza? E ora che i talebani hanno preso il potere ripristinando la sharia, come possiamo pensare di negoziare con dei tagliatori di teste che di sicuro si sono fatti più astuti sul piano diplomatico (anche grazie agli Usa che hanno fatto con loro gli accordi di Doha), ma di certo non hanno cambiato pelle. Lo dimostrano le violenze, le fustigazioni a cui sottopongono le donne ogni giorno.
Ne avevamo parlato su Left all’inizio di luglio lanciando un allarme sulla situazione che stava per precipitare. Ora torniamo idealmente in Afghanistan per continuare a dare voce alla società civile che si oppone ai fondamentalisti e al loro oscurantismo, per raccontare il dramma dei profughi e stare della parte delle donne, attraverso testimonianze dirette raccolte da Bianca Senatore. A lottare rischiando la vita sono in tante. Fra loro le attiviste di Rawa e di tante organizzazioni femminili nate nel Paese. Sono avvocatesse, docenti universitarie, artiste, registe, politiche come la ex parlamentare Malalai Joya che più volte è stata intervistata su Left (dal collega Stefano Galieni) ma che ora non riusciamo a raggiungere. Speriamo che sia ben nascosta, temiamo molto per la sua incolumità.
Sono loro le vere e coraggiose avanguardie in un Afghanistan, terra dai tesori d’arte millenari, ma che purtroppo conosce ancora tassi di analfabetismo altissimo. «Molte donne oggi nelle zone rurali non sanno nemmeno di avere dei diritti, questo è il punto più doloroso», ci ha detto un’attivista di una Ong, che per motivi di sicurezza deve restare anonima. «Nei villaggi il Mullah è l’unica figura di riferimento, viene ascoltato senza vaglio critico. Vige una rigida ideologia religiosa e patriarcale. Tante ragazze e donne anche per ignoranza, poiché non hanno mai conosciuto una realtà diversa, subiscono violenze con rassegnazione. Molte di quelle che siamo riusciti a raggiungere non sapevano neanche che fosse un loro diritto non essere picchiate».
Esperienze come quella di Pangea, del Cospe e di tante altre organizzazioni dal basso ci dicono tuttavia che le cose possono cambiare e in piccola parte stavano cambiando come ci racconta da Kabul il medico Gina Portella di Emergency ricordando che al loro ospedale nel Panshir le donne andavano per partorire ma anche per la pianificazione familiare. Che ne sarà ora di tutto questo? Cosa accadrà delle afgane quando si spegneranno i riflettori sull’emergenza che in questi giorni occupa le prime pagine di tv e giornali? Anche per questo abbiamo scelto di pubblicare come copertina una delle splendide immagini realizzate dalla street artist afgana Shamsia Hassani che a Kabul lotta per la liberazione delle donne rappresentandole senza bocca, ma vitali, fiere e appassionate, determinate a fare musica, a realizzarsi nell’arte e negli affetti, lottando per costruire un futuro di pace e di democrazia. «Voglio colorare i brutti ricordi di guerra – aveva detto qualche tempo fa Shamsia in una intervista -. Se coloro questi brutti ricordi, allora cancello la guerra dalla mente delle persone». E oltre: «Voglio rendere famoso l’Afghanistan per la sua arte e non per la sua guerra».
🆙 Bastano pochi click!
🔴 Clicca sull’immagine oppure segui questo link > https://left.it/abbonamenti
—> Se vuoi regalare un abbonamento digitale, vai sull’opzione da 117 euro e inserisci, oltre ai tuoi dati, nome, cognome e indirizzo mail del destinatario <—

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE