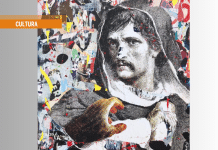Chissà come avrebbe reagito Lucio Fontana nel vedere la sua Fine di Dio esposta in una cappella, per quanto oggi faccia parte di un complesso universitario distaccato dell’Università Orientale di Napoli
Accade nella splendida isola di Procida (capitale della cultura 2022) dove dal 2 al 5 settembre si svolge la mostra di arte diffusa Panorama curata da Vincenzo de Bellis (direttore associato e curatore per le arti visive del Walker art center di Minneapolis).
Una provocazione? Piuttosto, oseremmo dire, una plastica dimostrazione della forza dirompente dell’arte di Fontana capace di risemantizzare e di umanizzare anche un contesto “sacro”.
La forza del colore, lo squillante verde mela di questa opera, tassello fondamentale della omonima serie del ’63-’64, la potenza di quest’immagine che evoca la nascita appaiono dirompenti sulle bianche pareti di Santa Maria Regina della Purità nel complesso dell’ex Conservatorio delle orfane a Terra Murata.
Questa installazione di Tornabuoni arte (che insieme alla rete di gallerie Italics ha promosso questa esposizione) ci ha spinto ad andare a curiosare nella storia critica di questo ciclo di opere che segnò la maturità di Lucio Fontana: nell’Italia democristiana di allora l’artista italo argentino osò un titolo che da molti fu giudicato blasfemo. Tanto che la galleria dell’Ariete le espose senza citarne alcuno. Ma cosa di questa creazione faceva scandalo? Guardiamola più da vicino. La cifra di questa, come di tutta la trentina di opere astratte che compongono l’intero ciclo, è la misura in scala umana: 1,78 di altezza. Ciascuna di esse si presenta con un’enigmatica forma ad uovo, rastremata verso l’alto. Nel contesto dell’abside non può non richiamare alla mente l’uovo carico di simbolismi della Sacra conversazione di Piero della Francesca conservata a Brera. Ma qui non c’è l’intonsa e ideale perfezione dell’uovo appeso sopra la testa della Vergine.
L’opera ovoidale di Fontana, ricoperta da un pastoso strato materico appare felicemente profanata da buchi che aprono a una dimensione spaziale sconosciuta. Altre varianti de La fine di Dio sfoggiano perfino lustrini «come il corpetto di una ballerina», come notò Cesare Brandi, cogliendo l’aspetto femminile e carnale dell’opera.
Insomma la storia della ricezione de La fine di Dio ci dice che il suo aspetto dissacrante e insieme introspettivo fu a lungo oggetto di equivoci e malintesi. Basti dire che la galleria Marlborough propose a Lucio Fontana di esporre la serie a dicembre con il titolo Uova di Natale. Cosa che l’artista cercò in ogni modo di scongiurare perché per lui non si trattava affatto di un gioco, di uno sberleffo, al contrario quelle opere erano una faccenda molto seria. A seconda di come venivano illuminate, avvertiva l’artista, potevano avere anche rivelare un aspetto tragico. Fontana stesso le descrisse come «aperte sull’infinito, come una sfida a rappresentare la cosa inconcepibile».
Uno strumento prezioso per comprendere più a fondo la genesi di questo lavoro è Lucio Fontana. Fine di Dio di Enrico Crispolti (edizioni Forma-Tornabuoni Art) anche per l’ampia antologia critica. Ma per continuare la nostra ricerca ci siamo rivolti anche al critico Bruno Corà che di Lucio Fontana ha curato storiche mostre come quella del 1996 che al Museo Pecci di Prato faceva “dialogare” Burri e Fontana (proprio in questi giorni Corà è al lavoro alla Fondazione Burri per una nuova mostra dedicata al maestro umbro ad Alba che aprirà il 7 e 8 ottobre). Professore qual era il senso più profondo di questa potente e misteriosa creazione di questo grande Maestro dell’astrattismo? «Quello che posso dire è che quest’opera ha una valenza talmente emblematica che suscita molte riflessioni. Come lei sa l’uovo è una simbologia da sempre evocata dalla pittura, dalla filosofia come dalla scienza. Nell’iconografia – ricostruisce Corà – è emblema della perfezione, dell’origine della vita, rimanda al soprannaturale ma è anche simbolo cosmico». Pur conoscendo bene questa lunga e sfaccettata tradizione, Lucio Fontana però la rilesse in modo originale. «Lui aveva fatto propria questa forma e inferto i suoi drammatici fendenti attraverso un punteruolo, decretando la fine di quell’integrità che per tanti secoli ha rappresentato l’elemento strutturale di questa immagine». Anche in questo senso, il suo, è stato un gesto epocale, sottolinea il critico e curatore: «Quello sfondamento della tela segnava l’apertura di uno spazio inedito. La superficie della tela come emblema, come supporto dell’arte insieme al muro, aveva sempre rappresentato un cardine per i pittori. In quel modo Fontana concludeva una parabola temporale grandissima e avviava una nuova epoca». Anche prendendo spunto dagli avanzamenti della scienza?«Sì – risponde Bruno Corà – potremmo dire che Fontana apre alla civiltà del cosmo, a uno spazio diverso; apre la civiltà dei viaggi dell’uomo fuori del suo pianeta. È stata una grandissima intuizione. Ha cominciato con quello che lui definisce come concetto spaziale, il buco (nel 1949) e poi dieci anni dopo usa addirittura il taglierino e il coltello per fendere la tela. Sono i cosiddetti tagli del 1959. Questa opera è del 1963 e segna un passo ulteriore nella sua ricerca ma anche il declino della sua vita. Fontana morì 5 anni dopo, nel 1968. Dunque è sicuramente un’opera cardine, importantissima, nella maturità di questo Maestro».
Un anno dopo ci sarebbe stato il primo allunaggio. L’essere umano che esplora dimensioni nuove, che non ha più paura di varcare le colonne di Ercole, avventurandosi nel cosmo. Alludeva anche a tutto questo La fine di Dio? Sappiamo che Fontana era anche appassionato di fisica. «Non a caso creò i Quanta. In arte dette vita a una sperimentazione legata alla quantistica, Fontana non ignorava le novità della scienza. Con La fine di Dio, ribadisco, Fontana voltò una pagina importante della storia dell’arte – rimarca Bruno Corà -. In questo senso è molto innovativo. Ma non dimentichiamo anche il riferimento a Nietzsche. Lui per primo aveva detto che “Dio è morto”. Anche per dire che era finita una grande parabola civile, storica e ne cominciava un’altra, anch’essa sotto un segnale crepuscolare della civiltà».
Fontana fu certamente un innovatore radicale, ma non un iconoclasta, mantenendo sempre un fortissimo legame con la storia dell’arte. «Era un profondo conoscitore della tradizione di cui decretava la morte per creare il nuovo », commenta Corà. Prova ne è proprio la citazione del capolavoro di Piero della Francesca: «Ne La fine di Dio è chiarissimo il richiamo all’uovo sospeso della Sacra conversazione di Piero. Ma al tempo stesso quell’opera segnò la definitiva fine dell’arte come riproduzione della percezione retinica». Un percorso che era cominciato già nel 1945 quando in Argentina Fontana aprì allo spazialismo con il Manifesto Blanco. «Già lì lui diceva della necessità che l’arte sia suono, sia colore, sia spazio sia tutt’altro che raffigurazione mimetica o banalmente riproduttiva di quel che si vede. Fontana – spiega il professore – si rifà alla tradizione dei grandi maestri, primo fra tutti Cennino Cennini che nel Trecento diceva “dipingere è mostrare ciò che non si vede”, ciò che non appare, ma che si pensa. Poi l’ha ripetuto anche Leonardo che l’arte è materia del pensiero, viene dal pensiero, dall’intuizione non è imitazione, Fontana sviluppò quel pensiero lì». Lo fece in rapporto con gli artisti del passato ma anche con quelli delle generazioni successive. «Non c’è stato giovane che abbia varcato la soglia dello studio di Fontana per mostrargli un lavoro che non ne sia uscito con un acquisto fatto dal maestro. Fontana – sottolinea Corà – era solito aiutare i giovani artisti, ne apprezzava la qualità e il valore ed è sempre stato generoso con loro, li ha sostenuti e incoraggiati. Castellani, Manzoni, Dadamaino, sono artisti usciti dalla sua covata». Proprio in un’intervista rilasciata a Bruno Corà e pubblicata nel catalogo della mostra Burri e Fontana (Skira, 1996) Enrico Castellani con riconoscenza ricordava la generosità di Fontana. «Ma, ricordiamo, anche se Castellani riconobbe il valore del maestro Fontana – commenta oggi Corà – persisteva fra loro una diversità. Sta anche nel fatto che mentre Fontana faceva sulla tela una lacerazione, produceva una rottura irreversibile per alludere allo spazio altro, ad una quarta dimensione, Castellani invece con sollecitazioni e tensioni produceva modulazioni, estroflessioni e introflessioni ma diceva, se io smettessi di esercitare queste forze la tela tornerebbe ad essere integra come prima, perché lui non la rompe, non la strappa, non la buca, non la taglia, ma sollecita le forze del telaio sul davanti, per produrre una modularità, una sensibilità di superficie che prima la superficie non aveva»

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE