Nel 1926, a Berlino, un ventisettenne Nabokov, dopo aver pubblicato un buon numero di racconti e raccolte poetiche, dà alle stampe Mašen’ka, il suo romanzo d’esordio. Dopo cinquant’anni esatti dalla prima traduzione italiana con titolo Maria, per i tipi di Mondadori, ripescato dal dimenticatoio dove era rimasto relegato a lungo, quel romanzo torna in libreria grazie alla nuova traduzione di Franca Pece, per Adelphi.
Il romanzo ha come scenario una modesta pensione di Berlino, scossa dal frequente sferragliare dei treni della vicina stazione; in essa alloggia un microcosmo formato da alcuni russi espatriati dalla madrepatria e a essa legati da una nostalgia più o meno confessata. Nella pensione, i ricordi della patria si aggirano come fantasmi sulle gambe degli alloggianti, brandelli di passato si sovrappongono a un presente altrimenti privo di movimento e significato. La nostalgia e l’attesa di qualche cosa di risolutivo sono le vere protagoniste: c’è chi attende il visto sul passaporto, buono a lasciare la Germania per Parigi, c’è chi attende l’occasione per manifestare i propri sentimenti, ci sono due artisti in attesa di un ingaggio, e c’è chi, in questa continua tensione fra il passato e il futuro, attende Mašen’ka, la donna che presta il proprio nome al romanzo, costantemente presente attraverso la sua assenza, oggetto di una attesa piena di trepidazione.
Quella Berlino, tappa intermedia per migranti della Russia bolscevica diretti altrove, in cui Ganin passeggia, è la medesima in cui passeggiava Nabokov, ed è la stessa città dalla luce sospesa e caliginosa che aveva già fatto da sfondo ad altri suoi racconti. Una sera, in un cinema, Ganin assiste a una proiezione in cui con somma sorpresa riconosce se stesso, impegnato nella parte di comparsa in una narrazione di cui lui, come tutti gli altri figuranti presi a vendere «la propria ombra», sapeva poco o nulla. Nell’inaspettato incontro del proprio Doppelgänger, Ganin ha una volta di più la percezione di Berlino come di uno scenario teatrale di illusioni su cui si stagliano vite spettrali e inquiete.
Così anche nella pensione in cui alloggia, microcosmo rispecchiante la grande città tedesca, i sette inquilini gli sembrano ombre in pena, e l’esistenza è «una ripresa cinematografica in cui delle comparse distratte ignorano tutto del film al quale partecipano».
Fino a che l’inquieta sospensione in cui tutta Berlino galleggia viene spezzata dall’annuncio dell’imminente arrivo della moglie di uno dei pensionanti, la cui foto, esibita con orgoglio dal marito, fa riaffiorare alla memoria del protagonista i più dolci ricordi della vita in Russia: lui conosce quella donna, con lei ha vissuto il sentimento d’amore più intenso e vero della sua vita, e ora quel volto appartenente al suo passato «giaceva nella scrivania di un altro». I giorni trascorsi a rincorrersi in campagna e a Pietroburgo prendono a proiettare, allora, la loro tinta rosea sul presente, intrecciandosi con la vita presente e ridonandole una parvenza di nuovo significato.
Attesa e nostalgia ora hanno un volto, la cui presenza assente ricuce l’intero panorama biografico di Ganin, attraendone i movimenti e le azioni come il punto di fuga di una nuova prospettiva. Con determinato cinismo, appartenente a quel mondo spettrale che è Berlino, mette fine alla relazione affettiva in corso, e poi si libera risolutamente di quella sua personalità apatica e scostante, per ridiventare il dolce ragazzo che era stato una decina di anni prima, nelle campagne russe.
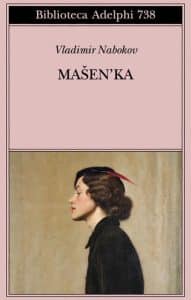
Mašen’ka ritroviamo frammenti tratti dalla biografia dello stesso Nabokov, adornati con l’arte dell’incanto, tratto che lo stesso Nabokov nelle sue lezioni americane elegge a precipuo per il narratore. Mašen’ka è un romanzo sospeso tra il ricordo nostalgico e l’amaro timore che il tempo dell’infanzia e della giovinezza sia per sempre «finito, spazzato via, distrutto». Mašen’ka è per Ganin il primo grande amore, quello che fu Tamara (nome fittizio per parlare di Valentina Šul’gin) per Nabokov: un amore inghiottito dai turbinii della Rivoluzione, che rendono difficile anche la sola corrispondenza, e «c’era qualcosa di commovente e di meraviglioso nel modo in cui le loro lettere riuscivano ad attraversare la terribile Russia di allora, come bianche farfalle cavolaie in volo sopra le trincee». I viali di Berlino attraversati da Ganin sono gli stessi attraversati da Nabokov; l’Oredež è un dolce ricordo per Ganin come per Nabokov. Un romanzo certo acerbo per stessa ammissione dell’autore, eppure così intimo da contenere estratti di realtà più veri e inebrianti di quanto non saranno le rigorose narrazioni contenute nell’autobiografia stilata decenni dopo da Nabokov.
In apertura, immagine di Walter Mori (Mondadori Publishers), public domain





