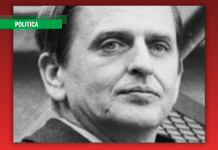Nelle ultime settimane la Romagna è stata colpita da quella che è stata registrata come l’alluvione più estesa d’Europa, ed ora a distanza di due settimane, le immagini dei primi giorni sono ancora fresche e vive e chiedono di essere raccontate.
Gli eventi di queste settimane sono stati estremi ed eccezionali, ma non improvvisi o inaspettati, e forse, oltre a spalare e ricostruire è necessario anche fermarsi a riflettere sul rapporto tra territorio, società, comunità, cultura, sulla cultura del territorio. Sono architetta e vivo in Romagna e da settimane si è avviata una riflessione per cercare di capire come siamo arrivati fino a qui e cosa possiamo imparare, non solo come romagnoli, da quello che è successo.
Ho passato tutta la giornata di martedì 16 maggio in casa, nelle campagne tra Forlì e Faenza, verso le prime colline, che definiscono il salto di quota dell’antica costa adriatica. Piove dalla notte precedente e sappiamo che pioverà per due giorni incessantemente, i fiumi sono pieni dalle piogge della settimana prima, il Lamone, il fiume che costeggia a sud Faenza aveva già rotto un argine ed alcune case erano già state alluvionate. Seguo senza sosta le notizie dell’allerta meteo sul telefono, sembrano i primi giorni di lockdown durante la pandemia. Alle due di pomeriggio nel gruppo whatsapp degli amici di Forlì, Clara manda un video di casa sua, nelle campagne di Forlimpopoli, in cui l’acqua riempie il giardino e comincia ad entrare in casa: un piccolo lago è esondato e ha allagato i terreni e le case attorno.
Sono uscita fuori per fare una passeggiatina, tutto mi soffoca la pioggia incessante, la casa, le immagini, mi sfreccia di fianco un camion della protezione civile di Trento. Allora dev’essere grave, penso.
La notte si prospetta insonne, con la pioggia che scroscia assordante nel buio fuori dalla finestra: le ultime notizie sono che tutti i fiumi delle mie città sono esondati, il Savio a Cesena, il Montone a Forlì, il Lamone a Faenza.
La luce è saltata, non so più niente, so solo che non posso fare nulla e non riesco nemmeno ad immaginare cosa stia succedendo a qualche chilometro.
Il giorno dopo mi sveglio per la luce plumbea che entra dalla finestra, mentre ancora piove. Niente internet, niente luce, nessuna notizia. Prendo la macchina per andare a Castrocaro, il paese più vicino, manca la luce anche lì ed è tutto chiuso. Al primo ponte, vengo colpita dal silenzio delle persone che guardano il fiume: “Arrivava fino l’altra parte della strada” mi ha detto un signore sotto l’ombrello di fianco a me. Dal castello, un po’ più in alto, non si vede più il fiume, ma una distesa d’acqua indeterminata.
Non si riconosce più il paesaggio. Con mio padre, fotografo, iniziamo a esplorare quei luoghi. Ho fotografato una collina che mi sembrava strana, senza alberi, con dei calanchi che non avevo mai visto, sembra un’immagine di un paesaggio estraneo, crudo e colorato, che non ha nulla a che fare con le nostre colline.
Cerco di capire cosa sia successo davvero, quali aree di Forlì sono state colpite, ma la strada è bloccata, il ponte di porta Schiavonia è il fulcro dell’esondazione, l’altro ponte ed unico che mi porterebbe in città ha due ore di fila.
È giovedì 18 maggio quando arrivano le prime foto di giovani che spalano fango a Cesena e Faenza, mi dirigo in bici fino alla zona rossa, questa volta con gli stivali, non so se per aiutare o per capire; l’accesso al ponte che collega al centro storico e la via Emilia è chiuso da un posto di blocco, mentre intorno persone spalano in silenzi; ancora non è facile capire come aiutare.
Il sabato, il Comune, ha assegnato a tutti i volontari un punto di raccolta, nel quale distribuiscono pale, guanti e cibo: c’è tantissima gente, dal parcheggio intasato sembra che vadano tutti al mare; invece, vanno finalmente ad accompagnare l’acqua verso i tombini. Parto da casa con pala da neve e stivali e una gran voglia di far parte di questo aiuto generale che già da giorni sembrava l’unica occupazione dei cittadini non colpiti dall’alluvione. Davanti a me, un paesaggio non immaginato, quartieri un tempo noti invasi da uno strato di acqua marrone, cataste di mobili color fango si estendono per tutti i marciapiedi.
M’infilo nella prima strada che vedo, è in discesa, circa 4 metri sotto il livello del fiume, del ponte, dell’antica via Emilia. C’è una folla incredibile, tutti parlano con tutti, tra uno scusa e un sorriso la gerarchia delle azioni è questa: chi spala l’acqua dai garage o dalle cantine la riversa in strada, chi spala l’acqua ricevuta in strada, la accompagna verso i tombini che dovrebbero filtrarla. Nel mezzo a queste azioni, ci sono persone che accatastano mobili e oggetti lungo la strada, come se fossero barricate.
Ma quest’acqua è una soluzione pesante di terra e detriti, che vorrebbe stare ferma nell’antro che si è trovata, quindi in pochi minuti, i tombini sono pieni, un signore urla “cassette” e parte la ricerca tra le cataste di detriti di cassette della frutta che possano filtrare il fango prima di essere riversato nel tombino.
Si creano paratie improvvisate, con griglie di frigoriferi e damigiane piene d’acqua per tenerle ferme. Una ragazza con solo la testa fuori dall’acqua si auto-proclama “toglitrice di foglie incastrate nelle griglie”, azione salvifica per il giusto flusso delle acque. I volontari devono inventarsi delle soluzioni, ognuno è indispensabile all’altro, senza un coordinamento, ma un solo scopo comune. Sembra un balletto senza che ci siano state le prove generali, non si parla ma c’è una intelligenza comune, un processo “azione-conseguenza” che tiene su il gioco, fino a quando i tombini di tutta la strada si riempiono definitivamente ed è necessario far passare l’autospurgo, mentre alcuni volontari tornano sulla via principale per poi riversarsi in altre traverse allagate.
La via principale, la famosa via Emilia, che in quel tratto si chiama via Bologna, sopraelevata rispetto ai quartieri allagati è ricoperta di fango e polvere bianca ma priva di acqua, viene utilizzata dai mezzi della protezione civile, dai vigili del fuoco e dall’esercito, dai chioschetti di acqua e cibo allestiti dai volontari e da chi si sta spostando per capire dove dirigersi.
Siamo tutti pieni di fango, sembriamo attori di un film post apocalittico in una sagra improvvisata, c’è un’energia mai vista nella Forlì di provincia, dove le strade sono piene di ragazzi giovani solo il sabato pomeriggio nel corso principale pieno di negozi, dove il gioco è chi si veste meglio e non di chi veste peggio ed è più sporco, come ora.
Durante queste operazioni, è possibile finalmente iniziare a capire cosa è successo in quel territorio, anzi è necessario trovare un pattern, delle cause oltre alla retorica della catastrofe naturale e dell’imprevedibilità. C’è un quartiere residenziale, ad esempio, che è stato fortemente colpito, si chiama Romiti-La Cava (forse la toponomastica non andava sottovalutata), ed un altro piccolo quartiere a Est della via Emilia, che dalle mappe, si trova nella vecchia ansa del fiume: è un insieme di vie residenziali, file di villette unifamiliari di due piani massimo, costruite negli anni Settanta- Ottanta, un esempio da manuale di sprawling urbano costruito sotto gli argini: in pochi minuti gli abitanti si sono trovati in trappola, con l’acqua che li circondava da tre direzioni. Il sogno americano di vivere nella villetta indipendente, in città ma non proprio, insieme alle poche lire di oneri al comune, hanno spazzato via le secolari regole della costruzione del territorio, le leggi della civiltà contadina che hanno reso abitabile questo territorio alluvionale.
Ma ora, anche per colpa della crisi climatica, i nodi sono venuti al pettine.
La mia giornata si è conclusa camminando altri chilometri per raggiungere l’altro quartiere allagato, basta seguire il flusso di gente con fango e pala, riesco ad attraversare il ponte che porta al centro e vedere un timido Fiume Montone ritiratosi nel suo letto, decisamente fuori scala rispetto alle sue sponde deturpate, che comunque non hanno retto.
Continuando l’indagine sul campo, mentre è incessante il flusso di gli aiuti e di volontari, si può vedere un altro quartiere, che costeggia il centro storico: è stato costruito nella parte più alta rispetto al fiume, come tutta la città, infatti da quel lato dell’argine le case più vecchie sono state invase dall’acqua che però, è passata attraverso gli edifici, senza fermarsi. I danni maggiori si sono riscontrati dove poi l’acqua non è riuscita a defluire, qualche strada più in là, dove si è accumulata di nuovo nei giardini e negli interrati dei quartieri costruiti più recentemente.
Almeno per quanto riguarda le città di Forlì e Cesena a riportare i danni maggiori sono stati i quartieri progettati a partire dal dopoguerra, con danni via via più evidenti nei quartieri realizzati in tempi più recenti, mentre le case più antiche, anche quelle sugli argini, forse anche per un maggior rapporto con la campagna circostante hanno avuto un destino almeno un po’ migliore. L’impressione, un po’ semplificata, è che “si siano allagati gli anni Ottanta”.
Prima della guerra non esistevano le mappe che tracciassero i rischi, e anche il concetto di vincolo e tutela del territorio (o anche solo di paesaggio) era ancora flebile, almeno dal punto di vista normativo, e anche nel periodo della ricostruzione del dopoguerra fino a tempi relativamente recenti, l’attenzione principale dei piani e degli strumenti di amministrazione del territorio era quello di organizzare in modo funzionale e redditizio l’espansione, la conoscenza del territorio passò in secondo piano, e le mappe antiche che indicavano i fattori di rischio vengono scavalcate da strumenti come il Piano regolatore Generale di Forlì del 1965 che prevedeva, per le aree alluvionate la destinazione a “zone di nuova espansione semintensiva”. Solo in tempi più recenti il consumo di suolo è stato pensato in modo più organico, e il territorio come un ecosistema globale, in cui l’uomo si pone alla pari e non al di sopra, e in cui gli insediamenti urbani o rurali devono fare i conti con l’ambiente circostante.
Oggi con più consapevolezza della crisi climatica e con una volontà all’utilizzo di suolo ponderato, si possono aggiungere tasselli che aiutino a contrastare eventi così catastrofici, a partire da una conoscenza approfondita dei territori, dei bacini fluviali e dei fattori di rischio che non possono essere trascurati.
E quindi si fa sempre più chiaro come siamo arrivati fino qua, nel succedersi di scelte basate su altre priorità momentanee che hanno sovrastato un equilibrio da rispettare, che non hanno tenuto conto della storia delle popolazioni che hanno costruito e modellato questi territori, consapevoli che non sarebbero potuti scappare, se non a piedi, durante una piena e la cui sopravvivenza era legata indissolubilmente al territorio, ai campi, ai raccolti, al guardiano dell’argine della bassa.
Risulta evidente che nel passaggio tra la gestione del territorio basato sulla sussistenza e con una demografia molto minore, ad una gestione amministrativa finalizzata alla crescita è andata persa la conoscenza che ha disegnato e reso sicure queste aree, è chiaro che sono cambiate molte cose, da una parte la necessità di costruire case per una popolazione che aumentava, dall’altra un modello di abitare e un modello di società estraneo a questi territori, da cui la pur produttiva Romagna (e come questa, ognuna a modo suo, tante regioni italiane e non solo) si è distaccata. E questo distacco ha anche rotto il patto tra generazioni alla base dell’idea di sviluppo sostenibile, che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfarne i propri, i millennial e la generazione Z si trovano quindi ad affrontare delle crisi, locali e globali, sempre più interconnesse, scontrandosi con la staticità delle generazioni precedenti.
Ma allo stesso tempo, per chiudere con una nota di speranza, durante i giorni successivi alle alluvioni, in mezzo alle persone che per solidarietà o per necessità si ritrovavano nelle città allagate, si è visto recuperare il rapporto con il territorio, le strade diventare veramente pubbliche, gli argini e il fiume diventare veramente di interesse collettivo, la solidarietà e la collaborazione diffondersi prive di competizione e al di fuori del binomio azione/profitto economico.
Per la prima volta, il bisogno di essere insieme agli altri, di aiutare ed essere aiutati, di non dare per scontato tutto quello che si ha, la possibilità di prendersi cura delle persone e del territorio, la forza di sentire qualcosa di proprio e di poter dare qualcosa ha travolto tutti, lasciandoci in piedi e con una pala.
Le foto qui pubblicate sono state scattate dall’architetto Caterina Spadoni, autrice di questo reportage dalle aree colpite dalle bombe d’acqua e dall’alluvione in Romagna