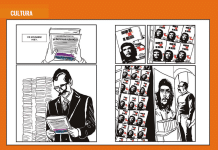Come si può ricordare oggi la tragedia del Vajont? Come accostarsi allo spettacolo Il racconto del Vajont, portato in scena da Marco Paolini il 16 ottobre al teatro Strehler di Milano, dopo dieci anni dall’ultima rappresentazione? La prima volta che ho assistito a questo spettacolo è stato ventisei anni fa. L’ho visto in televisione quando ancora la televisione faceva servizio pubblico. È lì che ho appreso che il 9 ottobre del 1963 alle 22:39 una gigantesca frana si è staccata dal monte Toc precipitando nella diga del Vajont, provocando un enorme ondata che ha scavalcato gli argini e spazzato via cinque paesi del Veneto, lasciando il Piave gonfio di morti, in un mattino livido con un bilancio finale di 2000 vittime.
La rappresentazione allo Strehler in serata unica è stata preceduta qualche giorno prima da VajontS per una Orazione Civile Corale. Si è trattato di un’operazione culturale che ha visto cento teatri in Italia e in Europa portare in scena il lavoro di Marco Paolini e Gabriele Vacis.
A teatro c’era grande folla arrivata ben prima che in sala si spegnessero le luci, per riaffermare la voglia, il bisogno di esserci, di ritrovarsi, in uno dei pochi luoghi in cui rintracciare ancora un’ombra di senso, il teatro. Possibile antidoto ai tempi confusi che stiamo attraversando.
Il racconto del Vajont è uno spettacolo che a poco a poco perde i contorni dell’evento verificatosi sessanta anni fa, per diventare un’orazione laica e civile, che reclama giustizia, attenzione verso un pianeta che muore.
Paolini lo dice bene, le tragedie industriali non sono qualcosa di meno di una guerra. Ce lo fa capire nelle due ore in cui calca le scene, mixando con perfetto equilibrio drammaturgico dati tecnici e momenti passionali. Attraverso le sue parole non vediamo soltanto la scena della tragedia annunciata del Vajont, prefigurata con largo anticipo dai tecnici, dalla giornalista del L’Unità Tina Merlin, che per questo subì un processo per diffamazione e fu poi assolta perché il fatto non sussiste ( della sua storia scrive Piero Ruzzante ne L’acqua non ha memoria, Utet ndr).
Scene come quelle che l’attore mostra, evocandole solo a parole, ci portano anche alle migliaia di morti di questi giorni. Perché i morti con la bocca digrignata sono gli stessi, il patimento, la sofferenza, la tragedia sono gli stessi, come ha sottolineato Paolini nel corso della sua orazione/spettacolo.
A Marco Paolini va riconosciuto un grande merito di riuscire con la messa in scena di Vajont, che racconta uno degli eventi industriali più catastrofici che ha percosso l’Italia, di riuscire a rendere il teatro di parola assolutamente perfetto. Di fronte a rappresentazioni come quelle di Vajont la parola spettacolo risulta riduttiva e imprecisa come spesso sono le parole. Marco Paolini in Vajont raggiunge il suo apice. Così come accade nel suo Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute che racconta dei programmi nazisti per eliminazione le persone disabili nella Germania del Reich. Così come avviene nel suo I-TIGI. Canto per Ustica, che ci aiuta a non dimenticare ciò che accadde nei cieli di Ustica, quando il DC9 dell’Itavia, in volo da Bologna a Palermo con a bordo 81 passeggeri, precipitò (abbattuto?) nei pressi di Ustica il 27 giugno 1980.
Vajont è un atto politico, di denuncia del malaffare italiano in cui le sue responsabilità si perdono nella nebbia, nella confusione di ruoli in cui controllore e controllato si mischiano, in cui alla fine nessuno è responsabile. Il teatro di Paolini diventa denuncia civile, diventa un modo come ben affermato durante lo spettacolo per trasformare la solitudine in moltitudine, per non alzare le spalle di fronte al dissesto morale e idrogeologico del nostro Paese, ma per trasformare la rabbia e l’impotenza in atto politico.
È un teatro di cui abbiamo bisogno. È un teatro che non consola. Ci rende responsabili della memoria affinché questa non sia qualcosa in cui rifugiarsi, ma diventi presupposto del nostro agire, per dire no al Vajont, al ponte Morandi, all’Ilva, a Bophal, a Černobil, a Fukushima. Per dire no ai luoghi dove la morte provocata dall’uomo prende il sopravvento sull’uomo, e ribadire il sì alla vita.
L’autore: Gianfranco Falcone è psicologo e blogger (Viaggi in carrozzina, DisAccordi) e collabora con la rivista on line Mentinfuga, dove scrive di temi culturali, di teatro e diritti. Da alcuni anni è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Ha da poco pubblicato il romanzo 21 volte Carmela (Morellini editore)