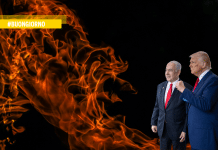Il 5 maggio 1936 le truppe italiane comandate dal maresciallo Pietro Badoglio entravano trionfalmente ad Addis Abeba e l’annullamento dei grandi simboli dell’indipendenza etiope iniziò pochi mesi dopo l’occupazione. Nell’ottobre del 1936, fu smantellato il monumento a Menelik II; poco dopo cadde la statua in bronzo del Leone di Giuda, inviata a Roma e installata sul monumento ai caduti della battaglia di Dogali. Nel 1937, anche l’obelisco di Axum, sottratto ad uno dei siti più antichi e venerati della nazione, veniva eretto nella capitale italiana per celebrare il quindicesimo anniversario della marcia su Roma. Per la sua restituzione all’Etiopia, pur stabilita dal trattato di pace italo-etiope del 1947, ci sono voluti sessantuno anni di diplomazia e di pubblici appelli, fino al 4 settembre del 2008, lo stesso anno che vide il ritorno in Libia della Venere di Cirene, che era stata trasportata a Roma nel 1915.
L’obelisco di Axum e la Venere di Cirene: due casi celebri che ancora oggi alimentano, nella coscienza comune, l’immagine di un’Italia benevolmente orientata al rispetto dei popoli vittime dell’aggressione coloniale. In realtà, non è che l’infinitesima parte visibile di un patrimonio sommerso e dimenticato, accumulatosi nelle raccolte dei musei italiani con i primi viaggi di esplorazione commerciale alla metà dell’Ottocento, con i doni diplomatici, per lo più da leggersi nel contesto di rapporti condizionati dalle mire coloniali, e infine cresciuto in maniera esponenziale con i trafugamenti legati all’occupazione. Da tempo l’Etiopia rivendica la restituzione delle centinaia di oggetti preziosi e di manoscritti depredati dagli inglesi nel sacco del palazzo imperiale di Magdala, ora dispersi in varie istituzioni britanniche, tra cui il British Museum, il Victoria and Albert e la British Library, un caso che meriterebbe di essere portato all’attenzione internazionale al pari di quello dei bronzi del Benin, recentemente illuminato dalle ricerche di Dan Hicks. In Italia, nonostante l’attenzione crescente al fenomeno della decolonizzazione, la geografia, l’entità e la natura dei patrimoni provenienti dall’Africa rimangono ancora in larga parte oscure.
L’impegno degli storici per andare alle radici profonde del colonialismo italiano, e a quelle della sua mancata o mai completa rilettura critica da parte della coscienza nazionale, ha tracciato negli ultimi decenni un fondamento che rappresenta per i musei un formidabile strumento per affrontare la sfida intorno a questi segmenti patrimoniali dimenticati. A patto che vi sia la consapevolezza del ruolo che le testimonianze materiali possono rivendicare nella costruzione di nuove idee e di nuove coscienze sociali, contro ogni ideologia estetizzante che vede nel museo una morta gora di deportazione. È la storia stessa dei musei, anch’essa intricata e dinamica, fatta di affondamenti e di riemersioni, a fornire un documento esplicito di come abbia agito la rimozione collettiva di parti significative della nostra storia nazionale. Fa da capofila il controverso destino del Museo coloniale di Roma e delle sue raccolte, ma anche l’immobilità, quando non la chiusura prolungata, di molti musei antropologici italiani, tra cui il Museo di Antropologia ed etnografia dell’Università di Torino; per arrivare alle mille strade delle collezioni civiche, dei musei diocesani e missionari, dove le raccolte extraeuropee hanno avuto, nel migliore dei casi, vita stentata, e nel peggiore, drasticamente negata. Esistono poi episodi apparentemente insospettabili, come quello dell’Armeria Reale di Torino, che già dagli anni Sessanta dell’Ottocento comincia ad accogliere manufatti provenienti dalle esplorazioni commerciali nell’Africa Orientale, per precisare man mano l’orientamento secondo le direttrici della penetrazione italiana, con vetrine dedicate all’Eritrea e alla Somalia e infine alla Libia. Anche tanti oggetti ricevuti in dono o acquistati nel corso dei viaggi compiuti dal principe Umberto di Savoia (poi re Umberto II), e da lui lasciati al castello di Racconigi, sono in ampia parte legati alle sue visite nelle colonie italiane.

Il caso del raro kebero etiope dell’Armeria Reale esposto nella mostra è uno tra i molti esempi possibili dell’intreccio di relazioni che legano l’Italia al Corno d’Africa. Donato dall’imperatrice Taytu alla chiesa della Trinità della regione di Debre Berhan (Shewa), riconvertito da Menelik II in dono diplomatico per Umberto I di Savoia e infine inserito da Hailé Selassié nella primissima richiesta di restituzioni presentata al governo italiano nel 1946 per il tramite dell’Ambasciata britannica. Riportarlo alla luce significa fissare per sempre un frammento di storia, con quel potere esclusivo che gli oggetti e le loro immagini esercitano sulla nostra memoria, per lungo tempo condizionata dalla propaganda coloniale.
Il progetto della mostra è maturato lentamente, anche nel contesto dell’impulso dato dal ministero della Cultura italiano alla ricostituzione del “Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali” e con la nomina di uno specifico gruppo di lavoro per lo studio delle collezioni coloniali.
A Torino, il dialogo tra i Musei Reali, la direzione regionale musei e il museo di Antropologia ed etnografia ha portato all’avvio di un progetto di ricerca orientato alla “diplomazia culturale”, sfociato in un protocollo d’intesa pensato per mettere a sistema competenze e risorse per la valorizzazione delle collezioni extraeuropee. Le prime ricognizioni, condotte nel corso del 2021, hanno censito centinaia di manufatti provenienti dalle aree più diverse di quattro continenti, eredità di esplorazioni e di viaggi, ma anche di relazioni dinastiche, diplomatiche e commerciali intrattenute dai principi e dai re di casa Savoia, e dai loro rappresentanti, a partire dal Settecento.

La ricerca collettiva e multidisciplinare che ha portato al disegno finale della mostra si è sviluppata anche attraverso il dialogo con Lucrezia Cippitelli, da anni impegnata in progetti di decolonizzazione, e Bekele Mekonnen (1964, vive e lavora a Addis Abeba), artista concettuale, educatore ed intellettuale pubblico, che, a partire dalle collezioni torinesi, ha sviluppato per la mostra l’opera site-specific The smoking table, ispirata al tema della Conferenza di Berlino del 1884-85 e a quello della difficile ma necessaria azione di decostruzione della colonialità.
Un progetto che può documentare solo in parte il ruolo svolto da Torino nel processo coloniale, ma l’augurio è che il percorso possa proseguire nel quadro della collaborazione con studiosi e artisti africani che si è avviata, nella prospettiva di una museologia condivisa e concretamente impegnata nel dialogo e nella cooperazione internazionale.
Le autrici: Elena De Filippis (direttore regionale Musei Piemonte), Enrica Pagella (direttrice Musei Reali) e Cecilia Pennacini (docente universitaria e direttrice Museo di antropologia ed etnografia), hanno curato la mostra “Africa. Le collezioni dimenticate”