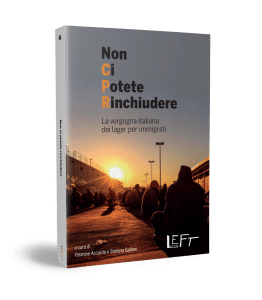Questa storia inizia con l’approvazione della legge 40 (Turco-Napolitano) nel luglio 1998, quando, in nome dell’esigenza di “coniugare sicurezza e accoglienza”, nacquero i primi Cpta (Centri di permanenza temporanea e assistenza) che vennero realizzati in maniera improvvisata prima ancora di dare loro un quadro normativo.
Per la prima volta in Italia – nel resto d’Europa era già una prassi – si potevano privare le persone della libertà personale in virtù del fatto che la loro presenza non era considerata regolare. La finalità dei centri riguardava gli «stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile». Persone che non avevano commesso reati, rinchiuse per ciò che erano. Per facilitare i rimpatri delle persone considerate irregolari, l’allora ministro dell’Interno si affrettò a siglare i primi accordi bilaterali di riammissione con alcuni Paesi del Nord Africa che raramente produssero i risultati sperati.
I centri in cui allora si poteva restare rinchiusi fino ad un mese in attesa dell’espulsione nacquero da un giorno all’altro e in modo non organico. A Lampedusa non c’era ancora la struttura di Contrada Imbriacola, quindi le persone venivano tenute nei pressi dell’aeroporto e poi nell’ex base militare Loran che non risultava inquadrata come Cpta ma che di fatto aveva quella funzione. A Trapani venne preso in affitto un ospizio in disuso, il “Serraino Vulpitta”, tramutato in struttura con celle, a Roma si utilizzò parte di una caserma nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, a Ponte Galeria, e poi fu la volta di Agrigento, Bari, Brindisi. Già da allora i servizi di “assistenza” (sanità, pasti ecc.) vennero dati in gestione a imprese o cooperative che a volte partecipavano a gare pubbliche, più spesso ottenevano un affidamento diretto: un business enorme. La sorveglianza esterna e la repressione interna in caso di emergenze era (come ancora oggi) gestita dalla locale prefettura e quindi attraverso personale dei diversi corpi dello Stato. Furono in molti a “offrirsi” per fornire strutture adeguate, da don Cesare Lodeserto che in Puglia fece rapidamente trasformare il suo centro Regina Pacis, prima adibito all’accoglienza, in un Cpta, alle città di Milano (via Corelli), Torino, (Corso Brunelleschi), Bologna (via Mattei). A Modena ne sorse uno gestito dalle Misericordie il cui presidente era Daniele Giovanardi, fratello del più noto uomo politico Carlo Giovanardi. E poi Foggia, Crotone (Isola Capo Rizzuto) accanto a un immenso campo di accoglienza, Lamezia Terme, (gestito da un responsabile della protezione civile e realizzato al posto di una comunità di accoglienza per tossicodipendenti). Nel 2006 venne aperto il Cpt di Gradisca D’Isonzo, ribattezzata la “Guantanamo italiana” per l’uso di tecnologia avanzata atta a impedire fughe, rivolte, socialità eccessiva fra gli “ospiti”. Sì perché chi vi era trattenuto non era considerato detenuto ma “ospite” al punto che le fughe non potevano essere addebitate agli addetti alla sorveglianza per negligenza. A Ragusa venne aperta una struttura solo per donne in pieno centro, con personale quasi esclusivamente maschile.
E poi una serie di aperture e chiusure: chiuso il Cpt di Agrigento per difficoltà di gestione, ne venne aperto uno a Caltanissetta (Pian Del Lago), si spostò quello di Bari, per pochi mesi ne restò aperto uno a Trieste mentre nelle altre città venne resa difficile la realizzazione di queste strutture sia per l’opposizione degli enti locali sia più spesso della popolazione e dei movimenti sociali, oltre che per le difficoltà di reperire strutture idonee, come nel caso di Corridonia, nel maceratese. Nel frattempo era entrata in vigore la legge Bossi-Fini, che raddoppiava i tempi massimi di trattenimento (da 30 a 60 giorni) e si andava rapidamente dimostrando il fallimento di tale approccio all’immigrazione. I centri, sin dalla loro apertura si erano dimostrati luoghi da cui si tentava di fuggire e in cui si moriva. La notte di Natale del 1999 venne trovato senza vita, nel Cpt di Ponte Galeria, Mohamed Ben Said, con una mascella rotta e forse imbottito di psicofarmaci. Pochi giorni dopo, il 28 dicembre, alcuni “ospiti” tentarono la fuga dal “Serraino Vulpitta” di Trapani, vennero ripresi, rimessi in cella e, sembra, uno di loro dette fuoco al materasso. Non si trovarono le chiavi per aprire i locali, non funzionavano gli estintori e in 6 trovarono una morte atroce (uno di loro dopo 3 mesi di agonia): insomma, una strage annunciata in una struttura anche inadeguata al trattenimento.
C’è un calcolo macabro scomparso dalla storia ufficiale, in triste e perenne aggiornamento: quello di coloro che hanno perso la vita a causa della detenzione in questi spazi dove non valgono nemmeno le garanzie dei regolamenti penitenziari. Fra tentativi di fuga, malori dalle cause mai chiarite, suicidi parliamo, per difetto, di una trentina di morti. Senza contare gli innumerevoli atti di autolesionismo, l’equilibrio psicofisico spezzato da mesi di privazione della libertà, la repressione sempre seguita a rivolte e sommosse per la scarsa qualità del cibo, per poter ottenere colloqui con parenti e avvocati, per difficoltà strutturali derivanti da spazi pensati esclusivamente come “zoo” temporanei per esseri umani.
Per parecchi anni, soprattutto fino al 2007, si sono susseguite mobilitazioni per chiedere la chiusura dei centri, giudicati dai più irriformabili, la più grande a Torino nell’inverno 2002, ma furono tante e in tutte le città in cui c’erano Cpt o in cui si minacciava di aprirli. Mobilitazioni a volte creative e che riuscivano a parlare alla popolazione e alle persone rinchiuse, in altri casi aspramente e duramente conflittuali, spesso represse dalle forze dell’ordine. Ma anche nei palazzi della politica, per alcuni anni, ci si interrogò sul senso di queste strutture che non sono state “imposte dall’Europa” come ha lasciato passare una vulgata pseudo progressista (l’Europa con l’accordo di Schengen ha solo chiesto a ogni Stato di vigilare sui propri confini), ma create più per soddisfare istanze propagandistico securitarie che già da allora venivano utilizzate in Parlamento.
Ci furono però parlamentari, senatori ed europarlamentari che, essendo gli unici ad avere il mandato ispettivo, cominciarono a visitare quei luoghi, a denunciarne le carenze e le condizioni di vita che vi venivano imposte, a provare a scardinare questo sistema. Certo, di centri ce ne erano in tutta Europa, nel 2005 (fonte Migreurop) 174, in Italia si arrivò a un massimo di 14 strutture che costarono milioni di euro l’anno e che, anche in base agli scopi per cui erano state aperte, si dimostrarono fallimentari. I dati di 14 anni fa indicano che al massimo il 48% delle persone trattenute veniva poi effettivamente rimpatriato, con costi che si aggiravano attorno agli 8mila/12mila euro per ogni espulsione. Il tutto per detenere 2mila/3mila persone, rispetto ai dichiarati “600mila clandestini”, in parte rinchiusi nei centri dopo periodi di detenzione in cui non erano stati identificati, i cui provvedimenti di convalida del trattenimento erano affidati a giudici di pace (mai utilizzati fino ad allora per autorizzare la limitazione della libertà personale). Queste persone una volta non rimpatriate, tornavano fuori in condizioni di irregolarità con l’obbligo di lasciare entro pochi giorni il territorio nazionale ma senza alcun Paese intenzionato ad accoglierle.
Un mix di propaganda e costruzione della fortezza escludente per rinchiudere il “nemico interno”, con l’intento di dimostrare che lo Stato si prendeva cura della sicurezza dei cittadini. Oltre che gli ex detenuti sono finiti nei centri persone che avevano perso il lavoro e quindi il diritto di restare in Italia, richiedenti asilo a cui non era stata riconosciuta la protezione internazionale o umanitaria, lavoratori e lavoratrici al nero (in particolar modo nel lavoro di cura), vittime di tratta per sfruttamento sessuale che non usufruivano delle normative atte a tutelarle, a volte persino minori.
Estratto dall’introduzione del libro di Left Non Ci Potete Rinchiudere. La vergogna italiana dei lager per immigrati a cura di Yasmine Accardo e Stefano Galieni