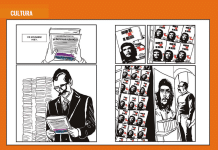Dopo il Belgio, si trova in Francia per una tournée Giuseppe, Peppe, Voltarelli, quando lo raggiungo al telefono per farmi raccontare del suo ultimo lavoro, La grande corsa verso Lupionòpolis, secondo classificato al Premio Tenco nel 2023. (l’11 maggio è stato al Salone del libro e al Teatro Vittoria di Torino in occasione del premio speciale “InediTO RitrovaTO”, dedicato alla scrittrice Grazia Deledda, mentre il 13 maggio è al Teatro Cartiere Carrara a Firenze).
L’album è il risultato di un ottimo lavoro di produzione, registrato a New York da Marc Urselli, nello storico EastSide Sound di Manhattan. Ben orchestrato, coniuga la profondità della voce con sonorità cosmopolite. Tutto questo lo rende fluido e apprezzabile ed arriva con una godibile morbidezza. Quella che inizia come una semplice chiacchierata sull’album, oggi realizzato in formato fisico per Todo Modo Publishing, in collaborazione con l’etichetta discografica Visage Music, sfocia poi nella storia di una vita che inizia in un paese della Calabria per arrivare in varie parti del mondo, compreso il Brasile.
Fondatore, in quel di Bologna, nel 1990, della band folk-rock Il parto delle nuvole pesanti, a metà degli anni Duemila Peppe Volatrelli inizia una carriera da solista, oggi è al suo sesto album e ben tre Targhe Tenco. Numerose anche le collaborazioni e i riconoscimenti, tra tutti quella con Claudio Lolli, «un punto di riferimento», dice Voltarelli, ma anche con molti altri artisti italiani e internazionali. Ma lui, cantautore impegnato, nonostante le contaminazioni fuori dalla sua terra, a cominciare da quella di Firenze dove sceglie di vivere dopo Bologna, non abbandona il suo dialetto per raccontarci, anzi fotografare, le storie che lo circondano. Autore, cantautore, ma anche attore (tra le ultime cose, la serie Il Re, di Giuseppe Gagliardi) getta lo sguardo sul contemporaneo, quello italiano, soprattutto sul piano culturale, attualmente sostiene l’artista in una triste impasse soggiogato dal mainstream. Lui che al “sistema” non si è mai piegato, le sue storie le porta in giro con la speranza che iniziando a guardare altrove, e lo chiede a tutti noi, qualcosa possa cambiare. Alle brutte, c’è Lupionòpolis, ma non solo!
Esattamente, dove si trova Lupionòpolis?
Un piccolo villaggio del Paraná in Brasile, dalle parti di Londrina, dove ho scoperto che esiste un supermercato col mio cognome, allora ho cominciato a fantasticare sull’idea che, quando tutto mi sarebbe andato male, sarei potuto andare lì e chiedergli di lavorare, una cosa del genere. Poi ho pensato che ognuno di noi può avere il desiderio di trovare un posto nuovo dove scomparire e rinascere, trasformarsi, insomma vivere sotto mentite spoglie. Allora, ho immaginato una corsa che mi porti lì.
Per la tua storia, per la musica che fai, e che porti in giro, mi sembra che ci siano tanti villaggi che ti aspettano.
In effetti, questa grande corsa io l’ho iniziata con un produttore americano che si chiama Simone Giuliani, che mi ha arrangiato i pezzi, mi ha costruito la band. Tutto questo a New York, che per me, nato in un piccolo paese della Calabria, rappresenta un bel punto d’arrivo. Nel senso che c’è un posto dove la mia persona si sente a casa: quando ci sono andato per la prima volta, nel 2002, ho pensato che avevo sempre vissuto in quel luogo. Come mi è successo anche a Buenos Aires. Sono grandi metropoli dove la cultura non si sente subalterna, ma è rispettata, come dovrebbe essere insomma.
Però tutto ha inizio in Calabria, nel tuo paese di origine, poi Bologna, poi Firenze e il resto del mondo.
Torno sempre volentieri a Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, dove sono nato, dai miei amici. Sono molto legato a quella terra. Dopo Bologna, dove sono andato per l’università, Firenze per fare un disco con la Bandabardò, che è stato il gruppo di amici che mi ha accolto lì come un fratello e quindi la mia vita è ricominciata. Firenze per me è un luogo ideale dove poter avere questa sorta di microclima umano, fatto di sostenibilità, di facilità di vita quotidiana, ma ha anche il vantaggio di essere una città internazionale. Quando stai via per 15/20 giorni, dall’altra parte del mondo, è un piacere tornarci. Però per me la cosa principale è che lì c’era un gruppo di amici che mi aspettava, che mi aspetta; che se ho bisogno so che c’è. Ecco per me questa è una cosa fondamentale.
Adesso sei ad un Festival chiamato “Canzoni&Parole” sulla canzone d’autore italiana nei teatri e nei licei parigini. Che tipo di pubblico partecipa?
C’è un bel rapporto con il pubblico anche all’estero; ci sono amici sostenitori che ti aspettano, ma anche persone autoctone. Abbiamo fatto molte cose belle sia dal punto di vista dei live, ma anche incontri come ad Anversa dove sono stato ospite all’università per un incontro sulla canzone italiana. Abbiamo fatto un po’ di discussione con gli studenti, insomma molto bello.
Che tipo di attenzione c’è soprattutto per la nostra cultura?
Per l’Italia ovviamente c’è sempre tanta curiosità e tanto interesse: sia per la musica che per la lingua. Quello che faccio io chiaramente ha una connotazione molto precisa perché io, scrivendo in dialetto, racconto spesso storie che riguardano un’Italia meridionale o comunque legata ai temi del lavoro, della solidarietà, del viaggio e chiaramente viene fuori un Paese, concedimi il termine, neorealista. Il pubblico è fatto di italiani che, vivendo all’estero, quando arriva un cantante italiano o se arriva il cantante italiano che loro seguivano anche in Italia, lo vanno a sentire e hanno questo rapporto d’affetto molto bello, molto passionale e poi c’è la fronda dei locali che praticamente una volta che tu torni nel paese dove sei già stato a suonare, ti segue comunque. Ho fatto, per esempio, un film in Germania (Doichlandia di Gagliardi ndr), e lì è rimasta, come dire, una parte di me; così come un album pubblicato in Francia, mi ha permesso di entrare nelle radio francesi, nel repertorio delle loro canzoni, nella critica. La mia figura di italiano è molto da italiano senza patria, rispetto all’identità classica magari seguita dalla corrente migratoria degli anni 60 50, legata all’italianità col tricolore, con la musica magari pop dei grandi nomi italiani.
Da tutto questo mondo che vai a scoprire, che cosa riporti nella musica che fai?
I viaggi sono materiale per la scrittura, che diventa un materiale molto vivo, molto suggestivo molto intenso. Però il mio confronto principale la mia antenna principale è sempre la mia terra, la mia lingua. Tutto questo mi permette di poter esprimere anche le mie critiche in maniera molto libera e di essere anche, per fortuna, ascoltato.
Italiano o straniero, che tipo è il tuo pubblico?
Ci sono molti giovani, ma anche gente più grande. Molti mi seguono da tanto tempo, quindi riconoscono i miei segni distintivi, la mia lingua, i miei simboli. Per esempio, un mio brano si intitola “Turismo in quantità” e nomino la bombola del gas, che è un oggetto di culto per noi cresciuti in un’epoca in cui ancora il metano non è arrivato nelle case, per cui ogni tanto mi capita, in giro per il mondo, quando becco una bombola del gas, di fargli una foto e quella bombola riporta un po’ il messaggio surrealista. La condivisione di un certo surrealismo è una caratteristica importante della gente che viene a sentire i miei spettacoli perché è la parte dove veramente si raggiunge l’estrema libertà espressiva. Puoi essere pungente però, nello stesso tempo, assolutamente disarmante, con un racconto che è anche un nonsense. Si stabilisce così con il pubblico un rapporto di fiducia perché non è più il pubblico fan, ma è complice, sta con te, ti guarda negli occhi, sa se stai bene. L’ho imparato con gli anni frequentando artisti straordinari come Claudio Lolli, che per me è stato un amico: una persona di una grandissima profondità e di una grandissima poetica, di analisi della realtà. Queste esperienze mi hanno dato la possibilità di distanziarmi da quella che è la corsa verso il mainstream, verso l’idea che avevo a 25 anni. Che è un po’ l’idea che abbiamo tutti. Adesso c’è una consapevolezza molto bella, che è quella della musica come necessità, di miglioramento delle qualità umane, della vita che poi è il rapporto con le persone, i rapporti con i luoghi, il rispetto per l’ambiente, l’amore per tutte le culture del mondo. Hai uno sguardo sul mondo per cui, tutto sommato, se quest’anno la radio non ti programma è relativo perché magari hai altre 30 radio nel mondo che ti passano. Se c’è una cosa che è importante avere oggi per fare arte è il coraggio: di dire delle cose, di non fermarsi sulla superficie, di cercare la qualità. Quando viene percepita, diventa un bene prezioso e per me è il massimo cui posso aspirare.
Qual è il tuo sguardo adesso sul nostro Paese, politica compresa?
Direi che sono sempre molto arrabbiato, ma la rabbia mi dà comunque la motivazione per scrivere, per viaggiare, per spostarmi, per schierarmi nelle cose. Però è una rabbia che si va a scontrare con una realtà anche molto complessa, quindi anche a livello politico negli anni Novanta per me era immediato il mio essere dalla parte dei Centri sociali, dalla parte degli amici dell’estrema sinistra, in questo momento chiaramente sento la mancanza del progetto politico, ma non penso di essere solo. Quindi sono sempre alla ricerca di temi, di figure, di discorsi, di cose che possano comunque indicarmi una strada; non dico che sogno di avere un grande leader, anche se mi piacerebbe. Sono sempre alla ricerca di qualcosa che mi ricorda un po’ un’idea di politica con cui poi sono cresciuto cioè che era una politica fatta da un collettivo, da un gruppo di persone dove c’era uno che era bravo in economia, uno bravo in amministrazione, uno bravo nell’analisi, uno bravo a parlare, uno bravo a scrivere insomma questa sorta di immagine un po’ vecchio stampo, di una vecchia sezione di partito, dove si macinavano idee. Sono arrivato a Bologna e nel 1990 c’è stata la Pantera. Ecco quell’idea di scambio, di dibattito politico eccetera, purtroppo in questo momento mi manca, ma penso manchi a tutti!
Qual è la cosa che ti fa più arrabbiare?
Per esempio non mi piace la politica spettacolo, l’antimafia spettacolo, mi piace ciò che ha una forte componente di autenticità. Però è bello incontrare persone che hanno il coraggio di battersi per le proprie idee, di persone che non cercano solo visibilità, di persone che non vanno a vivere la propria vita semplicemente per il consenso. Penso anche che la grande abbuffata di Internet, di digitale, social, eccetera, di questi anni sia al pari di quando è arrivata l’eroina: ci siamo buttati con avidità, ma quando questa cosa cambierà allora capiremo cosa succede e a me piace osservare e stare a guardare cosa succede.
E secondo te, invece, come siamo percepiti all’estero?
Malissimo! Da un lato c’è l’Italia, come dire, autoreferenziale culturalmente, il Paese che viene da trent’anni del dominio culturale delle reti Mediaset, e questa cosa più che venire percepita, non passa fuori, non funziona. Le proposte che ci sono all’estero sono plurime: c’è il mainstream, ma c’è anche altro che ha spazio nelle reti, nelle radio. Noi siamo percepiti come un Paese culturalmente statico, un Paese dove lavorano dieci persone, dove non c’è pluralismo culturale. Non è possibile che si riconoscano sempre gli stessi linguaggi. Da noi se diventi un cantautore, un regista che funziona, è molto facile che il giorno dopo ti propongono di condurre… il telegiornale. Andrebbe data più voce al pluralismo. Se pensi solo che negli ultimi 10 anni è stata smantellata tutta una rete di realtà, per esempio per la musica si suonava nei club, nei circoli e adesso non ci sono più. Tu mi puoi dire: vabbè, ma i tempi sono così, lo so però, come dire, allora facciamo le riserve come si faceva con gli Indiani d’America, i tempi sono così gli indiani stanno in riserva. Chi fa una musica che non è prodotta da quel produttore, lo mettiamo nella riserva! Noi siamo un Paese dove c’è ancora il monopolio culturale, questo è il problema. Può sembrare un discorso rétro, ma non lo è.
Come si cambia tutta una mentalità, una cultura?
Col quotidiano, cercando di dare degli esempi prima di tutto a te stesso e a chi ti sta vicino. Facendo cose che vanno in altre direzioni, scoprendo nuovi luoghi, nuovi approcci, nuovi linguaggi cioè nuove strade. Siamo diventati un Paese che vive sull’asse dell’alta velocità, tra Salerno e Torino. Tutto si muove a quel ritmo e tutti vogliono andare a quel ritmo, invece noi dobbiamo cominciare a immaginare che esiste un ritmo diverso, che esistono strade laterali, che esistono la Costa adriatica, l’Appennino, Le Madonie, che ci sta pure l’Aspromonte. Questo sguardo ci vuole!
Qui il video Au Cinema