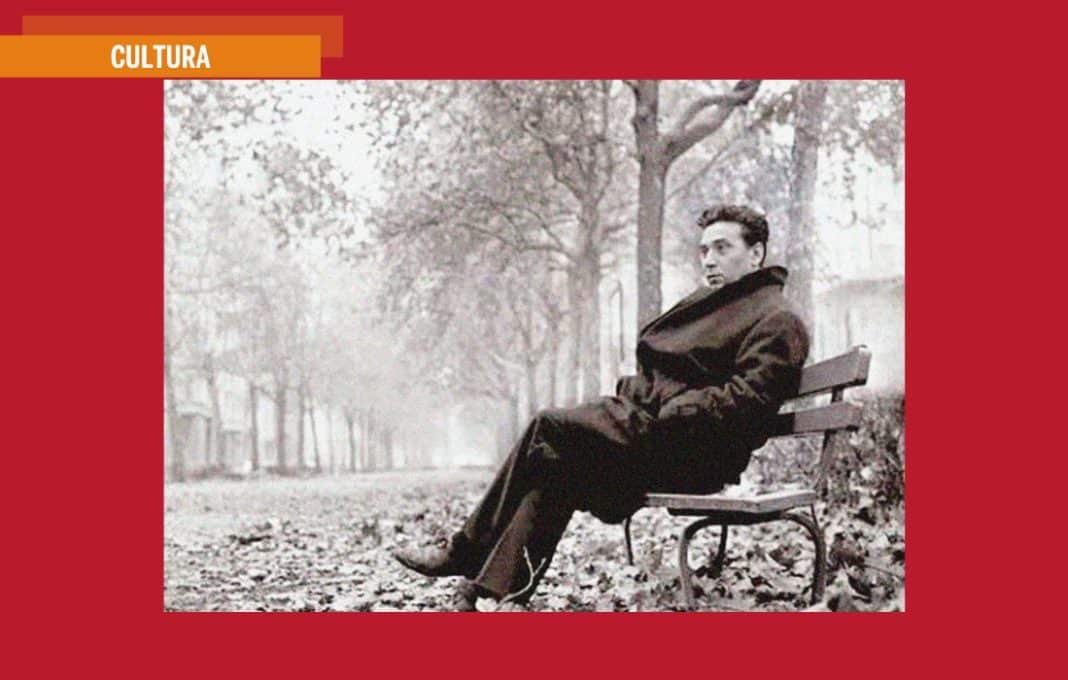Scegliere da che parte stare. Ecco cosa si chiedeva Bianciardi. La stessa domanda emerge dal libro di Pierluigi Barberio sullo scrittore grossetano. Questa volta è indirizzata ai ragazzi
La vita agra, il grande romanzo di Luciano Bianciardi incentrato sul lavoro, sul sacrificio, sulla fatica, sulla tragedia e sulla sognata vendetta, racconta tra le tante cose anche le angosce profonde che attanagliano i traduttori, quelli di ieri e quelli di oggi.
Angosce legate alle consegne editoriali, ai pagamenti, al dovere di sbarcare sempre e comunque il lunario: «Bisogna lavorare tutti i giorni, tante cartelle per questo e quello e quell’altro, fino a far pari, anche la domenica. Se ti ammali non hai mutua, paghi medico e medicine lira su lira, e per di più non sei in grado di produrre, e ti ritrovi doppiamente sotto».
Non è possibile tenere lontano il Bianciardi scrittore dal Bianciardi traduttore, perché parte del suo lavoro culturale fu proprio, e molto a lungo, il mestiere di prestare la propria voce, il proprio ingegno, alla voce e agli ingegni altrui. In modo resistente, tenace: «Venticinque giorni a cartelle piene, cinquecento cartelle mensili complessive, che a quattrocento lire l’una danno duecentomila lire mensili. Sessanta vanno a Mara, trenta al padrone di casa, dieci fra luce gas e telefono (e d’inverno anche di più, perché bisogna tenere acceso quasi tutto il giorno, mentre d’estate si consuma meno luce, ma bisogna lavarsi più spesso, e allora quello che hai risparmiato di lampadine ti va per lo scaldabagno), venti di rate fra mobili, vestiti e libri (si potrebbe anche non leggere, ma i vocabolari li devi comprare), quindici fra sigarette, caffè, giornali e qualche cinema, cinque fra pane e latte, e ti restano sessantamila mensili per il companatico e gli imprevisti».
Un grande ritratto del precariato letterario di oggi, si dirà. C’è però un luogo del romanzo in cui la tensione lavorativa lascia il campo all’abbandono: dopo una faticosissima consegna, il protagonista si concede una fantasticheria, una rêverie tutta irlandese: «Mi piacerebbe tanto visitar l’Irlanda, e specialmente la città di Dublino. Quando la nave entra a Dun Laghaire, dal ponte vedi il sole che tenta di affacciarsi alle colline. Eccole lì, le colline, ferme e ordinate dolcemente attorno alla baia: Capo Bray, il Pan di Zucchero, le Due Rocche, le Tre Rocche, Kippure, la regina fra tutte, che leva alta la testa minacciosa sopra le spalle delle altre che digradano sulla città».
Questo viaggio della mente, nel luogo del sogno, è però una continuazione naturale del lavoro culturale di Bianciardi. Sta infatti chiaramente pensando a un autore che ha da pochi anni tradotto, Brendan Behan, e al suo Borstal Boy (uscito per Feltrinelli nel 1960 col titolo Il ragazzo del Borstal). Il libro si chiude proprio col ritorno del giovane protagonista nella sua Dublino, dopo un soggiorno forzato in una istituzione di rieducazione minorile in Inghilterra. E le parole che usa Bianciardi sono esattamente sovrapponibili a quelle che chiudono il libro dell’irlandese, persino evocato, ma col suo nome gaelico forse per giocare un po’ di più a nascondino col lettore: «Poco prima del barcarizzo l’amico Breandan O’Beachain, piccolo e tozzo, con quella testa, dicono, da imperatore romano gonfio di sidro, stringe la mano al funzionario, un viso triste, da contadino istruito, come un maestro insomma».
Questo articolo è riservato agli abbonati
Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivista
Se sei già abbonato effettua il login