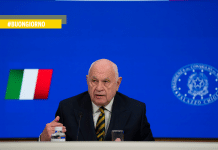Le guerre commerciali di solito non finisco bene, tantomeno per chi le inizia. È ormai cronaca che lo scorso 1 febbraio il neo-presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto un aumento delle tariffe doganali per i prodotti che vengono dai tre principali partner commerciali, ovvero dal Canada, dal Messico e dalla Cina. Gli importatori americani saranno costretti a pagare il 25% di tasse su tutte le merci provenienti dal Canada e dal Messico, legati agli Stati Uniti, è bene ricordarlo, da un accordo di libero scambio noto come NAFTA (Accordo nordamericano per il libero scambio). Per quanto riguarda la Cina, ad oggi si parla dell’imposizione di tariffe dell’ordine del 10%. Chi impone le tariffe, di solito, si deve aspettare delle ritorsioni di egual misura, se non di ordine di grandezza più grande.
Trump gioca sulla convinzione dell’importanza del mercato interno americano (quello dei consumi e dei capitali, per intenderci) per tutte le economie export-led, ovvero quelle che fanno delle esportazioni delle proprie merci un fattore determinante per la propria ricchezza nazionale (come lo è di fatto anche l’Italia). Dati alla mano, la ricchezza pro-capite degli Stati Uniti (dati 2023) è di 74,600 dollari a testa (cifra media che non tiene ovviamente conto delle enormi diseguaglianze tra ricchi e poveri), rispetto a quella della Cina e del Messico che è di soli 22,100 dollari. Limitare l’accesso al mercato statunitense, secondo Trump, vorrebbe dire mettere in difficoltà i partner commerciali più di quanto non metterebbe in difficoltà gli Stati Uniti. È una politica dell’azzardo, rischiosa per i suoi effetti destabilizzanti non solo sull’economia globale ma anche sull’ordine geopolitico.
Bisogna infatti considerare che molte aziende americane usano il mercato cinese, canadese e messicano per produrre i propri prodotti beneficiando dei costi del lavoro più bassi e di regolamentazioni ambientali light. Parte così delle importazioni americane da questi Paesi sono a marchio Made in USA, specialmente prodotti tecnologici, automobili, abbigliamento, etc. I primi a beneficiare di questo rapporto commerciale tra USA e “resto del mondo” sono le stesse aziende americane (ed europee, anche italiane) che, per tutelare i propri scopi di profitto risparmiando sui costi del lavoro, causano un deficit della bilancia commerciale del proprio paese. Chi soffre sono quelle imprese ed aziende americane (ma anche quelle italiane) che lavorano e producono esclusivamente sul suolo nazionale (e che non possono delocalizzare) e che risentono così della concorrenza estera. Trump di fatto ha ottenuto una valanga di voti proprio da questa fascia di popolazione “indebolita” da siffatto sistema di scambi. Non deve infatti meravigliare che una delle sue prime mosse politiche si concentra nel dare un segnale forte ai suoi elettori scatenando una guerra commerciale su vasta scala. Paradossalmente però, tali scontri commerciali causeranno crescenti costi a tutta la popolazione americana, almeno nel breve periodo.
Come ricorda il sito Bloomberg, le nuove tariffe americane ridurranno di circa il 15% le importazioni totali e genereranno circa 100 miliardi di dollari di maggiori entrate all’anno. Tuttavia, questo genererà anche dei contraccolpi nell’economia americana. Prima di tutto può creare delle distorsioni nella catena del valore a livello internazionale, rompendo e alterando i vari collegamenti di approvvigionamento delle aziende. Di fatto l’aumento dei costi può rendere meno conveniente produrre o assemblare in un paese rispetto ad un altro, etc. Di conseguenza, un secondo contraccolpo è certamente l’aumento dei costi per chi svolge attività imprenditoriali e commerciali su scala planetaria (ma non per le compagnie high-tech o di servizio come Amazon e Meta). Di conseguenza si arriverà alla perdita di molti posti di lavoro, non è detto esclusivamente nei paesi periferici. Facciamo un esempio: se mi aumentano i costi per le mie esportazioni o importazioni (visto poi che ai dazi americani si aggiungeranno i dazi degli altri paesi) non è detto che sia conveniente per me far tornare l’intera produzione in patria. Magari è semplicemente più conveniente delocalizzare interamente tutta la mia produzione in un paese terzo per compensare l’effetto degli aumenti dei costi tariffari. Nella migliore delle ipotesi, tali aumenti causeranno un rialzo generale dei prezzi e dunque un danno per tutti i consumatori.
Per quanto ne dica Trump, l’economia americana è fatalmente interconnessa con moltissimi paesi stranieri. Tra i vari rincari previsti dai nuovi dazi, c’è quello dell’energia. Circa il 70% del petrolio grezzo lavorato nelle raffinerie americane proviene da Canada e Messico (Trump vuole aumentare lo sfruttamento del petrolio nazionale per superare questo problema ma non si conoscono ancora bene i tempi). Collegato al settore del petrolio è certamente quello dell’auto. Attualmente gli Stati Uniti importano circa la metà delle auto vendute nel proprio paese, specialmente da Canada e Messico (dove sono presenti molto aziende americane che usano i vantaggi offerti in questi paesi, come ad esempio un assai minore costo del lavoro in Messico). Il Council of Foreign Relations stima che ci sarà un aumento per veicolo di circa 3 mila dollari al momento della vendita. Anche i prezzi alimentari potrebbero subire un aumento, sia come conseguenza del rialzo del costo del petrolio che per la dipendenza americana dai prodotti agricoli messicani: questo paese fornisce agli Stati Uniti circa il 60% delle importazioni di ortaggi e verdura nonché un’enorme quantità di frutta.
Trump gioca sul fatto che Canada e Messico verranno a loro volta colpiti pesantemente dai novi dazi. I due paesi sono molti dipendenti dal commercio con gli Stati Uniti, dato che circa il 70% del loro PIL dipende da questi scambi. Basti pensare che l’80% dell’export messicano prende la via degli Stati Uniti (per Washington invece le importazioni dal Messico valgono solo il 15% della torta). La guerra commerciale con il Messico rischia di causare un calo del suo PIL dell’ordine del 16%. Questo causerebbe un aumento della povertà e dunque dell’immigrazione verso gli Stati Uniti; possibilità che Trump dovrebbe evitare, per quanto funzionale alla sua politica di strumentalizzazione politica a danno degli immigrati.
Stessa cosa per il Canada. Gli Stati Uniti acquistano circa il 70% dell’export canadese, che vale circa il 14% delle importazioni americane. Basti pensare che circa l’80% dell’export di petrolio canadese varca i confini degli Stati Uniti.
Tuttavia, il deficit americano nei confronti di questi Paesi permette a Washington di sostenere la sua valuta e di finanziarie la propria spesa pubblica a costi decisamente più bassi rispetto a quelli che il mercato imporrebbe. Di fatto, essendoci tanti dollari in giro, acquistare i titoli di Stato americani (Treasury) diventa una scelta più che ragionevole e quasi obbligata (se si punta su investimenti “sicuri”). Questa condizione mantiene il costo dell’indebitamento pubblico americano basso, sostiene il dollaro e il ruolo egemonico degli Stati Uniti nel mondo. Non è azzardato affermare che il deficit americano mantiene paradossalmente in piedi alcune architetture del potere statunitense a livello globale.
Come nel 1933, la guerra commerciale tra i vari Paesi può innescare spirali di violenza politica difficilmente controllabili, aumentare il risentimento dell’opinione pubblica così come i costi generali per i consumatori. Il problema non sono i rapporti commerciali di libero scambio in sé, ma come le risorse derivate da questi scambi vengono utilizzate e concentrate in poche mani anziché redistribuite, almeno in parte, tra chi subisce i danni più deleteri di queste aperture; specialmente coloro che lavorano e producono per il mercato domestico, ovvero coloro che generalmente, presi dalla disperazione, costituiscono la base di voto per i partiti populistico-nazionalistici alla Trump.
L’autore: Giampaolo Conte è PhD Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo Università Roma 3,Research Associate ISEM-CNR ed editorial assistant of The Journal of European Economic History
Foto Adobe stock nr. 953180160