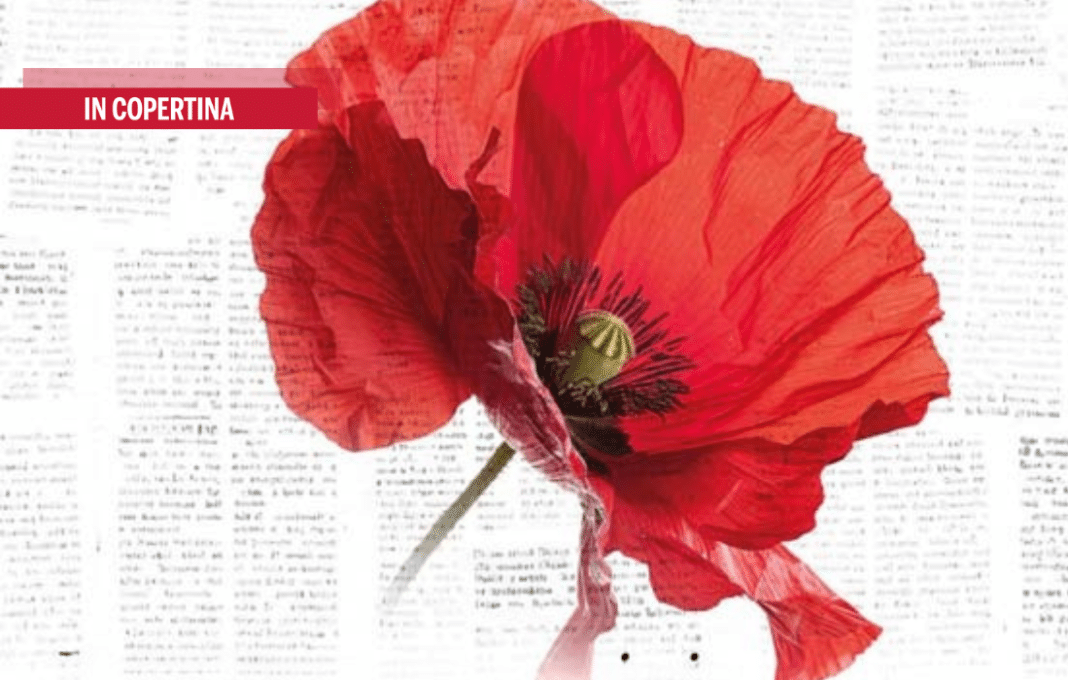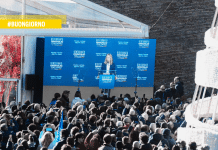L'istante, l’effimero, l’immediato lo ghermiscono [il presente, ndr] e solo l’amnesia può essere la sua sorte. Questi sono i tratti del presente multiforme e multivoco: un presente mostro. Nello stesso tempo è tutto (non c’è che il presente) e quasi niente (la tirannia dell’immediato). “Allora lo spirito non guarda né avanti né indietro. Il presente solo è la nostra felicità”, basta far ascoltare una nuova volta i versi del Secondo Faust per capire che questo presentismo non è, o non è più, il nostro. Noi, al contrario, non cessiamo di guardare in avanti e indietro, ma senza uscire da un presente di cui abbiamo fatto il nostro solo orizzonte»
Con queste parole François Hartog, nel suo Regimi di storicità (2003), designava quel particolare “ordine del tempo”, che segna il mondo contemporaneo, con il termine “presentismo”. Diversamente da quanto accaduto nelle epoche trascorse, in cui il presente era letto e vissuto a partire dal passato (come nell’Umanesimo-Rinascimento) oppure si proiettava in un futuro gravido di certezze (nell’Ottocento e fino a buona parte del XX secolo) oggi, sosteneva lo storico francese, siamo immersi in un tempo “fermo”, in cui «tutto avviene come se non ci fosse che il presente, sorta di vasta estensione di acqua che agita un incessante sciabordio»: i legami con il passato faticano ad acquisire un senso che oltrepassi la memoria - individuale o pubblica che sia - la capacità di immaginare il domani è tutta schiacciata sul “qui e ora”. Come falene che si agitano intorno al lume di una lampadina fioca, ci muoviamo inquieti andando avanti e indietro sul grande oceano della storia, alla ricerca di radici che “sappiamo” non esistere più, rappresentandoci un futuro che “diciamo” non sarà mai. E il grande oceano assume l’aspetto di un piccolo lago di acqua stagnante.
Questo articolo è riservato agli abbonati
Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivista
Se sei già abbonato effettua il login