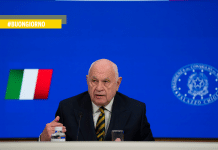Se già c’era stato qualcosa di ambiguo nell’invito a scendere in piazza “per l’Europa” del 15 marzo scorso – lanciato da Michele Serra e dal giornale Repubblica e raccolto dalle forze politiche del centro-sinistra, da organizzazioni sindacali, associazioni e singoli individui, che sono tutti andati con le motivazioni più varie – la manifestazione ha poi rivelato come fosse una chiamata in favore del riarmo, dell’idea che siamo minacciati e dobbiamo quindi prepararci a difenderci (con buona pace dei tanti “no war” presenti). L’adunata ha così avuto due effetti, dentro e fuori la piazza.
Il primo è stato quello di evidenziare tanto la contrapposizione tra i sostenitori del “riarmo” e i suoi oppositori, ma anche tra chi sostiene la necessità di una difesa “comune” e chi, invece, guarda con favore al riarmo dei singoli Paesi membri. L’appello alla piazza ha infatti coinciso con la decisione di Ursula Von der Leyen di procedere con il piano ReArm Europe che prevede l’aumento fino a 800 miliardi di euro della spesa militare dei Paesi membri – fuori dai vincoli del patto di stabilità – senza affrontare il tema della difesa comune.
I Paesi europei, però, già sono tra quelli che più spendono in armamenti nel mondo. Secondo i dati di fonte Nato, i Paesi membri europei hanno destinato nel solo 2024 ben 470 miliardi di dollari alla spesa militare – contro i 968 degli Usa e i 146 della Russia –, in aumento per il decimo anno consecutivo, di cui 86 della Germania (è il secondo Paese Nato per ammontare), 81 del Regno Unito e 64 della Francia. Consentire un aumento della spesa dei singoli Paesi fino a 800 miliardi, ovvero il triplo del valore annuale attuale – è stato fatto notare – non contribuisce alla spesa “comune” della UE che, se davvero fosse rafforzata, potrebbe portare ad un risparmio per i singoli Paesi. Il problema, però, è che non esiste uno Stato Europeo e dire “Rearm Europe” è insensato e dunque ognuno farà da sé, a cominciare dalla Germania, l’unico Paese che può ampliare il suo debito oltre misura.
Così, quella stessa Germania, che nell’originario atlantismo postbellico andava imbrigliata, riemerge ora con serie mire egemoniche – già avviate con Scholz (100 miliardi di euro, tre giorni dopo l’invasione dell’Ucraina) –per riprendersi quella supremazia economico-finanziaria, imposta con i vincoli del patto di stabilità e poi con l’austerity che era stata narrata come un grande successo dell’euro e del “whatever it takes”. Seppellendo definitivamente Willy Brandt e la sua Ostpolitik che aveva contribuito alla distensione e che era culminata nella Conferenza per la sicurezza in Europa di Helsinki il cui Atto finale obbligava i firmatari, tra cui Usa e Urss, al rispetto dei confini, alla soluzione pacifica dei conflitti, alla non ingerenza nei reciproci affari interni, alla difesa dei diritti umani.
Se l’Atto fosse stato applicato avrebbe sostituito la Nato, quando nel 1991 furono sciolti Patto di Varsavia e Unione Sovietica. Gli occidentali avrebbero protetto le minoranze russe nell’Europa post-sovietica (nei Baltici, in Ucraina, in Georgia), ma così non fu. La lingua e i diritti dei russi sono oggi calpestati da Kiev come nei Baltici: il 25% della popolazione lettone è russa e così si dica per il 24% degli estoni e il 4,5% dei lituani.
Dal momento che l’Europa non esiste, proporre una difesa comune, peraltro, è solo sviare. Come si può avere una difesa “comune” senza uno Stato “comune”, senza un’entità governativa democratica comune?
Il secondo effetto è stato quello di chiamare a raccolta in una generica manifestazione «a favore dell’Europa» forze e sigle varie sulla base di motivazioni anche molto diverse, unite sotto la bandiera blu stellata, evidenziando, nelle declamazioni fatte dal palco, un europeismo di maniera, retorico e, a tratti, suprematista, lontano dalle premesse egalitarie, sociali e inclusive – anche se spesso solo di facciata – che avevano caratterizzato lo sforzo per «restare in Europa» che, dall’adesione al trattato di Maastricht nel 1992 all’entrata in vigore dell’euro, avevano contraddistinto l’europeismo del centro-sinistra.
Certo, i tempi sono cambiati, ma non solo per la sciagurata postura iper-atlantista assunta sulla vicenda ucraina, quanto perché da allora ci sono stati la crisi del 2008, quella greca e del debito sovrano, cui l’UE ha sempre opposto il rigorismo dell’austerity, per fare un’eccezione solo in occasione della pandemia, e che il centro-sinistra ha duramente pagato in termini di consensi per la sua ostinata adesione al dictum ordo-liberista proveniente da Brussels. Essere europeisti oggi – in quello “spirito” di Ventotene tanto sbandierato – dovrebbe voler dire no tanto al riarmo che al neoliberismo. E ad ogni mira egemonica. Perché Europa ha voluto dire colonialismo e imperialismo, fino ai giorni nostri.
Perché non solo furono europei fascismo e nazismo. Furono europei gli sterminatori prediletti dal dio maledetto della bibbia, in America Centrale come in Africa e Asia. Europeo fu Leopoldo del Belgio che si impossessò con la forza delle armi dell’immenso territorio del Congo, uccidendo milioni di indigeni (ma loro non vengono ricordati come lo sono le vittime della Shoah) come europei sono coloro che ancora oggi finanziano e armano le bande criminali che occupano Goma e l’est del Congo (non più belga) per rapinarne le risorse. Europea fu la Compagnia delle Indie Orientali di cui parlano William Dalrymple in Anarchia e Amitav Gosh ne La maledizione della noce moscata. Europei furono quelli che hanno impiccato Mossadeq, primo ministro iraniano che aveva nazionalizzato le compagnie petrolifere. Europei furono i mandanti dell’omicidio di Patrice Lumumba.
Eppure, dopo la Seconda guerra mondiale e, soprattutto, dopo che aveva preso piede l’idea di una unione doganale che sarebbe poi divenuta la Comunità Economica Europea e infine l’Unione Europea, avevamo creduto che si dovesse essere europeisti. Perché poteva voler dire rispetto dei diritti umani e sociali in un quadro democratico progressivo e di politiche redistributive. Nel suo Discours a la nation europeenne, nel 1933 Julien Benda aveva scritto che, se vogliamo fare l’Europa non dobbiamo partire da quel che siamo, ma da quello che vogliamo, perché non c’è un’identità europea, ma può esserci una volontà di essere europei.
Ma da Maastricht in poi l’Europa è stata lo strumento della libertà d’impresa – del capitale – contro il lavoro, del mercato, che non è mai “etico”, contro le istanze non economiche di equità e giustizia sociale. E la logica neoliberista ha prevalso, svuotando lo Stato e le politiche pubbliche, estendendo il dominio dell’economia e la logica concorrenziale e dell’efficienza in ogni campo, fino a svuotare la politica stessa. E la democrazia ha fallito, non proteggendo i non protetti, non tutelandone i diritti, emarginandoli. I quali non garantiti hanno finito per non credere più nella democrazia stessa e in quelli che li dovevano rappresentare.
Il consenso delle élite dominanti e dei partiti “progressisti” si è venuto restringendo. E per tutta risposta, con il prevalere di entità extra-statuali il potere è passato di mano. Non più ai governi, ma al capitale sovranazionale del tecno-capitalismo che della democrazia ora sembra volersi liberare, come un inutile orpello, e che oggi guarda con favore alle derive illiberali, autocratiche e totalitarie.
Perché chiamare ad una manifestazione di adesione in favore dell’Europa oggi? C’era forse qualcuno che si era espresso contro l’Europa? O forse, nonostante l’affermazione del contrario, la chiamata era proprio in favore dell’Europa del riarmo (al di là della questione ucraina)? Un riarmo che, in via di principio, non trova giustificazioni se non quelle, tutte da dimostrare, che Putin avrebbe “implicitamente” dichiarato guerra alla UE e che la Nato sarebbe in via di smantellamento, venendo così a mancare l’ombrello americano. Così, invece di andare in direzione di una difesa comune, in mancanza dell’ombrellone Nato si procederà con tanti “ombrellini” (difficile pensare che la Germania si farà mai proteggere dalla Francia).
Giorgia Meloni, poi, ci ha messo del suo, stravolgendo il messaggio del manifesto di Ventotene, contribuendo così a promuovere, per reazione, un’adesione all’Europa che finisce per mettere in secondo piano l’accettazione del piano di riarmo. Tuttavia, è proprio rifacendosi a quel manifesto, e all’Europa che in molti avevano desiderato, che sostenere l’Europa oggi dovrebbe significare auspicare un’unione pacifica, che promuove la coesistenza e la distensione, che stigmatizza l’operato di Israele e fa rispettare il diritto internazionale e le disposizioni dell’ONU, non la corsa al riarmo e alla contrapposizione militare. Non occorre rifarsi a Spinelli, Rossi e Colorni, peraltro, perché basterebbe richiamare Brandt, Palme, Pertini e Berlinguer per trovare riferimenti più vicini e attuali.
Che adesso i sindaci di Bologna e Firenze si propongano di rinnovare la chiamata a favore dell’Europa non contribuisce né all’europeismo né alla pace. Perché non chiarisce che l’Europa che vogliamo non è quella che va verso il riarmo e la guerra e nemmeno quella neoliberista ma quella, disattesa più volte, dell’equità e dell’inclusione, ponte tra mondi e culture, fautrice della distensione – non della deterrenza – e della coesistenza pacifica negoziata. Fare confusione sull’Europa, contrapponendo “europeisti” e “pacifisti” nuoce ad entrambe le cause e porta solo al “via libera” per l’opzione militare, la peggiore di tutte, che smentisce tanto l’europeismo originario che la causa della pace.