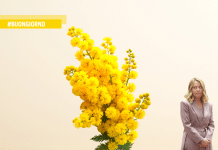Cinquant’anni dopo la legge 354 del 1975 – il cuore civile dell’esecuzione penale – il bilancio non può che essere negativo. Non perché quella riforma non avesse una propria forza innovatrice, ma perché la sua promessa è rimasta schiacciata sotto il peso di una macchina penitenziaria che ha continuato a operare secondo logiche estranee alla Costituzione. L’Ordinamento del ’75 nasceva per tradurre l’articolo 27 in prassi quotidiana: umanizzazione del trattamento (principio di personalizzazione della pena), centralità della persona detenuta, finalità rieducativa, controllo giurisdizionale sull’esecuzione. Un progetto ambizioso che i regolamenti successivi – da quello del 2000 al più recente tentativo di riscrittura – hanno tecnicizzato senza riuscire a farne realmente un dispositivo di garanzia, e che nel tempo è stato progressivamente svuotato da una legislazione penale speciale sempre più orientata all’eccezione, alla sicurezza e alla neutralizzazione.
La frattura fondamentale riguarda la pena come istituto giuridico. La teoria prevede un modello polivalente, capace di tenere insieme prevenzione, rieducazione e, in ultima istanza, difesa sociale. In pratica, ciò che si è imposto è una pena univoca: pura punizione, spesso in forme deteriori. Il carcere continua a operare come un dispositivo disciplinare nel senso foucaultiano, orientato al controllo dei corpi più che alla responsabilizzazione delle persone. L’esecuzione penale è diventata un segmento opaco dell’apparato punitivo, dove il diritto si indebolisce fino a dissolversi nella prassi amministrativa e dove la discrezionalità dell’amministrazione finisce per sostituire la legalità costituzionale.
Sul piano tecnico-giuridico, i nodi sono evidenti: il sovraffollamento strutturale che rende inattuabile qualunque trattamento individualizzato; la cronica insufficienza dei servizi sanitari e psichiatrici; l’uso espansivo degli istituti differenziati, dal 41-bis alla sorveglianza particolare; la residualità delle misure alternative, spesso concesse non sulla base di un reale percorso trattamentale, ma per l’impossibilità materiale di tenere le persone dentro gli istituti. Anche il magistrato di sorveglianza, che avrebbe dovuto essere l’architrave delle garanzie, è rimasto intrappolato in una funzione amministrativa di gestione dell’emergenza più che in un vero controllo di legalità, mentre l’amministrazione penitenziaria ha consolidato un potere di fatto che spesso precede – e condiziona – la norma stessa.
l risultato è un sistema incapace di rieducare perché incapace prima di tutto di garantire diritti. Se la rieducazione è relazione, progetto, riconoscimento della soggettività, allora un carcere che produce isolamento, regressione e sofferenza inutile è costituzionalmente incompatibile. In cinquant’anni, l’Ordinamento penitenziario non è stato smentito dalle sue premesse, ma dalla realtà materiale degli istituti: strutture fatiscenti, personale insufficiente, trattamenti diseguali, accesso precario alla cultura, al lavoro, alla formazione. Tutto ciò che dovrebbe costituire il percorso rieducativo è diventato l’eccezione.
Il vero punto, oggi, è che la funzione della pena non corrisponde più alla sua rappresentazione giuridica. La Costituzione immagina un sistema finalizzato al reinserimento; la prassi perpetua un apparato di esclusione. L’Ordinamento penitenziario non è fallito perché troppo avanzato: è fallito perché non è mai stato pienamente applicato. Cinquant’anni dopo, resta una grande promessa disattesa, la prova tangibile che, in Italia, il diritto dell’esecuzione penale continua a vivere in uno spazio strettissimo tra la norma e la sua negazione quotidiana. Una distanza che non può più essere ignorata e che potrebbe, con buona volontà, aprire i terreni del diritto penale minimo, del superamento del modello classico della carcerazione, di una nuova relazione tra carcere e città, dove – tra lo spazio della pena e lo spazio della cittadinanza – si misura la maturità istituzionale di una comunità.Ma so già che queste parole cadranno nel silenzio: il carcere, da noi, resta la parte del diritto che nessuno vuole guardare.
Disegno di Marilena Nardi