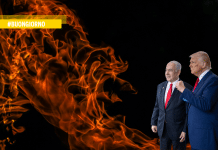Davide Enia è una figura centrale del teatro italiano contemporaneo: artista completo, unisce rigore narrativo e impegno etico, trasformando la scena in un luogo di forte emozione e riflessione civile. Con Autoritratto, Enia ha ricevuto due Premi Ubu 2025 – miglior attore/performer e miglior nuovo testo italiano – lo scorso 15 dicembre all’Arena del Sole di Bologna. Lo spettacolo affronta il trauma delle stragi di mafia, facendo della memoria un atto critico e politico, interrogando il rapporto tra storia, responsabilità e comunità.
Davide, il tuo Autoritratto attraversa un trauma che è insieme personale e collettivo. Prima di diventare spettacolo, il testo ha preso la forma del libro. Quanto è stata urgente questa scrittura e in che modo la doppia natura – letteraria e scenica – ha inciso sulla costruzione del racconto teatrale?
La prima scrittura viene dal corpo. Inizio le prove raccontando direttamente, usando quindi i gesti, gli sguardi, il movimento delle mani per ampliare lo spettro del racconto, per creare una partitura ritmica ripetibile, per fare emergere il sentiero emotivo. La scrittura per il teatro trova compimento proprio nel tempo della sua rappresentazione, così il mio modo di lavorare si configura come una scrittura in presa diretta che, prova dopo prova, si va progressivamente disidratando, rendendo essenziali le parole, fissandosi nella mia carne, diventando memoria narrativa ed emotiva. Il testo così si forma, si scolpisce e viene infine depositato nello spazio della pagina.
Nei tuoi lavori il teatro è un atto di responsabilità, non solo di rappresentazione del dolore. Quanto è importante, per te, che un’opera come Autoritratto produca una presa di coscienza condivisa?
Il dispositivo teatro nasce, e poi perdura, come tentativo di dotarsi di una prospettiva durate una crisi del presente. L’incontro dei corpi, la vicinanza fisica, una comune ferita psichica: questa l’urgenza del teatro. Siccome è impossibile nominare la verità, è necessaria la mediazione artistica. Il duplice percorso, quello intimo e privato e quello collettivo e comunitario, sono le due mani con le quali il dispositivo teatro prova a suturare le ferite e a ricercare la gioia. Riconoscersi come parte di un insieme aiuta a ricalibrare l’entità del dolore, o l’ampiezza dell’emozione. È una risposta di cura alla violenza della guerra.
In Italia-Brasile 3 a 2 (2002, ripreso nel 2022), che ti valse il primo Premio Ubu nel 2003, il racconto sportivo diventa racconto di una comunità. Il lavoro sui personaggi è centrale: come hai costruito le singole voci sceniche per trasformare storie individuali in quel tessuto emotivo?
Per me un testo è una sinfonia, con ritmi, melodie, armonie che tornano, si nascondono, riaffiorano. Per creare questa polifonia è necessario ascoltare le voci delle assenze, nel caso in essere le persone che erano nel tinello palermitano dell’82. Alcuni di loro, i miei genitori, mio zio Beppe, le avevo chiarissime, altre erano una suggestione di allora, come Bruno Curcurù, carissimo amico di papà morto troppo giovane. Ma il tempo è un cerchio, e tornare indietro ai miei otto anni mi ha rimesso nella possibilità di dialogare con queste assenze che diventano presenza nella pratica della scena, affidandomi a loro, abbandonandomi a quello che mi dissero nel passato perché le loro parole tornassero, replica dopo replica, a rilucere nel presente. Questo lavoro sinfonico apre alla moltitudine della collettività, alla fine l’appartamento di casa dei miei a Palermo diventa ogni appartamento d’Italia, perché il vero legante di quella esperienza sta nella condivisione della gioia, nell’ansia comune vissuta durante la partita, nella potenza liberatrice della vittoria. Non dimentichiamo mai le due ali del teatro: una è la tragedia, l’altra è la commedia. Sforzarsi di essere felici è tanto importante quando affrontare i traumi.
Con L’abisso, Premio Ubu 2019, hai affrontato memoria, perdita e identità, mettendo al centro il Mediterraneo come spazio politico e umano. In Autoritratto, quali strumenti narrativi, ritmici o poetici hai ritrovato – o sentito il bisogno di reinventare – per confrontarti con il trauma legato a Cosa Nostra, senza ridurlo a racconto simbolico o consolatorio?
Il bisogno primario è quello della nominazione di ciò che ferisce e fa male. L’abisso è figlio della terapia, di quel particolare rimbalzo dialettico che ti insegna a dire le cose cercando di calibrarle sempre meglio, prendendo coscienza progressiva delle ferite, dei traumi, iniziando a riequilibrarsi. Ma è la parola lo spiraglio da cui filtra la luce. Sono o non sono odiati, nelle organizzazioni criminali, le persone che parlano? Per superare il trauma, individuale e collettivo, penso ai nostri palermitanissimi anni Ottanta, pieni di morti ammazzati per strada, e alle ferocissime bombe del ’92, credo sia necessaria una operazione di autoanalisi per iniziare a raccontare cosa si è provato, cosa si è visto, come ci si è sentiti. Questa è al contempo una operazione individuale di slatentizzazione del trauma e una operazione comunitaria e plurale di cicatrizzazione delle ferite. Certo, il Paese che abitiamo è maledetto dalla Madonna: non viene mai desecretato nulla, ancora oggi non abbiamo una verità su Ustica e il nostro presidente della Repubblica ancora non sa chi gli ha ammazzato il fratello, tre esempi per indicare come in Italia esista un problema sistemico e non ci sia nessuna volontà politica né di risolverlo, né di affrontarlo per davvero.
Parola, corpo, ritmo e dialetto sono certamente per te elementi fondanti. Pensi che il teatro possa essere anche una forma di educazione emotiva e politica, soprattutto per le nuove generazioni?
Il teatro è una palestra emotiva innanzitutto per chi lo pratica: entrare nella logica e nella pratica del rituale, apprendere la ripetizione, dimenticare se stessi e obliare il proprio presente per essere pienamente ciò che si mostra in scena. Incarnare il paradosso del totale abbandono e del pieno controllo, contemporaneamente. La dimensione più importante, a mio avviso, è l’incontro dei corpi, il trovarsi fisicamente a respirare in una stessa sala, o scantinato, o centro sociale, o stanza, non importa. Il teatro è dato dall’insieme di pubblico, spazio scenico, mediazione artistica e quell’indicibile mistero che, quando accade, ha un impatto nella carne: brividi, risate, emozione, eccitazione, dolore. Il dato da cui partire, quindi, è tutto legato all’elemento politico per eccellenza del contemporaneo: il corpo. Stando così le cose, portando quindi i corpi nei luoghi della rappresentazione, il teatro conferma la sua origine politica.
In questa prospettiva, quale ruolo può avere il teatro civile nel percorso formativo dei più giovani? Quanto è importante che la scuola lo riconosca come spazio creativo, critico e di costruzione della memoria?
I giovani credo debbano arrivare al teatro in santa pace, senza forzature. Se a me mi avessero costretto a scuola ad andare a teatro, avrei fatto come un pazzo, per una ansia di rivolta sicuramente stimmate di immaturità eppure presentissima. Piuttosto, le scuole dovrebbero fare leva su quelle persone che hanno per motivi imperscrutabili passione per il teatro, e cercare a poco a poco di coinvolgere altri ragazzi a partire dai loro racconti. È poi necessario che venga fin da subito riconosciuto come un lavoro, con ritmi, orari, pratiche precise e rigorose. Sarebbe altresì importante che in qualche modo ci fosse una sorta di corso per imparare e leggere gli spettacoli, capire il perché di alcuni segni sulla scena, che vanno dal vuoto al disegno delle luci, dallo stare dei corpi ai costumi. Questo credo che manchi, onestamente. Sul tema della memoria, invece, il discorso è più complesso. Il teatro non serve a mantenere la memoria, serve a dotarsi di una prospettiva. La memoria è una attività, spiace dirlo, sopravvalutata. È usata a singhiozzo, in maniera strumentale, si omette, si distorce, mentre si sta perpetrando un genocidio, è in nome dei torti subiti in passato che scoppiano le guerre, che continua ad alimentarsi la fiamma dell’odio. Ci sarebbe bisogno per davvero di una amnesia totale e completa dell’intero genere umano, per ripartire senza più memoria, in un presente scevro di rivendicazioni.
Essere palermitano attraversa profondamente il tuo immaginario. Raccontare la Sicilia e le sue ferite è per te un atto identitario, politico, o una necessità narrativa che continuerà a orientare il tuo lavoro futuro?
La Sicilia è per me la lingua della culla, è la costruzione simbolica, è il mio egoistico e autoreferenziale tentativo di comprensione del linguaggio che mi ha strutturato come persona, è la possibilità di continuare ad ascoltare tutte le mie assenze, e di cantare con loro.