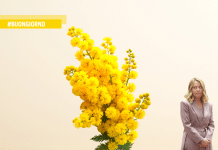Negli ultimi venti giorni Minneapolis è diventata un terreno di scontro tra comunità locali e forze federali statunitensi incaricate dell’applicazione delle leggi sull’immigrazione. Il 24 gennaio un uomo di 37 anni, Alex Pretti, è stato ucciso da agenti federali durante un’operazione nel quadrante sud della città. Secondo la versione ufficiale del Dipartimento della Sicurezza Interna, Pretti si sarebbe avvicinato ai membri della U.S. Border Patrol armato di una pistola e avrebbe opposto resistenza, inducendo un agente a sparare in “legittima difesa”. Ma filmati verificati mostrano Pretti con un telefono in mano mentre aiuta persone colpite da gas spray, prima di essere spinto a terra da più agenti e colpito da numerosi proiettili: una dinamica che contraddice in modo significativo l’interpretazione ufficiale dei fatti.
E’ la seconda uccisione compiuta dall’Ice in poche settimane, dopo quella di Renee Good, 37 anni, madre di tre figli, colpita il 7 gennaio da un agente dell’Ice durante un controllo federale. Secondo l’esame autoptico e diverse testimonianze, Good è stata raggiunta da tre colpi, tra cui uno alla testa, mentre si trovava in auto; la versione di un tentativo di speronamento diffusa dall’amministrazione è contestata da video e testimoni oculari.
In mezzo a questi casi, anche minorenni sono stati fermati e trasferiti in centri di detenzione a centinaia di chilometri di distanza insieme ai genitori, durante operazioni mirate alla cattura di adulti. La foto di un bambino di cinque anni, identificato come Liam, con zainetto e giubbotto, ha suscitato indignazione internazionale. Le autorità federali sostengono che lasciarlo solo non fosse sicuro; critici, famiglie e associazioni per i diritti civili definiscono invece questa pratica inutile e profondamente traumatica.
Si tratta di eventi che si inseriscono in un contesto più ampio di progressiva militarizzazione e uso estensivo della forza da parte dell’Ice e di altre agenzie federali: arresti di massa, utilizzo di spray al peperoncino contro manifestanti e residenti, operazioni condotte con modalità tipiche dell’ordine pubblico più che dell’amministrazione civile. Numerose sono state le critiche avanzate da organizzazioni come l’American Civil Liberties Union (Aclu, che ha chiesto il ritiro immediato degli agenti e l’apertura di indagini trasparenti sulle tecniche di intervento adottate.
Episodi che non possono essere liquidati come anomalie isolate. Da mesi, inchieste giornalistiche – in particolare di ProPublica, ma anche di altre importanti testate statunitensi – documentano l’esistenza di una pratica sistemica fatta di abusi, arresti arbitrari, uso eccessivo della forza, opacità procedurale e grave carenza di accountability all’interno delle agenzie federali per l’immigrazione, Ice in primis. Detenzioni prive di adeguate garanzie, persone trasferite per migliaia di chilometri senza reali possibilità di difesa, famiglie separate, minori coinvolti in operazioni che nulla hanno a che vedere con la tutela dell’infanzia: un sistema che nel tempo si è spostato da una logica amministrativa a una logica apertamente securitaria e repressiva.
E allora la domanda non è solo cosa stia accadendo a Minneapolis. La domanda vera è: ci riguarda? Sì, ci riguarda eccome. Ci riguarda perché qui non è in gioco soltanto la politica migratoria statunitense, ma un modello di governo della sicurezza che può essere esportato ovunque: forze dotate di poteri ampi, controlli deboli, uso della forza normalizzato, emergenza permanente elevata a giustificazione politica. Ci riguarda perché tocca il nodo universale del rapporto tra Stato e cittadino, tra autorità e diritti, tra legalità formale e giustizia sostanziale. Ci riguarda perché mostra cosa accade quando la gestione della complessità sociale viene ridotta a un problema di ordine pubblico.
Minneapolis non è lontana. Non è un’anomalia americana. È un paradigma che ci interroga su quale idea di sicurezza vogliamo costruire: una sicurezza fondata sulla forza, sulla paura e sulla repressione, oppure una sicurezza fondata sul diritto, sulla proporzionalità e sulla dignità delle persone. Ed è per questo che sì, ci riguarda. Non per solidarietà emotiva, ma per responsabilità politica e civile. Perché ciò che oggi viene normalizzato lì, domani può diventare prassi ovunque.