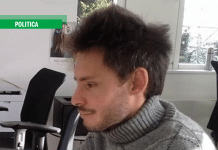«Mai come in queste ore a Gaza il senso di appartenere a una comune “umanita” si sta mostrando più vuoto di senso. La responsabilità di questo è del governo israeliano», dice Ruba Salih antropologa dell’università di Bologna che abbiamo intervistato mentre cresce la preoccupazione per la spirale di violenza che colpisce la popolazione civile palestinese e israeliana.
Quali sono state le sue prime reazioni, sentimenti, pensieri di fronte all’attacco di Hamas e poi all’annuncio dell’assedio di Gaza messo in atto dal governo israeliano?
Il 7 ottobre la prima reazione è stata di incredulità alla vista della recinzione metallica di Gaza sfondata, e alla vista dei palestinesi che volavano con i parapendii presagendo una sorta di fine dell’assedio. Ho avuto la sensazione di assistere a qualcosa che non aveva precedenti nella storia recente. Come era possibile che l’esercito più potente del mondo potesse essere sfidato e colto così alla sprovvista? In seguito, ho cominciato a chiamare amici e parenti, in Cisgiordania, Gaza, Stati Uniti, Giordania. Fino ad allora si aveva solo la notizia della cattura di un numero imprecisato di soldati israeliani. Ho pensato che fosse una tattica per fare uno scambio di prigionieri. Ci sono più di 5000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane e 1200 in detenzione amministrativa, senza processo o accusa. Poi sono cominciate da domenica ad arrivare le notizie di uccisioni e morti di civili israeliani, a cui è seguito l’annuncio di ‘guerra totale’ del governo di Netanyahu. Da allora il sentimento è cambiato. Ora grande tristezza per la quantità di vittime, dell’una e dell’altra parte, e preoccupazione e angoscia senza precedenti per le sorti della popolazione civile di Gaza, che in queste ore sta vivendo le ore piu’ drammatiche che si possano ricordare.
E quando ha visto quello che succedeva, con tantissime vittime israeliane, violenze terribili, immagini di distruzione, minacce di radere al suolo Gaza?
Colleghi e amici israeliani hanno cominciato a postare immagini di amici e amiche uccisi – anche attivisti contro l’occupazione- e ho cominciato dolorosamente a mandare condoglianze. Contemporaneamente giungevano terribili parole del ministro della Difesa israeliano Gallant che definiva i palestinesi “animali umani”, dichiarando di voler annientare la striscia di Gaza e ridurla a “deserto”. Ho cominciato a chiamare amici di Gaza per sapere delle loro famiglie nella speranza che fossero ancora tutti vivi. Piano piano ho cominciato a cercare di mettere insieme i pezzi e dare una cornice di senso a quello che stava succedendo.
Cosa può dirci di Gaza che già prima dell’attacco di Hamas era una prigione a cielo aperto?
Si, Gaza è una prigione. A Gaza la maggior parte della popolazione è molto giovane, e in pochi hanno visto il mondo oltre il muro di recinzione. Due terzi della popolazione è composto da famiglie di rifugiati del 1948. Il loro vissuto è per lo più quello di una lunga storia di violenza coloniale e di un durissimo assedio negli ultimi 15 anni. Possiamo cercare di immaginare cosa significa vivere questo trauma che si protrae da generazioni. Gli abitanti di Gaza nati prima del 1948 vivevano in 247 villaggi nel sud della Palestina, il 50% del paese. Sono stati costretti a riparare in campi profughi a seguito della distruzione o occupazione dei loro villaggi. Ora vivono in un’area che rappresenta l’1.3% della Palestina storica con una densità di 7000 persone per chilometro quadrato e le loro terre originarie si trovano a pochi metri di là dal muro di assedio, abitate da israeliani.
E oggi?
Chi vive a Gaza si descrive come in una morte lenta, in una privazione del presente e della capacità di immaginare il futuro. Il 90% dell’acqua non è potabile, il 60% della popolazione è senza lavoro, l’80% riceve aiuti umanitari per sopravvivere e il 40% vive al di sotto della soglia di povertà: tutto questo a causa dell’ occupazione e dell’assedio degli ultimi 15 anni. Non c’è quasi famiglia che non abbia avuto vittime, i bombardamenti hanno raso al suolo interi quartieri della striscia almeno quattro volte nel giro di una decina di anni. Non credo ci sia una situazione analoga in nessun altro posto del mondo. Una situazione che sarebbe risolta se Israele rispettasse il diritto internazionale, né più né meno.
Prima di questa escalation di violenza c’era voglia di reagire, di vivere, di creare, di fare musica...
Certo, anche in condizioni di privazione della liberta’ c’e’ una straordinaria capacità di sopravvivenza, creatività, amore per la propria gente. Tra l’altro ricordo di avere letto nei diari di Marek Edelman sul Ghetto di Varsavia che durante l’assedio del Ghetto ci si innamorava intensamente come antidoto alla disperazione. A questo proposito, consilgio a tutti di leggere The Ghetto Fights di Edelman. Aiuta molto a capire cosa è Gaza in questo momento, senza trascurare gli ovvi distinguo storici.
Puoi spiegarci meglio?
Come sapete il ghetto era chiuso al mondo esterno, il cibo entrava in quantità ridottissime e la morte per fame era la fine di molti. Oggi lo scenario di Gaza, mentre parliamo, è che non c’è elettricità, il cibo sta per finire, centinaia di malati e neonati attaccati alle macchine mediche hanno forse qualche ora di sopravvivenza. Il governo israeliano sta bombardando interi palazzi, le vittime sono per più della metà bambini. In queste ultime ore la popolazione si trova a dovere decidere se morire sotto le bombe in casa o sotto le bombe in strada, dato che il governo israeliano ha intimato a un milione e centomila abitanti di andarsene. Andare dove? E come nel ghetto la popolazione di Gaza è definita criminale e terrorista.
Anche Franz Fanon, lei suggerisce, aiuta a capire cosa è Gaza.
Certamente, come ho scritto recentemente, Fanon ci viene in aiuto con la forza della sua analisi della ferita della violenza coloniale come menomazione psichica oltre che fisica, e come privazione della dimensione di interezza del soggetto umano libero, che si manifesta come un trauma, anche intergenerazionale. La violenza prolungata penetra nelle menti e nei corpi, crea una sospensione delle cornici di senso e delle sensibilità che sono prerogativa di chi vive in contesti di pace e benessere. Immaginiamoci ora un luogo, come Gaza, dove come un rapporto di Save the Children ha riportato, come conseguenza di 15 anni di assedio e blocco, 4 bambini su 5 riportano un vissuto di depressione, paura e lutto. Il rapporto ci dice che vi è stato un aumento vertiginoso di bambini che pensano al suicidio (il 50%) o che praticano forme di autolesionismo. Tuttavia, tutto questo e’ ieri. Domani non so come ci sveglieremo, noi che abbiamo il privilegio di poterci risvegliare, da questo incubo. Cosa resterà della popolazione civile di Gaza, donne, uomini bambini.
Come legge il sostegno incondizionato al governo israeliano di cui sono pieni i giornali occidentali e dell’invio di armi ( in primis dagli Usa), in un’ottica di vittoria sconfitta che abbiamo già visto all’opera per la guerra Russia-Ucraina?
A Gaza si sta consumando un crimine contro l’umanità di dimensioni e proporzioni enormi mentre i media continuano a gettare benzina sul fuoco pubblicando notizie in prima pagina di decapitazioni e stupri, peraltro non confermate neanche dallo stesso esercito israeliano. Tuttavia, non utilizzerei definizioni statiche e omogeneizzanti come quelle di ‘Occidente’ che in realtà appiattiscono i movimenti e le società civili sulle politiche dei governi, che in questo periodo sono per lo più a destra, nazionalisti xenofobi e populisti. Non è sempre stato così.
Va distinto il livello istituzionale, dei governi e dei partiti o dei media mainstream, da quello delle società civili e dei movimenti sociali?
Ci sono una miriade di manifestazioni di solidarietà ovunque nel mondo, che a fianco del lutto per le vittime civili sia israeliane che palestinesi, non smettono di invocare la fine della occupazione, come unica via per ristabilire qualcosa che si possa chiamare diritto (e diritti umani) in Palestina e Israele. Gli stessi media mainstream sono in diversi contesti molto più indipendenti che non in Italia. Per esempio, Bcc non ha accettato di piegarsi alle pressioni del governo rivendicando la sua indipendenza rifiutandosi di usare la parola ‘terrorismo’, considerata di parte, preferendo riferirsi a quei palestinesi che hanno sferrato gli attacchi come ‘combattenti’. Se sono stati commessi crimini contro l’umanità parti lo stabiliranno poi le inchieste dei tribunali penali internazionali. In Italia, la complicità dei media è invece particolarmente grave e allarmante. Alcune delle (rare) voci critiche verso la politica del governo israeliano che per esempio esistono perfino sulla stampa liberal israeliana, come Haaretz, sarebbero in Italia accusate di anti-semitismo o incitamento al terrorismo! Ci tengo a sottolineare tuttavia che il fatto che ci sia un certo grado di libertà di pensiero e di stampa in Israele non significa che Israele sia una ‘democrazia’ o perlomeno non lo è certo nei confronti della popolazione palestinese. Che Israele pratichi un regime di apartheid nei confronti dei palestinesi è ormai riconosciuto da organizzazioni come Amnesty International e Human Rights Watch, nonché sottolineato a più riprese dalla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.
Dunque non è una novità degli ultimi giorni che venga interamente sposata la retorica israeliana?
Ma non è una novità degli ultimi giorni che venga interamente sposata la narrativa israeliana. Sono anni che i palestinesi sono disumanizzati, resi invisibili e travisati. Il paradosso è che mentre Israele sta violando il diritto e le convenzioni internazionali e agisce in totale impunità da decenni, tutte le forme di resistenza: non violente, civili, dimostrative, simboliche, legali dei palestinesi fino a questo momento sono state inascoltate, anzi la situazione sul terreno è sempre più invivibile. Persino organizzazioni che mappano la violazione dei diritti umani sono demonizzate e catalogate come ‘terroristiche’. Anche le indagini e le commissioni per valutare le violazioni delle regole di ingaggio dell’esercito sono condotte internamente col risultato che divengono solo esercizi procedurali vuoti di sostanza (come per l’assassinio della reporter Shereen AbuHakleh, rimasto impunito come quello degli altri 55 giornalisti uccisi dall’esercito israeliano). Ci dobbiamo seriamente domandare: che cosa rimane del senso vero delle parole e del diritto internazionale?
Il discorso pubblico è intriso di militarismo, di richiami alla guerra, all’arruolamento…
Personalmente non metterei sullo stesso piano la resistenza di un popolo colonizzato con il militarismo come progetto nazionalistico di espansione e profitto. Possiamo avere diversi orientamenti e non condividere le stesse strategie o tattiche ma la lotta anticoloniale non è la stessa cosa del militarismo legato a fini di affermazione di supremazia e dominio di altri popoli. Quella dei palestinesi è una lotta che si inscrive nella scia delle lotte di liberazione coloniali, non di espansione militare. La lotta palestinese si collega oggi alle lotte di giustizia razziale e di riconoscimento dei nativi americani e degli afro-americani contro società che oggi si definiscono liberali ma che sono nate da genocidi, schiavitù e oppressione razziale. Le faccio un esempio significativo: la prima bambina Lakota nata a Standing Rock durante le lunghe proteste contro la costruzione degli olelodotti in North Dakota, che stanno espropriando e distruggendo i terre dei nativi e inquinando le acque del Missouri, era avvolta nella Kuffyah palestinese. Peraltro, il nazionalismo non è più il solo quadro di riferimento. In Palestina si lotta per la propria casa, per la propria terra, per la liberazione dalla sopraffazione dell’occupazione, dalla prigionia, per l’autodeterminazione che per molti è immaginata o orientata verso la forma di uno stato laico binazionale, almeno fino agli eventi recenti. Domani non so come emergeremo da tutto questo.
Emerge di nuovo questa cultura patriarcale della guerra, a cui come femministe ci siamo sempre opposte…
Con i distinguo che ho appena fatto e che ribadisco – ossia che non si può mettere sullo stesso piano occupanti e occupati, colonialismo e anticolonialismo -mi sento comunque di dire che una mobilitazione trasversale che aneli alla fine della occupazione deve essere possibile. Nel passato, il movimento femminista internazionalista tentava di costruire ponti tra donne palestinesi e israeliane mobilitando il lutto di madri, sorelle e figlie delle vittime della violenza. Si pensava che questo fosse un legame primario che univa nella sofferenza, attraversando le differenze. Ci si appellava alla capacità delle donne di politicizzare la vulnerabilità, convinte che nella morte e nel lutto si fosse tutte uguali. La realtà è che la disumanizzazione dei palestinesi, rafforzata dalla continua e sempre più violenta repressione israeliana, rende impossibile il superamento delle divisioni in nome di una comune umanità. Mentre i morti israeliani vengono pubblicamente compianti e sono degni di lutto per il mondo intero, i palestinesi – definiti ‘terroristi’ (anche quando hanno praticato forme non-violente di resistenza), scudi-umani, animali (e non da oggi), sono già morti -privati della qualità di umani- prima ancora di morire, e inscritti in una diversa classe di vulnerabilità, di non essenza, di disumanità.
Antropologa dell’università di Bologna Ruba Salih si interessa di antropologia politica con particolare attenzione a migrazioni e diaspore postcoloniali, rifugiati, violenza e trauma coloniale, genere corpo e memoria. Più recentemente si è occupata di decolonizzazione del sapere e Antropocene e di politiche di intersezionalità nei movimenti di protesta anti e de-coloniali. Ha ricoperto vari ruoli istituzionali tra cui membro eletto del Board of Trustees del Arab Council for the Social Sciences, dal 2015 al 2019. È stata visiting professor presso varie istituzioni tra cui Brown University, University of Cambridge e Università di Venezia, Ca’ Foscari.