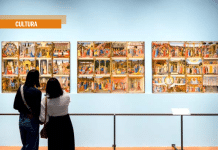Visitando la mostra al Maxxi di Roma a cura di Elisabeth Diller Architettura Instabile ho pensato a Alvar Aalto. Come se Aalto dopo aver creato il suo Edificio Finlandia in marmo di Carrara (un’opera che negò i presupposti naturalistici, romantici e organici della sua architettura) avesse organizzato una mostra per affermare la sua virata neoclassica. Elizabeth Diller infatti ci presenta oggi al MAXXI una mostra che è una giustificazione alla sua ultima grande opera a New York city: The Dock, un grande hangar semovente. Spieghiamoci meglio, Diller con il marito Riccardo Scofidio e Charles Renfro nel 2002, dopo un percorso all’interno del pensiero informatico in architettura, (come quello di Toyo Ito, Greg Lynn o Ben van Berkel) realizzò nel 2002 un capolavoro assoluto chiamato Thw Blur – l’edificio dell’Indeterminatezza, della nebbia, e della sfocatura. L’architettura di the Blur esprimeva una concezione rivoluzionaria che incorporava il paradigma informatico e offriva importanti linee evolutive ad una serie di relazioni come il rapporto tra informatica e natura, tra informazioni e nuovi edifici, tra mutabile e fisso. Non si trattava neanche esattamente di un edificio, ma di una continua mutazione atmosferica. Su uno piattaforma eretta come una palafitta migliaia di ugelli agganciati all’ossatura metallica nebulizzavano l’acqua del lago sottostante. L’operazione non era meccanica ma digitale e interattiva purché le variazioni delle situazioni ambientali erano catturate dai sensori che creavano algoitmicamente nebbia di diversa intensità al variare della luce del girono, della temperatura e del vento. L’architettura carica di sensori informatici e di dispositivi attuativi negli ugelli era diventava un corpo mutante e vivente in rapporto stretto con l’ambiente circostante.
Tutto l’opposto di quanto vediamo vent’anni dopo in The Dock. Si tratta di un progetto ispirato come i diceva al movimento di gru, piattaforme e carrelli lungo le banchine sullo Hudson. Un mondo che sembra uscito dai libri di Siegfried Giedion come Mechanization Takes comand del 1948 oppure Costruire in ferro, costruire in cemento del 1928 e rappresentato in innumerevoli cine giornali e in alcuni film ( come L’uomo con la macchina da presa, del 1929 di Dziga Vertov) e che ha ispirato un filone della pittura, basti pensare a Ferdinand Leger. The Dock è uno spazio spazio flessibile per performance, eventi culturali e artistici di norma tutti a pagamento. Rappresenta con l’adiacente torre The Vessel (ingabbiata oggi da una rete per evitare nuovi suicidi) quanto la città di New York abbia negoziato per consentire la costruzione dell’enorme intervento immobiliare di Hudson Yards (mezzo milione di metri quadri su quasi 6 ettari di terreno, ottenuti in parte con la realizzazione di una piattaforma sopra i binari ferroviari e in parte demolendo il quartiere storico di Hell’s Kitchen con rammarico e proteste della cittadinanza). All’interno di questo enorme progetto prendono quindi la luce due opere a destinazione “artistica” di cui una è appunto the Dock. L’architetto Diller (con Ricard Scofio + Renfro) stravolge la sua precedente ricerca per creare una sorta di macchina portuale semovente su dei binari che un poco come una scatola di fiammiferi si apre e si chiude a secondo delle circostanze. L’edificio permette di avere conformazioni estive o invernali con varie configurazioni dello spazio che sono forse un vantaggio dal punto di vista pratico, ma l’edificio risulta di rara aggressività se non di decisa bruttezza.
L’esposizione dedica a The Dock lo spazio centrale (con filmati, un plastico e l’album dei disegni esecutivi) e annulla quasi completamente anche nel resto delle opere l’idea che aveva mosso The Blur. “Architetture instabili” non ha nulla a che vedere con il paradigma informatico e con la ricerca di una architettura come sistema vivente. Infatti non è presente il lavoro di François Roche o di Philip Rahm, di Achim Menges o dei nostri Ecologic Studio. Il mostro dii acciaio su ruote di DS + R fa arretrare la ricerca su tutti i fronti compreso quello sulla sostenibilità: perché la questione non è se una architettura si muova o meno: la questione è la relazione tra la lettura dell’ambiente per via informatica e il conseguente adattamento del movimento di una architettura interattiva.
Retrocedendo la questione del movimento in architettura a un movimento puramente meccanico, Elisabeth Diller riscopre allora La villa del girasole (Angelo Invernizzi Marcialise) che si muove appunto su sistemi rotanti per seguire il sole realizzata negli anni 30, oppure l’opera di Cedric Price “The Fin Place” del 1961, progetto non realizzato ma che fu di ispirazione per il Centro Pompidou di Parigi. Alcuni modelli nella mostra sono effettivamente semoventi, come il grande parco di Ombrelli a Medina, altri modelli come lo stesso The Dock, o diaframmi che si aprono e chiudono al variare della luce del Centro della cultura araba di Jean Nouvel a Parigi sono presenti ma tristemente immobili. Elisabeth Diller negli anni Novanta dello scorso secolo fu nota per avere realizzate installazioni per esposizioni della più grande efficacia spaziale e concettuale (Vedi A. MArotta, Diller+ Scofidio Il teatro della dissolvenza, Edilstampa 2005) invece in questo caso siamo di fronte a un lavoro di installazione deludente, delegato a delle grandi tende in movimento su binari sul soffitto. Nonostante il costo e la coerenza con il tema, lasciano gli spettatori indifferenti e non emozionano più del tirare la tenda della doccia la mattina. In mostra anche opere che rappresentano poco più di una curiosità come il carrello telescopico per dormire, la struttura pneumatica come ufficio mobile, o che appartengono alla meccanizzazione industriale se non all’ingegneria, come il Salvataggio dei Templi egiziani di Nubia negli anni Sessanta. Eppure in un MAXXI pressoché deserto esso stesso, con mostre tutte in allestimento, questa esposizione rappresenta la sola occasione di rilevo aperta. Il libro che accompagna la mostra ha lo stesso titolo Architettura instabile a cura di Pippo Ciorra e Maddalena Scimemi non ne è affatto un mero catalogo ma uno strumento indipendente di riflessione.
L’autore: Antonino Saggio è un teorico e storico dell’architettura, saggista ed editore