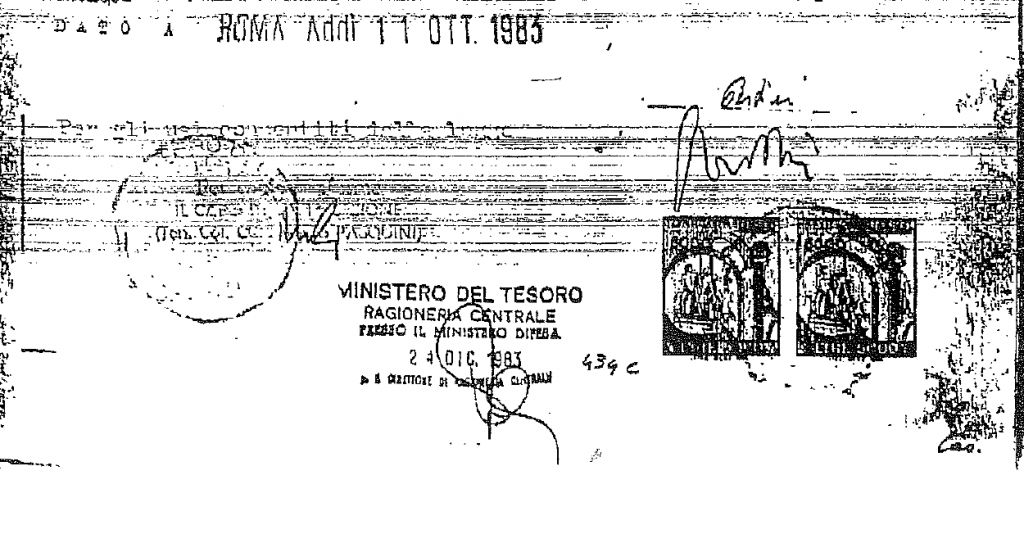Oggi lo sentite in maniera ossessiva nella pubblicità della Serie A che utilizza “Monkey Man” nella versione degli Specials come jingle. Ma nei primissimi anni 80 lo ska è stato la colonna sonora delle rivolte giovanili e dei ghetti della Gran Bretagna contro l’avvento e il trionfo di Margaret Thatcher – assieme a certo punk e persino a un po’ di New Wave.
A differenza dei sintetizzatori dei Depeche Mode, e dei mille gruppi non sopravvissuti a quegli anni, che bandivano le chitarre e sancivano il trionfo delle tastiere per qualche anno, le band ska e la 2 Tone records segnavano una rivoluzione, non tanto musicale, ma culturale: The Specials, The Selecter, The Beat e, più famosi e longevi di tutti, i Madness, erano le prime band che suonavano per bianchi e neri assieme. O meglio, la prima sottocultura che univa i figli della working class e i neri, che in Gran Bretagna, fino ad allora, non avevano mai condiviso un terreno comune. Era l’epoca degli skinheads e dei rasta che vanno agli stessi concerti e partecipano agli stessi scontri con la polizia. Di lì a poco arriverà la rivoluzione thatcheriana e spazzerà via anche loro.

Lo ska di quegli anni fondeva assieme la tradizione nera arrivata dall’isola caraibica negli anni 60, impegno politico, nel senso di una narrazione della vita di tutti i giorni della working class britannica, e uno stile destinato a durare nel tempo – il bianco e nero, le Dr. Martens, le giacche e cravatte strette, a imitare i cantanti giamaicani dei Sessanta, dagli Skatalites a Desmond Dekker, a Laurel Aitken. Lo ska era in tutto e per tutto musica politica che raccoglieva con spirito allegro il testimone del punk e trasmetteva un messaggio un po’ amaro, ma senza eccessi di nichilismo. Prima che il fenomeno skinhead venisse identificato – per errore – con i naziskin degli anni 90.
A fare la storia di questo genere c’era poi una casa discografica indipendente, la 2 Tone, appunto, fondata dagli Specials di Coventry, che nel 1979 portò tre singoli nella Top Ten, partendo dai concerti sul retro dei pub. Il logo-simbolo della 2 Tone era Walt Jabsco, l’omino in bianco e nero qui accanto, che rappresentava in qualche modo le radici bianche e nere dell’etichetta e del movimento ska.
portò tre singoli nella Top Ten, partendo dai concerti sul retro dei pub. Il logo-simbolo della 2 Tone era Walt Jabsco, l’omino in bianco e nero qui accanto, che rappresentava in qualche modo le radici bianche e nere dell’etichetta e del movimento ska.
Di quella ondata rapida e di successo che ha prodotto una serie infinita di hit capaci di entrarti in testa e non abbandonarti più, facevano parte anche The Beat. The Beat che tra il 1980 e il 1983 scalavano le classifiche con “Mirror in the bathroom”, “Ranking full stop”, “Tears of a clown” (una cover del classico di Smokey Robinson) e che oggi tornano con un nuovo disco: Bounce. Un misto tra il sound di quegli anni e del reggae più classico. L’album tocca i suoi punti migliori quando riprende i suoni, specie un sax rotondo e profondo, tipici dei successi che portarono i Beat a riempire stadi per qualche anno.
Mirror in the bathroom e Tears of a clown: quando The Beat scalavano la Top of the Pops
Il disco è suonato bene, arrangiato in maniera pulita e non sembra essere figlio di una band vecchia di 30 anni. A dire il vero non lo è: come nei Beat storici, che avevano un sassofonista dai capelli bianchi assieme allo stesso Roger, all’epoca poco più che adolescente, oggi è il figlio del sedicenne di allora a suonare con la band. Incursioni in terreno pop, come già nei dischi delle origini, reggae classico e probabilmente un ottimo live set sono quel che promette la band. Se non ricordate lo ska e la sua carica politica senza rabbia, ecco un buon punto da cui cominciare.
On the wrong side, uno dei tre singoli di Bounce