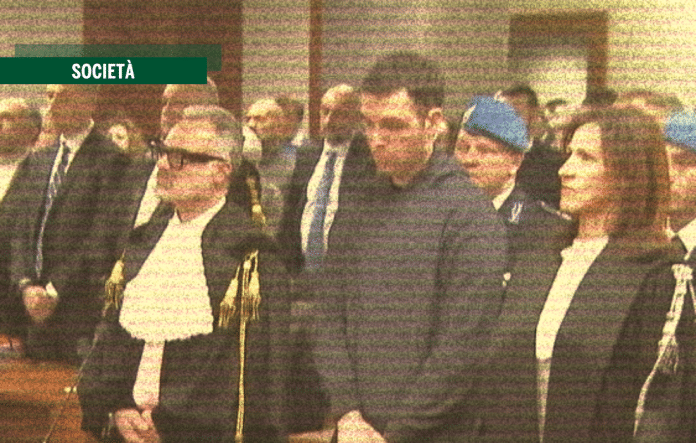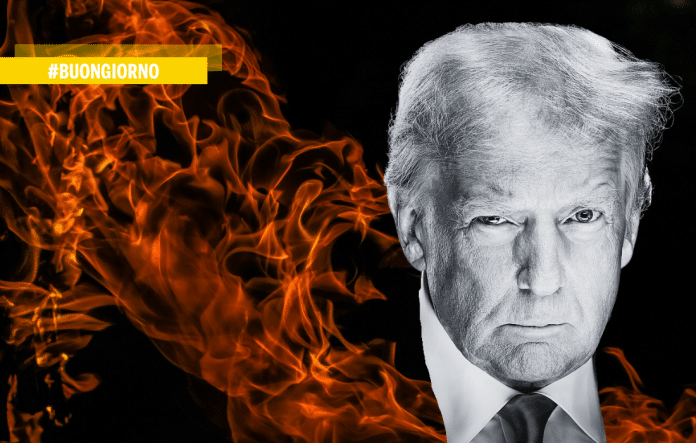Parlare del caso di Giulia Cecchettin risveglia, ogni volta, un dolore profondo. Un dolore forse necessario, perché è necessario parlare di femminicidio ed è necessario capire, se abbiamo la speranza che questo un giorno non si verifichi più. Il femminicidio è un fenomeno diffuso che ha legami fortissimi con l’idea del patriarcato ed è la ripetizione dell’eterna storia per cui una donna non si può separare da un uomo e realizzarsi dopo essersi separata da lui, e per questo viene da lui uccisa.
La sentenza dei giudici sull’assassino di Giulia Cecchettin risveglia e riattiva il dolore e l’orrore legato a questo caso.
La condanna al massimo della pena, l’ergastolo, che ha tenuto conto dell’aggravante della premeditazione, può avere un effetto rassicurante, che conferma il senso di fiducia in un sistema giudiziario in un certo modo ragionevole.
Il mancato riconoscimento dell’aggravante della crudeltà ha scatenato un dibattito mediatico che, personalmente, all’inizio mi ha lasciato perplessa. Comprendo umanamente l’indignazione della sorella, del padre e di migliaia di persone. Vista dalla prospettiva di Giulia la parola crudeltà definisce bene l’orrore, la tortura, la sevizia che l’ha investita e che ha dovuto subire per lunghissimi minuti. La sorella, il padre, migliaia di persone reagiscono con la propria sensibilità umana e i propri affetti e “vedono” e sentono questa crudeltà con gli occhi belli di Giulia.
I giudici non hanno rilevato alcuna premeditazione o volontà nel volere infliggere una sevizia o una tortura, per cui dal punto di vista giuridico (e ringrazio la collega che mi ha fornito l’articolo in cui veniva spiegato questo, ovvero il commento di Luciano Sesta su il Fatto quotidiano online del 9 aprile 2025) il concetto di crudeltà viene a mancare, e questo aggravante non può essere applicato.
Certamente i giudici devono fare il proprio lavoro e applicare il codice penale privi da qualsiasi influenza, anche politica o culturale e neppure quelle riguardanti le conseguenze mediatiche, politiche, culturali di una sentenza.
La faccenda dell’inesperienza continuava però a lasciarmi perplessa.
Mi sono chiesta se sia possibile che i giudici abbiano colto qualcosa e che poi, forse con la dizione “inesperienza”, la formulazione di questo qualcosa che avevano colto non sia stata precisa e puntuale, ma in qualche modo grossolana e fuorviante.
I giudici hanno certamente tentato di giudicare al meglio l’assassino.
È effettivamente molto difficile comprendere come un essere umano possa lucidamente premeditare e poi concretamente infliggere ad un altro essere umano un orrore di questo genere, senza che vi sia una intenzionalità “crudele” nel senso giuridico, cioè la volontà di indurre una tortura o una sevizia. Forse i giudici hanno colto negli occhi senza umanità dell’assassino di Giulia proprio questo. È estremamente difficile capirlo ed è estremamente raro, ma, a volte, alcuni esseri umani compiono atti crudeli e atroci senza che ci sia neppure l’ombra di sadismo, in un assetto di lucidità e di funzionamento della coscienza.
Questo non accade a persone sane, e neanche alla maggior parte delle persone affette da una patologia mentale; accade se c’è una malattia mentale gravissima che lede l’umanità presente sin dalla nascita in ognuno di noi fino al punto di quasi cancellarla completamente. Per uscire dalla perplessità e chiarirmi le idee su questo qualcosa di molto importante che possono aver colto i giudici, mi è stata molto utile la rilettura del paragrafo “La schizofrenia simplex” all’interno del capitolo ” l’indifferenza” del libro La marionetta e il burattino di Massimo Fagioli.
Scrive Fagioli: “Ormai indifferente al piacere e al dolore, egli, lo schizofrenico semplice è fuori, al di là del rapporto sadomasochistico. Può strapparsi da solo un’unghia e vivere la cosa come se si fosse tolto un capello fastidioso”. E ancora: “La percezione umana, di fronte allo schizofrenico semplice, è incerta, nebulosa”…”La percezione umana e il sapere la verità sono cimentati anche quando lo schizofrenico semplice viene ripreso da una crisi di pazzia”…”Raptus strano. Sembra arrabbiato e non è vero, sembra odiare e non è vero. È scena. Ma è pericoloso”…” La maschera maschera il non essere”…
Lungi, da psichiatra, dal voler fare perizie o tentare delle diagnosi a distanza. Da donna e cittadina studio e mi faccio delle domande e sento che queste parole possono essere di aiuto per capire. Perché è effettivamente difficilissimo capire l’annullamento dell’umano.
Da coautrice del libro Schizofrenia mi chiedo insieme ai coautori se parole come strano, bizzarro, fatuo, stolido e anaffettivo non siano più appropriate della parola “ inesperienza”.
L’autrice: Manuela Petrucci è MD Psychiatrist and PsychotherapistDr. med. Program Medical Psychology Section, Ulm UniversityAlbert-Einstein-Allee 7 89081 Ulm, Germany