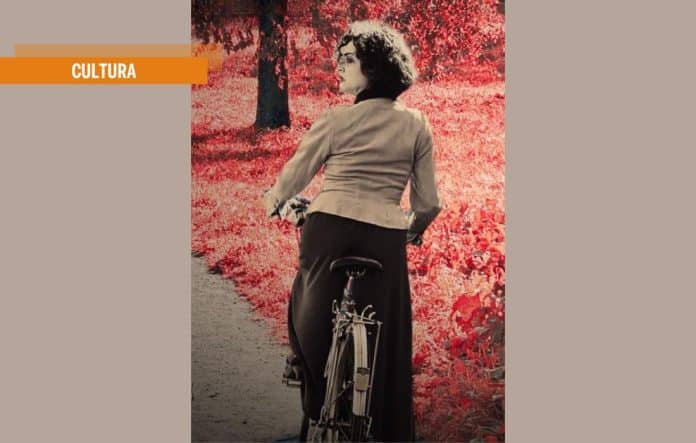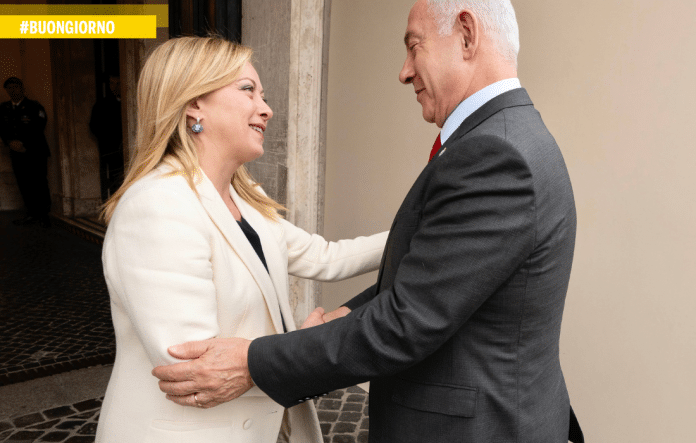«Stava uscendo, mi ha sorriso. Gli ho detto di non tornare tardi. Non è tornato più».
Yehia Elgaml non riesce a farsene una ragione. Sono passati quasi due mesi da quando suo figlio, Ramy, 19 anni, «non è tornato più».
Sono le 3:40 della notte di quel sabato 24 novembre 2024. Ramy viaggia sul T-Max guidato da Fares Bouzidi, 22 anni. La moto non si ferma a un posto di blocco delle forze dell’ordine. Tre vetture dei Carabinieri si lanciano all’inseguimento.
Siamo a Milano, in una notte tra sabato e domenica. C’è gente per strada. Tante auto, traffico, semafori che scattano. E una moto e tre Gazzelle (il nome con cui sono conosciute le auto dei Carabinieri) che sfrecciano. Per 8km, lunghissimi 20 minuti. Come fosse GTA. Ma non è un videogioco; è la vita reale.
Martedì 7 gennaio il Tg3, telegiornale della terza rete Rai, ne trasmette due lunghi minuti, ripresi da due telecamere comunali e dalle dashcam installate sulle Gazzelle dei carabinieri.
Alcune di quelle immagini erano già state rese pubbliche.
Giovedì 12 dicembre Dritto e Rovescio, trasmissione TV in onda sulla berlusconiana Rete 4, le aveva trasmesse con grande enfasi: «Esclusivo, il video della folle corsa del giovane immigrato Ramy».
“Immigrato” è la parola chiave. Disumanizzante. Sparata lì per sbattere il mostro in prima pagina. Ramy incarna alla perfezione il mostro che riempie da anni le narrazioni dell’ultradestra, mediatica e politica. Incarna il “nemico”: giovane, nato in Egitto, abitante di una delle periferie difficili delle metropoli italiane.
Il video trasmesso in quell’occasione non racconta tutto l’inseguimento. Si ferma prima della caduta, prima della morte di Ramy.
Il Tempo, quotidiano romano dell’ultradestra, di proprietà del parlamentare leghista e ras delle cliniche private Angelucci, l’indomani, 13 dicembre, potrà scrivere: «A giudicare dalle immagini – differenti da quelle che, secondo un presunto testimone oculare, sarebbero state fatte cancellare dalle forze dell’ordine – si vedono le gazzelle dell’Arma inseguire il motorino guidato da Fares Bouzidi».
Ancora: nel filmato c’è l’audio, si possono sentire le sirene spiegate, ma null’altro, nessuna voce.
Il nuovo video mandato in onda dal Tg3, invece, aggiunge i tasselli mancanti.
In onda vanno gli istanti dell’inseguimento, le manovre pericolose, Ramy che perde il casco. Infine, le immagini delle telecamere comunali mostrano il momento dello speronamento, scooter e auto dei Carabinieri che vanno dritte, schiantandosi contro un palo. Ramy non si alzerà più.
Non solo, c’è di più. L’audio permette di sentire le voci degli agenti che, lungo tutti i 20 minuti, insistono: «Vaffanculo, non è caduto», «Chiudilo, chiudilo… No, merda, non è caduto» e, alla fine, «Sono caduti, bene!».
«Non mi aspettavo i commenti dei carabinieri, sono disumani», dirà Nada, la fidanzata di Ramy.
La terza Gazzella, quella che riprende tutto con la dashcam, arriva a impatto già avvenuto. Continua a riprendere. Si vedono due militari in divisa andare incontro a un ragazzo che alza le mani in alto. Quel ragazzo è Omar, 28 anni. È lui che, l’indomani, dichiara che gli agenti gli avrebbero intimato di cancellare dal cellulare i video che avrebbero ripreso gli istanti finali della corsa, l’impatto, la morte di Ramy.
È lui il testimone cui l’ultradestra non aveva dato un minimo di credito. In fondo come si può credere a un altro immigrato, a un Omar?
Questa storia, però, sovverte la narrazione mediatica e politica dell’ultradestra. I “buoni” diventano i “cattivi”; i “cattivi” i buoni.
È quello che avevano raccontato fin da subito gli amici di Ramy. Ragazzi arrivati bambini nella periferia milanese o nati qui da genitori immigrati. Marocchini, egiziani. Sprezzantemente “arabi”.
Dal giorno dopo erano scesi in strada. Per protestare, per manifestare la rabbia (c’erano stati anche lanci di oggetti e fuochi d’artificio contro le forze di polizia e la distruzione di un bus). Ma anche perché sapevano che il silenzio avrebbe favorito il confezionamento di ricostruzioni di comodo. Non credevano alle prime versioni diffuse dalle istituzioni. Nel primo verbale redatto dai Carabinieri si legge che «il conducente del motociclo sopraggiungendo a velocità elevata effettuava manovra improvvisa a sinistra. A causa del sovrasterzo scivolava fino a impattare con il semaforo e terminando contro un’aiuola». Fares e Ramy sarebbero dunque scivolati. Ricostruzione messa in forte dubbio dalle immagini dei video che, anzi, aprono le porte all’ipotesi di un vero e proprio depistaggio da parte delle forze dell’ordine.
Al Corvetto gli amici di Ramy non ci hanno mai creduto. Perché Omar aveva iniziato a raccontare che lui aveva visto, che lui sapeva. Ma non ci avevano creduto anche perché, prima ancora di avere contezza di come si fossero svolti i fatti, erano abituati ogni giorno a fare i conti con l’immagine deforme e deformante che media e partiti politici offrono di loro, dei loro quartieri, delle loro famiglie.
Lo stesso rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri), pubblicato a ottobre 2024, affermava che «ci sono numerose testimonianze di profilazioni razziali da parte delle forze dell’ordine, che prendono di mira soprattutto i Rom e le persone di origine africana». Al centro dell’attenzione, quindi, la profilazione razziale, cioè la pratica di fermare o controllare persone sulla base del colore e della razza.
Il rapporto aveva suscitato lo sdegno dell’intero spettro politico italiano, fino ad arrivare alle parole dello stesso presidente della Repubblica Mattarella, che si era sentito in dovere di telefonare al capo della Polizia per esprimergli il proprio «stupore» per quanto sostenuto dall’ECRI e per ribadire «stima e vicinanza alle forze di Polizia».
Il caso di Ramy si inserisce in questo quadro. Per tv, giornali, partiti politici dell’ultradestra, Ramy era semplicemente un delinquente. Perché “arabo” è sinonimo di spacciatore, di criminale. In potenza, quanto meno.
Una storia tutt’altro che nuova e niente affatto patrimonio della sola ultradestra.
Correva il 1 novembre 2007 quando il quotidiano “progressista” per eccellenza, La Repubblica (oggi proprietà del gruppo Gedi, riconducibile agli Agnelli-Elkann proprietari di Stellantis), titolava: “Romeni e violenza. 2007, un anno nero”. Come ricorda Christian Raimo, sempre nel 2007 l’allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, ex direttore de L’Unità ed ex militante del Pci, affermava: «È necessario assumere iniziative straordinarie e d’urgenza sul piano legislativo in materia di sicurezza. Non si possono aprire i boccaporti. Roma era la città più sicura del mondo prima dell’ingresso della Romania nell’Ue».
Sono parole tanto diverse da quelle che oggi Salvini, Abascal, Wilders, Le Pen, Trump scagliano contro “arabi” o “latinos”?
Ramy in realtà era un giovane lavoratore. Da tre anni lavorava come elettricista. Uno dei tanti proletari che portano avanti il Paese ma di cui il Paese si accorge solo quando muoiono di morte violenta.
Anche se questo è il loro Paese: «l’Italia è il mio primo Paese, non il secondo», dice Yehia Elgaml, il papà di Ramy. «Mio figlio è morto qui, è sepolto qui, a mezz’ora da qui, a Bruzzano. Tutti i giorni lo vado a trovare».
«Il fatto che vivo in un posto di merda non significa che io sia una persona di merda», aveva detto Nabil, 20 anni, fidanzata di Fares Bouzidi.
Per il carabiniere alla guida della Gazzella Volpe 40 che avrebbe speronato il T-Max l’ipotesi di reato al momento è ancora quella di “omicidio stradale”, punibile con una pena tra i 5 e i 10 anni di carcere. I magistrati, però, iniziano a vagliare anche l’ipotesi di “omicidio volontario”, che prevede una pena assai più pesante, più di 20 anni di reclusione.
Per altri due agenti c’è l’accusa di “frode” e “favoreggiamento”, in virtù della testimonianza di Omar.
Anche dopo la messa in onda delle immagini dell’inseguimento e dello speronamento, anche dopo aver ascoltato le parole che si scambiavano gli agenti, il vice-presidente del Consiglio Salvini ha pubblicato su Instagram un’immagine in cui si chiede “Carabinieri assassini?”. E alla domanda retorica risponde con un “No, hanno solo fatto il loro dovere”.
In Italia, però, non fermarsi a un posto di blocco costituisce un illecito amministrativo, punibile con una multa. Solo dopo eventuale inseguimento a velocità elevata che metta in pericolo altri cittadini, si configura il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”, punibile con una pena tra sei mesi e cinque anni di carcere. In ogni caso, non con la pena di morte.
Le parole di Salvini danno il senso di una battaglia che non si esaurisce affatto nelle aule di tribunale. È una battaglia innanzitutto per il senso comune. E l’ultradestra da anni la combatte senza riserve, senza fare prigionieri.
Questo articolo di Giuliano Granato (portavoce di Pap) è pubblicato in collaborazione con Diario Red di Canal Red fondato e diretto da Pablo Iglesias