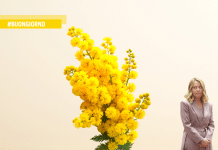I giovani, ha scritto Enrico Palandri, stanno al mondo come i gatti e la luna. Cercano, provano, si innamorano e lasciano tutto il resto indietro. Ad inseguirli.
Venerdì 15 marzo in piazza sono scesi in tanti, tantissimi. Raccogliendo la sfida lanciata da una sedicenne svedese. Un’adolescente dalle trecce bionde, che ha deciso di puntare i piedi: ora basta. L’hanno seguita in centinaia di migliaia, in tutto il globo. Una battaglia necessaria, coraggiosa, vitale, che urla al mondo incancrenito degli adulti l’ingiustizia dei suoi meccanismi produttivi. E le risposte non si sono fatte attendere: rabbiose, scomposte, incattivite. Giornali e personalità hanno tentato di sporcare la rivolta bella di Greta Thunberg e degli adolescenti. Troppo sciocche e strumentali le contestazioni: le carte sporche per la strada, i tranelli dei giornalisti che volevano far passare gli intervistati per scolari poco diligenti, che hanno colto l’occasione per trascorrere una giornata al sole. Dietro deve esserci qualcos’altro. È sempre stato così.
Negli ultimi decenni, la storia dei giovani si è ritagliata uno spazio a sé nel panorama storiografico. E non avrebbe potuto essere altrimenti dopo il Novecento, dopo il secolo che ha visto per la prima volta un gran numero di giovani che hanno avuto il tempo di essere tali: le generazioni post-belliche. Questo nuovo campo di studi pone inevitabilmente molti interrogativi sul senso dei movimenti giovanili e delle risposte che a questi sono state date.
Nel 1964 gli studenti si ribellarono nell’università di Berkeley, in California, e i ghetti delle città statunitensi entrarono in subbuglio. Un fermento mai visto. La cultura, spietata, rispose proponendo una riscoperta di Freud e Lacan. Il comando imperativo di chiudere gli occhi prese alle spalle i ragazzi che scendevano in piazza. I tomi illeggibili volevano raccontare dell’impossibilità di ribellarsi ai padri. Della loro onnipotenza di statue monumentali, davanti alle quali chinare il capo, con devozione. Il “non posso” sussurrato nelle orecchie intorpidite stregò i giovani del ’68, costringendoli a credere. A pensare che non c’è umano, ma solo animale.
Ma le generazioni cambiano, velocissime. Gli anni 70 furono per l’Italia il massimo del riformismo e insieme il massimo della distruttività: il terrorismo, l’eroina, la violenza diffusa. Ancora i giovani che gridavano per chiedere il pane e le rose, i bisogni radicali, forse anche oltre il comunismo. E il grande partito, ripiegato sui suoi santini, che chiudeva le finestre per non ascoltare, per non sentire. Urlava più forte, spaventato, tentando di far sparire quanto, muovendosi, gli ricordava la sua fine vicina. Ingrao l’ha scritto, trent’anni dopo, che avrebbero dovuto ascoltare i giovani. Ma così non andò. Restarono, sfingi di ghiaccio, ad urlare il proprio sapere, in faccia ai ragazzi che non riuscivano a capire.
Vogliamo solo cantare la nostra canzone, senza più padri, senza più simboli. Liberi, come selvaggi partoriti alla luna da una squaw dai fianchi generosi. Semplici, come ragazzi innamorati che cercano le parole per dirsi il loro primo amore. Il movimento del ’77 raccolse tutto questo: dispersi, studenti, operai, ex-militanti, adolescenti alla ricerca. Tra mille contraddizioni, ritornarono le domande spiazzanti dei giovani: un mondo nuovo, parole nuove, nuovi rapporti.
Ma il grido della rivolta si impastò con le frasi di maestri come Deleuze e Guattari, che rendono impossibile l’amore. Che mischiano Marx con Freud, sporcando l’idea di una socialità umana originaria. A marzo del ’78, Rossana Rossanda dal suo alto scranno di decana della rivoluzione fallita sentenziava: il ’77 è stato la microfisica del potere foucaultiana. Nel frattempo, il filosofo francese aveva iniziato a scrivere parole d’amore per la rivoluzione iraniana, per il sentimento oceanico che scioglie il singolo nella massa credente. Era la vittoria dei padri, che avevano smorzato in gola il respiro ai giovani ribelli.
Eppure, né Freud né Foucault sono bastati a fermare il movimento. Il grande partito, la cultura, i giornali sono stati tutti troppo stupidi e sciatti per non capire che la rivolta degli adolescenti non aveva bisogno di idoli immortali. Si muoveva sui passi leggeri di Corto Maltese, di Salgari, di Sandokan. Immagini belle di una navigazione oltre i confini del mondo, senza paura.
In piazza, venerdì 15 marzo, c’era una folla che non era massa. Identità singole, giovani, che si incontrano per un momento, per poi disperdersi, ed inseguire un altro sogno. Al centro della città antica, all’ombra dei suoi monumenti maestosi, canti e balli irriverenti ci hanno raccontato la storia del mondo. Da una parte, i “professionisti del significato”, impettiti nelle loro divise inamidate, che tentano di confondere, di guidare, di stregare gli occhi belli di una ragazza con i morsi di una mela avvelenata. Dall’altra, i giovani, sempre loro, sempre diversi, con tagli nuovi e nuovi vestiti. Inconcepibili e spiazzanti, rumorosi o estremamente quieti. Ma forse oggi qualcosa è cambiato, anzi, è tutto diverso: i maestri velenosi sembrano in declino, è solo una debole battaglia di retroguardia. A nulla sono valsi gli attacchi furiosi: i ragazzi si sono lasciati, come si erano incontrati, con la naturalezza dei loro gesti adolescenziali. Ci hanno lasciato, innamorati, a chiederci il segreto della loro sicurezza. Sotto le colonne antiche, sono scomparsi i padri immortali, è rimasto solo il movimento bello dei giovani. E le trecce bionde di un’adolescente svedese.
Il 15 marzo in tutto il mondo hanno gridato agli adulti l'ingiustizia dei meccanismi produttivi