Lasciando Longarone lungo la Strada regionale 251 ci si inerpica su un massiccio delle Prealpi carniche che oggi ospita uno dei più bei parchi naturali d’Europa, varcando il confine del Friuli con il Veneto. In automobile ci vuole mezz’ora per superare lo stesso balzo che l’8 ottobre 1963 un’immane massa d’acqua percorse in direzione opposta in appena quattro minuti, spazzando via interi paesi, sei chilometri di ferrovie e strade, e quasi 2mila persone. In quota, la 251 piega a sinistra e si getta dentro la montagna, attraverso una galleria scavata nella roccia e costellata di aperture che affacciano sulla Forra del torrente Vajont. Ancor prima di uscirne, la vista della diga, integra, mastodontica, cattura fin quasi a distrarre dalla guida. È ancora lì, sormontata da un camminamento protetto la cui unica funzione è oggi consentire le visite di gruppi di turisti. Fra le guide ci sono anche discendenti delle vittime di quello che è ancora ricordato come uno dei più grandi disastri della storia d’Italia. Dall’altra parte della strada, le pareti per fare arrampicate, rese celebri dallo scrittore e alpinista Mauro Corona. Verticali, come quasi tutto, quassù. Quando si esce dalla galleria il mondo è cambiato: la montagna sulla destra ha alberi radi, il terreno è smottato, il profilo appare innaturale. È la frana. Proprio come la diga, è ancora lì. Alle sue spalle, l’immensa ferita del Monte Toc dal quale la massa si è staccata, a deturpare la straordinaria bellezza di una delle zone altrimenti più incontaminate d’Italia, le Dolomiti friulane, sorelle minori di quelle più blasonate di Veneto e Trentino.
Quando nel 1959 fu completata, con i suoi 261 metri di dislivello fra il piano di coronamento e le fondazioni, la diga a doppio arco del Vajont era la più alta del mondo. Un vanto per la Sade – Società adriatica di elettricità (ente privato destinato a confluire nell’Enel qualche mese prima del disastro) che aveva così realizzato il progetto che l’Ingegner Carlo Semenza accarezzava sin dal 1925, in una terra così ricca d’acqua da essere stata oggetto di sfruttamento idroelettrico fin dall’inizio dell’era industriale. Centosettanta ettari di terreno, case espropriate e famiglie sfollate con indennizzi ridicoli, a Erto e a Casso, in nome dell’opera classificata “di interesse nazionale”, per creare un serbatoio di 150 milioni di metri cubi d’acqua nell’angusta valle in cui scorre uno delle centinaia di torrenti della Valcellina, il Vajont. In pochi mesi l’essere umano sovverte così il lavoro compiuto dalla natura in miliardi di anni per raggiungere un precario stato di equilibrio in una zona geologicamente instabile, la Faglia periadriatica (la stessa che appena 14 anni dopo il disastro causerà il terremoto del Friuli), incapace di reggere l’urto della “civilizzazione” forzata e della concentrazione delle sue acque. Ancora una volta nell’interesse del profitto.
La lobby politico-industriale nota come “Gruppo Venezia”, la stessa che sarebbe stata fautrice dell’espansione di Porto Marghera, aveva deciso già dagli anni 20 il destino delle valli friulane. Il boom economico del dopoguerra e gli investimenti del Piano Marshall fecero il resto: il terzo progetto di Semenza, il cosiddetto “Grande Vajont”, fu approvato nel 1957 senza una relazione geologica definitiva. I successivi sei anni furono un’escalation di segni premonitori e segnali d’allarme, che oggi inquieta ripercorrere.
Già nei primi mesi di cantiere nel 1957 le esplosioni con la dinamite rivelano incrinature della roccia nei punti di ancoraggio. Poco dopo, una frana cade da un versante nel lago di Pontesei, sede di un’altra diga, creando onde alte venti metri e confermando che la zona è instabile. Muore un operaio e viene spazzato via un ponte di 70 tonnellate. La Sade minimizza ma la popolazione che vive nei paesi sul Vajont entra in allarme. Solo Tina Merlin ne rappresenta gli interessi e i timori dalle colonne dell’Unità, per finire denunciata per turbamento dell’ordine pubblico. Verrà poi assolta con formula piena.
Grazie a una relazione del geologo Edoardo Semenza, figlio del direttore della Sade, si scopre che sul serbatoio del Vajont, a ridosso del Monte Toc, insiste una immensa frana preistorica del tutto scollata dal resto della montagna. L’imbibizione dello strato di scorrimento con l’acqua dell’invaso che si sta creando può quindi essere fatale per la valle. Ma l’onnipotenza dei dirigenti Sade si spinge fino a pretendere di saper controllare il movimento franoso evitando così ciò che, dati alla mano, si annuncia invece molto probabile. Le prove di invaso continuano, finché Il 4 novembre 1960 una frana di 800 mila metri cubi precipita dal versante sinistro del Vajont causando onde di venti metri e dando il via a una successione di eventi che non avrà mai termine fino al giorno della tragedia. I segni nel terreno, le spaccature, i cedimenti, visibili a occhio nudo, sono all’ordine del giorno. La popolazione locale vive nell’angoscia mentre l’Italia per lo più ignora cosa stia succedendo in quel piccolo lago artificiale dimenticato fra i monti. La Commissione di collaudo invia rapporti quindicinali a Roma e confida nel coordinamento del ministero. Roma a sua volta si affida alla capacità di vigilanza della Commissione, e la Sade è tranquilla che Roma sia informata; il Genio civile di Belluno non viene coinvolto e non si preoccupa dal canto suo di decifrare la gravità della situazione e svolgere il suo normale ruolo ispettivo. In breve, ognuno si affida al lavoro dell’altro in un incredibile rimpallo di responsabilità.
A controllare, però, non resta praticamente nessuno. Il modello in scala 1:200 approntato dal professor Augusto Ghetti di Padova per simulare la frana si basa sull’errata indicazione che questa non abbia la compattezza che in effetti ha, e quindi sottostima enormemente il rischio. A complicare le cose, nel 1961 Carlo Semenza muore. Il suo “erede” al vertice della Sade, Alberico Biadene, prende le redini dell’impianto in coincidenza con la nazionalizzazione da parte della nascente Enel nel 1962. Il quadro delle attribuzioni di responsabilità e delle competenze si fa ancora più complesso. Biadene è determinato ad andare avanti e raggiunge quote di collaudo del riempimento sempre più elevate. Il 2 settembre 1963, ovvero un mese prima del disastro, un violento terremoto è un segnale di pericolo che nemmeno lui può più sottovalutare. A seguito anche delle disperate proteste scritte del sindaco di Erto e Casso, lo svaso per mettere in sicurezza la valle ha finalmente inizio. Ma è tardi, e il livello delle acque non si può abbassare troppo in fretta, pena ulteriori rischi. L’8 ottobre vengono ordinati l’evacuazione del Monte Toc e il divieto di circolazione sotto quota 730 metri. A Casso, 200 metri più in alto, e soprattutto a Longarone, nella sottostante valle del Piave, non c’è alcuna percezione del pericolo. Nessuno immagina la portata dell’apocalisse che sta per abbattersi su chi vive sopra e sotto questi monti. Lo stesso Biadene effettua di persona un sopralluogo appena il giorno prima.
Il 9 ottobre 1963 alle ore 22.39 la gente dei monti per lo più dorme in casupole di pietra e legno. Sono pastori, contadini, malgari. Si sono abituati a vivere in un incubo, non sanno che per molti di loro, e per i loro figli, sarà l’ultima fatale notte di paura. Così per gli abitanti di Longarone, i cui cadaveri saranno trascinati dal Piave e ritrovati, a pezzi, fino a decine di chilometri di distanza, così per gli stessi operai e tecnici della diga. In un istante un fronte compatto di due chilometri di lunghezza si stacca dal Monte Toc e precipita nell’invaso alla velocità di cento chilometri all’ora. Bastano venti secondi perché cinquanta milioni di metri cubi d’acqua si sollevino creando due onde sovraccariche di detriti: una risale il bacino distruggendo gran parte dell’abitato di Erto e poi, nel movimento di ritorno, si abbatte sulla diga che la respinge scagliandola fino all’abitato di Casso, duecento metri più in alto. Su Casso ricade così una pioggia di massi, acqua, detriti, corpi. È una strage. L’altra onda si è invece nel frattempo sollevata per oltre centocinquanta metri al di sopra del coronamento della diga e in quatto minuti raggiunge l’abitato di Longarone nella valle sottostante. «Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi». Così scrive Dino Buzzati sul Corriere della sera del giorno dopo.
Sarà il giudice Mario Fabbri, il cui padre era stato internato in un campo di concentramento nazista e il fratellastro fucilato dai tedeschi, a occuparsi dell’istruttoria, resistendo a un tentativo di rimozione dall’incarico e poi facendo un lavoro colossale di raccolta di documenti insieme al pubblico ministero Arcangelo Mandarino. Poiché è impossibile trovare esperti di livello indipendenti dalla Sade e disponibili a farne parte, i magistrati sono costretti ad affidare la nuova perizia a una commissione internazionale, che stabilirà la prevedibilità dell’evento. È nelle parole del magistrato, immortalate nel docufilm Vajont, una tragedia italiana di Nicola Pittarello del 2015, che la vicenda viene posizionata nella sua prospettiva storica forse più corretta. «L’Italia degli anni 60 era un’Italia illusa e successivamente delusa, politicamente molto equivoca, in parte defascistizzata ma sostanzialmente fascista. Di certo è l’Italia che ha aperto le porte al terrorismo, a Tangentopoli, a un ventennio di corruzione, mafia, ‘ndrangheta, camorra. Prima di autoassolverci dobbiamo avere il coraggio di leggere bene la storia partendo anche da fatti come il Vajont». Sarà uno dei più grandi disastri della storia italiana, eppure al primo grado di giudizio, con sentenza di omicidio colposo plurimo del dicembre 1969, si cercherà di avvalorare l’idea che si fosse trattato di un evento inevitabile, in sostanza imputando alla natura le responsabilità umane e così escludendo l’aggravante della previsione per i condannati. Una catastrofe è un evento naturale.
Il disastro del Vajont di naturale non ebbe proprio nulla. Solo in appello l’aggravante sarà finalmente riconosciuta. In seguito, nel marzo 1971, ovvero due settimane prima della prescrizione, la Cassazione conferma le condanne, eppure riduce le pene. Vengono così definitivamente riconosciute le responsabilità dello Stato e della Sade/Enel, ma verso le persone fisiche prevale una clemenza che si esprime nella raccapricciante asserzione, da parte del tribunale, che «il comportamento degli imputati è in linea con la civiltà industriale». In un certo senso, non si può che essere d’accordo. Il problema, forse, è proprio la civiltà industriale. Quella che mette l’essere umano in secondo piano, fino a colpirlo a morte, usando come proiettile la stessa terra che fino al giorno prima aveva cresciuto le sue piante e i suoi bambini, in nome di una visione del progresso falsa, distorta e a puro vantaggio di pochi.
Negli anni successivi al 1963, alla politica dell’imprudenza fece seguito quella che i locali ancora oggi giudicano della prudenza eccessiva. Il “lago residuale” era considerato ancora instabile e divenne motivo per impedire il ritorno degli abitanti di Erto e Casso nelle loro proprietà. Per la valle iniziò un lungo isolamento da cui in un certo senso non è mai uscita. A differenza che sulle sorelle maggiori di Veneto e Trentino, sulle Dolomiti friulane non troverete impianti attrezzati né grandi alberghi, e la natura domina pressoché incontrastata. A parte le dighe. Ma il prezzo di tanta bellezza è stato eccessivo, inaccettabile. Oggi Erto e Casso sono paesi in bilico fra l’ostinazione di chi ci lavora per creare una nuova realtà e l’atmosfera surreale che avvolge i loro vicoli. Da scenario di un racconto dell’orrore sono diventate luogo in cui ambientare un’idea di futuro diverso, basato sul rifiuto della logica del profitto e sulla nobile e friulana tenacia di chi il senso della propria esistenza vuole ancora trovarlo lassù.
L’amara conclusione del docufilm di Pittarello è affidata al magistrato Fabbri: «Mi sono chiesto se la lezione del Vajont sia servita a qualcosa e la risposta è no». Francamente, di fronte a recenti e altrettanto evitabili drammi dell’Italia di oggi, è difficile dargli torto.
L’autore: Francesco Troccoli è scrittore e traduttore. Tra i suoi libri, il romanzo Mare in fiamme (L’Asino d’oro, 2020) e la trilogia de L’Universo Insonne (Armando Curcio ed., Delos editore)
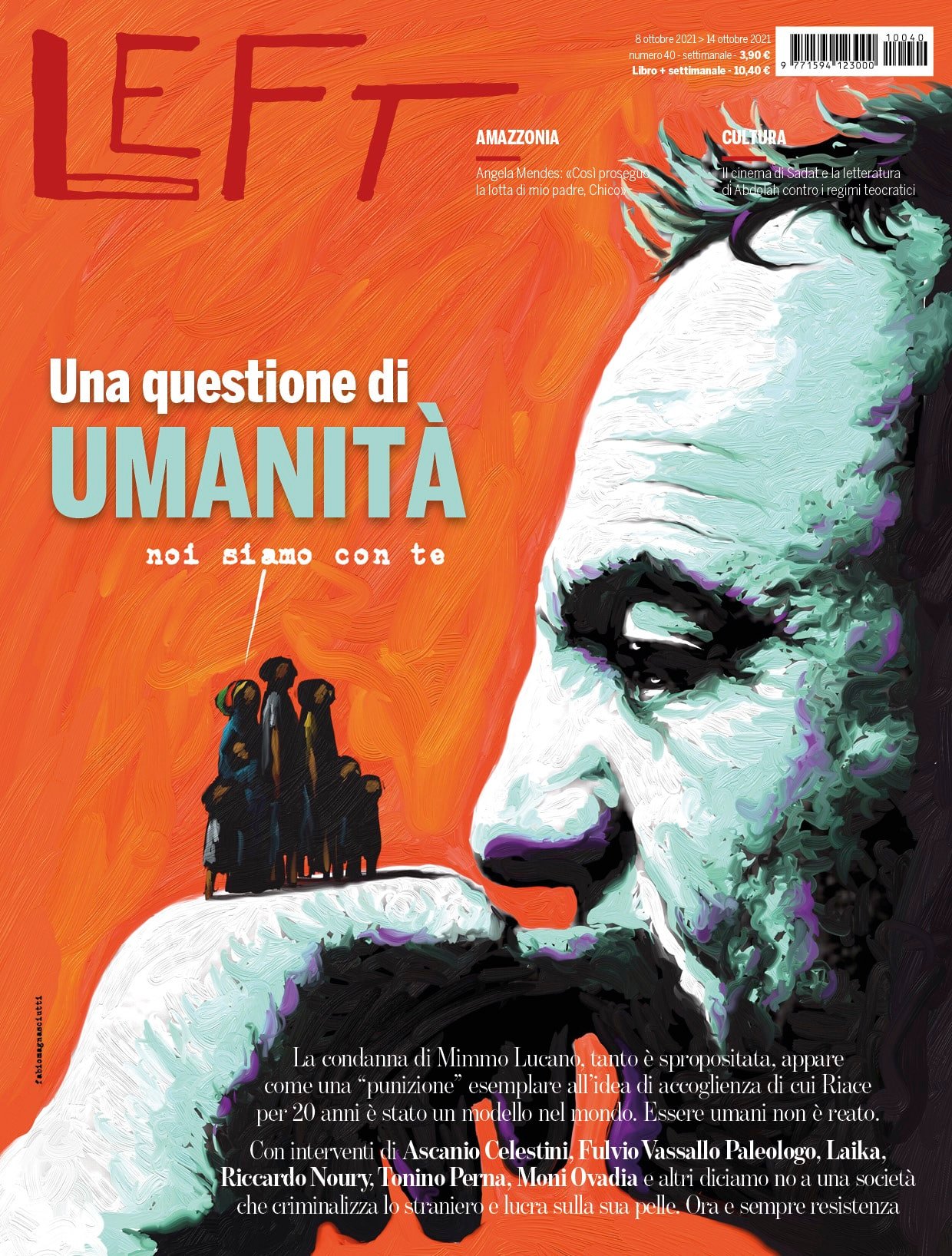
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE





