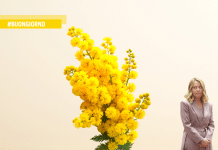Dopo un’interminabile attesa, il giudice monocratico dell’Alta Corte del Regno Unito ha respinto gli otto motivi di appello del collegio di difesa di Julian Assange, contro l’ordine di estradizione negli Stati Uniti siglato dall’allora ministra degli Interni Priti Patel.
Ora verrà presentato un ulteriore appello. Finita simile procedura alquanto barocca, non rimarrà che il ricorso alla Corte europea dei diritti umani, la cui legittimità la Gran Bretagna potrebbe persino non riconoscere dopo la Brexit. Insomma, in questi giorni pare consumarsi un delitto perfetto, contro WikiLeaks e il suo fondatore; e contro l’autonomia e l’indipendenza dell’informazione. Di questo, infatti, si tratta. Chi suppone che sia in questione la sorte, pur di enorme importanza, di una singola persona o non ha capito o finge con malcelata complicità.
Assange non è in libertà da tredici anni e da quattro è rinchiuso nel carcere speciale di Belmarsh, la Guantanamo d’oltre Manica. Tuttavia, non vi è stato finora alcun procedimento di merito sulle presunte accuse di violazione dell’Espionage Act del 1917, la legge varata nel corso della Prima Guerra mondiale e utilizzata cinicamente per impedire il ricorso al primo emendamento della Costituzione statunitense che considera sacrale il diritto di cronaca.
Le lungaggini di appelli e contrappelli inducono a pensare malissimo: si spera che il quadro psicofisico del giornalista peggiori definitivamente. Del resto, il recente volume redatto dall’ex relatore speciale delle Nazioni unite sulla tortura Nils Melzer (2023,per approfondire c’è il suo libro Il processo a Julian Assange edito da Fazi) spiega la parabola della tragedia in modo chiaro e documentato, ivi compreso il riferimento della docente dell’università di Boston -chiamata a svolgere la perizia in carcere- al dolore e alle sofferenze inflitte ad un imputato a rischio suicidario.
Quindi, i mesi trascorsi per dipanare la competenza territoriale del futuro dibattimento reale sembrano una condanna preliminare, che le menti spietate ispiratrici vorrebbero anticipasse la conclusione di una faccenda meno marginale e dimenticata di qualche tempo fa.
Appelli, cittadinanze onorarie, prese di posizione di ex ambasciatori, oltre ai riconoscimenti professionali decisi dall’Ordine dei giornalisti e da numerose organizzazioni sindacali della stampa europee hanno un po’ rivoltato la frittata. Si è capito, dove si tirano le fila della macchinazione (l’asse tra Stati uniti, Gran Bretagna, Svezia ed Ecuador), che la coscienza democratica diffusa potrebbe risvegliarsi dal sonno irragionevole di diversi lustri.
In fondo, a guardare a situazioni in parte omologhe, il Premio Nobel per la pace Pérez Esquivel si salvò dalla morte nell’oceano (il metodo che segnò la macelleria della dittatura argentina) proprio per la mobilitazione dell’opinione pubblica.
Vi sono state iniziative significative del presidente del Brasile Lula e dello stesso premier laburista australiano Albanese. L’associazione Articolo21 ha recentemente promosso un’importante assemblea in occasione della marcia Perugia-Assisi.
In quella sede aveva preso la parola il direttore di WikiLeaks Kristinn Hrafnsson, descrivendo il panorama inquietante della vicenda, confortato dalla moglie avvocata Stella Moris, in collegamento. Mentre la storia politica e giudiziaria veniva delineata da colei che in Italia più di tutti ha scritto libri e articoli, Stefania Maurizi (qui l’intervista di left).
Siamo arrivati, probabilmente, al dunque. Poco prima, forse, dei titoli di coda.
Se mai vi fossero stati dubbi, sarebbe il caso di scioglierli e di costruire un’azione civile di resistenza.
È possibile che non si levino voci critiche e non asservite all’amico americano nel parlamento italiano e in quello europeo? Non è una storia particolare, bensì la prova generale di una spirale autoritaria.
Per approfondire Free Assange, il libro di Left
E l’intervista all’avvocata Sara Chessa
L’articolo è stato pubblicato anche su Il Manifesto