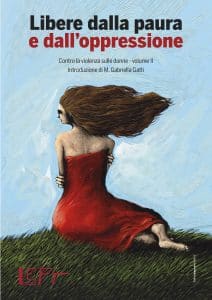«Non è facile articolare un pensiero. La notizia dell’uccisione di Giulia è arrivata mentre ero al corso per operatrici antiviolenza di Befree. Ho pianto, stretta alla mia compagna più cara, perché questa storia ha infranto il pensiero che le giovani e i giovani potessero essere salve e salvi dal dominio e dall’orrore patriarcale», dice Federica Scrollini, responsabile dei progetti di formazione e prevenzione di Befree–Cooperativa sociale contro tratta, violenze e discriminazioni. «Invece – continua – questa storia di violenza, ci mette di fronte una realtà e una radicalità della violenza per cui, ancora, nessuna e nessuno può dirsi immune. Ed è qui che si chiede un’azione trasformativa. È il momento che il maschile si attivi per contribuire alla fine del patriarcato: ogni uomo deve fare la sua parte. Noi continueremo a fare la nostra, ma è ora che tutti e tutte stiano in questa volontà trasformativa senza distrazioni, in ogni luogo, per Giulia, per tutte, per la libertà e per l’amore».
Nel nostro Paese il susseguirsi di atti violenti nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bambine, oltre che nei confronti di giovani e giovanissimi, ci obbliga a interrogarci sugli interventi necessari e non più procrastinabili per modificare radicalmente la situazione.
E la condizione delle donne in tutto il mondo è segnata da svantaggio sociale, economico, politico. Una donna su tre nel mondo ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica o sessuale e il rischio di subire violenza non si è certo ridotto, anzi appare aumentato, considerando quello che sta succedendo in Iran, in Afghanistan e nei teatri delle molteplici guerre oggi presenti.
Abbiamo incontrato Federica Scrollini a Roma, alla borgata Ottavia, dove c’è un centro gestito dalla cooperativa, per avere un riscontro da parte di chi “opera sul campo” circa il fenomeno della violenza contro le donne e sulle azioni per attuare un reale cambiamento.
In questi ultimi tempi ci siamo trovate di fronte a particolari efferatezze nei fatti di cronaca di violenza contro le donne: femminicidi preceduti da avvelenamento cronico, stupri di gruppo di adolescenti anche minorenni nei confronti di altre adolescenti o bambine… Tu che hai anche una lunga esperienza come operatrice antiviolenza vedi un cambiamento nelle forme che il fenomeno sta assumendo?
Il cambiamento c’è, nel senso che c’è un peggioramento dell’orrore: la violenza diventa sempre più “alta” profonda. Questo sta succedendo negli ultimi anni: l’avvelenamento, lo stupro di gruppo premeditato… c’è la recrudescenza dell’atto violento. Questo, è sia legato al fenomeno specifico del femminicidio, però è anche generale, di una società che purtroppo diventa sempre più violenta. Negli ultimi 5-6 anni in particolare, a partire dal linguaggio istituzionale, si usa sempre di più un linguaggio violento, un linguaggio discriminatorio; il linguaggio racconta, ma anche “forma” la realtà e sta succedendo questo, sta formando la realtà. D’altra parte Adorno ce lo aveva detto: a forza di essere esposto alla violenza l’essere umano si abituerà alla violenza.
Quindi, dici, c’è una abitudine alla violenza.
Sì, quando per esempio la cronaca riporta i fatti nei particolari più… profondi, nei dettagli, non è necessario! Per condannare un atto, come la violenza sessuale di gruppo o un femminicidio, io non ho bisogno di sapere i particolari. Io lo condanno; la società tutta lo dovrebbe condannare, e basta. Non è che una donna strangolata vale di meno di una donna seviziata. È gravissimo quello che viene fatto. Come viene fatto è di interesse giuridico, del tribunale, ecc. , ma per tutta la società civile, per l’opinione pubblica dovrebbe essere il fatto in sé che basta alla condanna generale.
La particolare attenzione che c’è stata per esempio per la uccisione della ragazza incinta, Giulia Tramontano, e anche per l’altra, uccisa dal suo vicino di casa, come la interpreti?
Lì c’è stata secondo me, un’altra operazione: il tentativo di una parte dei media di mettere in piedi una classifica delle vittime e un certo vojeurismo che indugia sempre un po’ di più quando le vite barbaramente interrotte sono di donne con alcune caratteristiche che fanno da sponda alla retorica familistica dell’attuale governo. Lì la cronaca si ferma oltre il dovuto e fuori dalla condanna di quell’atto che è un atto orribile, comunque e contro chiunque.
Hai detto del peggioramento del linguaggio usato; troppo spesso c’è la colpevolizzazione della donna o ragazza che ha subito violenza, come se l’avesse provocata lei…
Purtroppo da questo ancora non ne usciamo. Gli stessi giornalisti e giornaliste a volte parlano come se stessero con gli amici al bar, invece si rivolgono a una platea molto ampia. Anche se la televisione negli anni ha perso audience, quello che viene detto o succede in certi programmi viene riportato nei social e rimbalza su tutti i media. Così si viene a conoscenza, ad esempio, delle affermazioni del giornalista compagno della premier.
Ti riferisci a quelle frasi circa le donne che se bevono si espongono al rischio di subire violenza…
Sì, è il concetto che se abbassi la guardia qualcuno si approfitterà di te. Questo ha una doppia valenza: da una parte, ricevi la testimonianza che siamo “fermi” e che i giornalisti e alcuni stakeholders non sono andati avanti, non sono stati nemmeno formati né avvisati sul fatto che ormai certe frasi sono irricevibili. Dall’altra, comunque vada, anche quello che dovrebbe essere irricevibile riceve una visibilità altissima e questa è una cosa che non comprendo. Certe “robe” non andrebbero così diffuse. Quello che lui ha detto in quel contesto di Rete 4 alle nove di sera, a un pubblico che risponde a un target ben preciso, non dovrebbe ricevere tutta questa pubblicità. Invece poi ha provocato questa dinamica ‘familistica’ con la domanda a Giorgia Meloni che, in una conferenza stampa del governo, non parla come capo del governo ma come compagna di un giornalista. E ribadisce quello che ha detto il compagno. Insomma, si dà un megafono enorme a questi messaggi che alla fine convincono qualcuno.
Qual è alla fine, il messaggio?
Dovete stare attente, state a casa, state nell’ambito domestico… anche se noi sappiamo che la casa spesso non è un luogo sicuro.
Infatti le maggiori e diffuse violenze sono nell’ambito domestico e relazionale…
Loro dicono: fuori il mondo è brutto e cattivo verso voi donne… quindi dovete stare attente. “Occhi aperti” dice la premier, ma perché se io vado a farmi una passeggiata o voglio farmi una serata con le amiche, o da sola, devo vivere questo stato di allerta, perché devo avere paura e mi devo sentire in pericolo? E correre dalla macchina al portone di casa?
E di chi è la responsabilità della costruzione di un mondo brutto e cattivo?
E insieme a questo – “devi stare attenta perché dall’altra parte ci sono i lupi!” – c’è il discorso di Salvini che invoca la castrazione chimica come punizione per i perpetratori di violenza sessuale, come se si trattasse di un fatto di ormoni e se l’essere maschio volesse dire essere violento… che ne pensi?
…e non governare certi impulsi, che poi non sono impulsi… Castrazione chimica significa rendere impotente un uomo, quindi stiamo già dicendo che queste cose le fanno i maschi e che metà della popolazione deve stare attenta perché l’altra metà è cattiva. Hanno istinti che non governano! Ma non è vero, perché noi sappiamo che la violenza sessuale è un’azione legata alla sottomissione e quindi all’uso di un potere e non ha niente a che vedere con il desiderio. Quindi anche se elimino l’erezione sicuramente non elimino le aggressioni sessuali. E poi l’altro limite è che arrivo sempre dopo e intervengo punendo nella sua “virilità” – in quello che nell’immaginario condiviso è la virilità – un soggetto maschile.
Appunto, come se la virilità fosse collegata alla violenza; questo fa parte comunque della “cultura” patriarcale…
Sì, e non sganciare la narrazione del sesso e del desiderio dalla violenza è pericolosissimo, perché il desiderio e il sesso esercitati nel consenso e nel rispetto reciproco sono due tra le cose più belle della vita.
Siamo d’accordo! e in questo è importante la formazione, l’educazione, la cultura…
Esatto! La prevenzione, l’educazione alla affettività, l’educazione sessuale che comprende la conoscenza dei nostri corpi, di come funzionano e di quello che possono o non possono fare.
A questo punto stiamo parlando della necessità di fare prevenzione, formazione. Ci parli di come vi muovete in questo ambito e come si può agire?
Befree è una cooperativa sociale che si occupa di tratta, violenza e discriminazioni e lo fa su base nazionale. E quindi l’azione, sia il lavoro delle operatrici nei centri antiviolenza che il lavoro politico, è su base nazionale. Noi crediamo tantissimo nella prevenzione. Crediamo che ormai la prevenzione sia la chiave rivoluzionaria da oggi in avanti. Nei centri accogliamo le donne quando ormai hanno fatto esperienza della violenza, ma noi che cosa vorremmo? Che nessuna più facesse esperienza della violenza, e quindi occorre un lavoro di prevenzione. Questo viene fatto con le ragazze, con i ragazzi, con le bambine, con i bambini.
Quindi particolarmente nella scuola?
In realtà l’attività coinvolge tutta la popolazione. Diversamente dai centri dove ci sono donne che accolgono le donne, nel lavoro di prevenzione siamo operatrici antiviolenza che parlano a tutte e a tutti, alla cittadinanza. E vediamo quanto le dinamiche dell’educazione siano patriarcali dall’inizio.
In che senso?
Nel senso che è vero che le nuove generazioni si muovono e vanno in direzioni per fortuna diverse da quella che può essere stata la mia, che è quella degli anni 80, ma tantissimi ragazzi e ragazze sono fermi in una educazione patriarcale piena di stereotipi, piena di giudizi, piena di concetti del tipo “questo sarà il mio posto e quello sarà il tuo posto”, perché questo gli è stato detto. Quindi abbiamo tantissimo lavoro da fare nella scuola ma anche fuori dalla scuola. Comunque questa narrazione della scuola come spazio risolutivo di tutti i conflitti, di tutti i malanni di questa società… non è possibile.
Cioè? C’è il rischio che buttando tutto l’onere sul mondo della scuola alla fine non si faccia questo lavoro di prevenzione?
Sì, perché con tutte le problematiche di mancanza di risorse e di strutture che ci sono, pensare che la scuola da sola si possa fare carico di tutte le trasformazioni di cui la società ha bisogno, non è possibile. Quindi noi abbiamo bisogno di un intervento che diventi strutturale su queste tematiche e che, nell’essere strutturale, sia affidato a professioniste del contrasto alla violenza di genere. Mi spiego meglio: è chiaro che la Asl e il consultorio possono e devono dare il loro contributo per la salute e il benessere psicologico, e lo fanno, ma non in un’ottica di genere. Io da operatrice antiviolenza posso raccontare delle cose che l’ostetrica, ad esempio non sa o non rientra nel suo compito sapere, come io d’altra parte non possiedo il sapere delle ostetriche. Quindi va pensata una cooperazione… uno scambio di saperi… Se continuiamo solo a parlare di apparato riproduttivo e di come si rimane incinte o ci si protegge dalle malattie sessualmente trasmesse e non parliamo di relazione… non facciamo prevenzione della violenza. E per parlare di relazione dobbiamo fare un lavoro politico!
Occorre costruire una rete, un maggior collegamento tra sanità e operatrici antiviolenza? E rispetto alla formazione in questo campo dei professionisti e degli operatori della sanità, che cosa fate e proponete?
Il lavoro di prevenzione va nella direzione della trasformazione delle relazioni, quindi ti rivolgi alle giovani generazioni; poi c’è bisogno di formazione delle docenti e dei docenti, del personale socio-sanitario, degli operatori di sportello dei Municipi e dell’anagrafe… Abbiamo fatto una esperienza a Cuneo, abbiamo formato tutto il personale del Comune contro le discriminazioni; è super importante anche semplicemente mettere la locandina “Se ti succede questo chiama questo numero”, perché nello spazio pubblico ancora dobbiamo affermare l’esistenza del problema. Quindi chi legge il cartello può pensare: Se c’è questo cartello nell’ufficio dell’anagrafe, allora io non sono una malcapitata, una pazza… non ho incontrato un lupo, esiste il problema, non è solo mio… Allora se non è solo mio ci sarà un posto dove affrontarlo collettivamente. Per i medici inserire per esempio nelle domande dell’anamnesi “Lei ha mai subito violenza?” significa non tanto cercare la verità, quanto dare un segnale. La donna può pensare “Se fa questa domanda a tutte, allora questo problema esiste, non è un fatto che capita solo a me”; la fa entrare quindi in una dinamica politica e non in una sciagura personale. Il problema esiste e si può affrontare. E allora non devo raccogliere tutto il mio coraggio per tirare fuori questa cosa… posso dire di sì.
Oppure la donna può anche rispondere no, per tutti i motivi che sappiamo, vergogna, senso di colpa, non consapevolezza, ma quella domanda rimane e magari lavora nel tempo…
Sì, quello resta e questo è anche quello che succede al S. Camillo. Se nell’ospedale più grande di Roma con il pronto soccorso più grande d’Italia c’è lo sportello per il contrasto alla violenza di genere, il problema esiste! Il personale formato del triage chiama l’operatrice antiviolenza quando accedono donne con segni sospetti di violenza. La signora viene avvicinata da una professionista antiviolenza che sta in un posto istituzionale e magari quel giorno non racconta niente, ma un dopo mese, dopo un anno telefona. Noi abbiamo detto alla signora “la strada per uscirne c’è, esiste”
Quindi offrire da parte di un ente pubblico con gli enti del terzo settore che ci lavorano, il modo per uscire dall’isolamento, che è uno degli esiti peggiori e più pericolosi della condizione di violenza.
Sì, questo è importante per le donne.
Rimanendo nel campo della prevenzione…
Se noi pensiamo al turismo sessuale, a quello che succede alle bambine in India, in Brasile, in Estremo Oriente, che dobbiamo fare? Dobbiamo educare una parte della popolazione e dire che le donne non sono oggetti… e che siccome qui ti dico di no e certe cose qui sono illegali non è che le vai a fare all’estero! Devi diventare un essere umano che si relaziona ad altri esseri umani. Nella relazione c’è sì, c’è no, c’è forse; c’è sì oggi e domani no, ecc. e bisogna fare una azione di prevenzione che passa non solo per forme strutturate, ma anche attraverso l’adozione di un linguaggio rispettoso e non violento dei media, dei rappresentanti politici, un certo linguaggio negli ospedali. La prevenzione è un mondo che si fa carico di un problema.
È da porsi quindi anche il problema degli uomini che, cresciuti in questa cultura violenta, con certi messaggi, inibiti nella espressione di alcune loro emotività ecc., si devono adattare a un modello a cui fortunatamente non tutti si adattano; ma non è facile anche per loro opporsi e formare una loro propria identità, non violenta, cioè per me sana.
La sfida oggi è identitaria e occorre anche ridefinire il privilegio, decostruirlo… Ma soprattutto rispetto alla condizione in cui ci troviamo oggi dobbiamo stare insieme, partire da noi e trovare dei punti in cui siamo alleate per impegnarci nel cambiamento. E non arretrare più, non perderci in infinite categorie definitorie sulle varie identità.
Mi porti quindi a qualcosa che avevo sentito dire da te: lavorare al contrasto alla violenza di genere, e in particolare nella formazione, è fare politica e perché?
Sì, questo è fare politica su tanti fronti; intanto è avere un intento trasformativo. Io non sto trasmettendo niente, io sto cercando insieme di trasformare. Quando entro in classe con ragazze e ragazzi di 12-13-14 anni io non vado a raccontargli una cosa: io ho bisogno di loro per cambiare la storia. È una postura diversa, non sto trasmettendo ma dobbiamo trasformare e questo lo dobbiamo fare insieme. E questo è politico! E lo dobbiamo fare insieme partendo dalle esperienze e dalle storie anche lontane. Inoltre c’è un altro aspetto politico: è il riconoscimento del lavoro che svolgiamo. Noi vogliamo essere riconosciute come esperte, come lavoratrici e in quanto tali essere retribuite. E non essere sempre le volontarie… in questa società, capitalistica, il riconoscimento passa anche da un valore economico. Questa mancanza di dare valore economico al lavoro delle donne è una forma di oppressione.
Ecco, il fattore economico in quale condizione in particolare impatta negativamente?
Le donne che lavorano o hanno lavorato in casa non hanno mai ricevuto un riconoscimento economico per tutta la loro vita considerata produttiva e non riceveranno mai una pensione e questo fa sì che se hai una relazione con un uomo violento non te ne andrai mai via. La violenza nella età molto adulta, anziana, è una cosa orribile perché non hai alcuna risorsa. L’unica speranza è la vedovanza per la reversibilità…
Negli anni 60-70 c’era la proposta di retribuire il lavoro delle casalinghe, pensi sia giusto?
Si. Perché se la società tutta è basata sul denaro, non possiamo non retribuire anche quel lavoro. È una forma di infantilizzazione.
Una delle maggiori obiezioni da sinistra era però proprio che questo avrebbe definitivamente cristallizzato il ruolo della donna come donna di casa, mentre la meta doveva essere quella di favorire il lavoro fuori delle donne e la loro autonomia… E questo è ancora attuale, per cui sì, lottiamo perché ci sia la pensione per quelle che non hanno avuto la possibilità di lavorare, ma lottiamo perché ci sia la possibilità di maggiore lavoro femminile.
Sì, quella è la base, il lavoro ben retribuito. La chiave è “Lavorare tutte, lavorate tutti, lavorare meno!”. Il grande tema è quello di armonizzare il vissuto tra lavoro e vita dentro casa, di passare a una divisione del lavoro che deve essere diversa, a un orario di lavoro che deve essere diverso, a un compenso adeguato. Rispetto al salario alle casalinghe penso che non retribuire una parte – tutta femminile- di popolazione è stato anche uno stratagemma di infantilizzazione, perché gli unici soggetti non ricevono un compenso per quello che fanno sono i bambini e le bambine, e le donne.
L’autrice: Irene Calesini è psichiatra e psicoterapeuta, coautrice con Viviana Censi e Massimo Ponti di La violenza contro le donne (L’Asino d’oro)
Nella foto: una immagine di una campagna di BeFree (da fb)