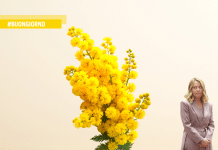Un’altra alba, un altro orrore: il nord di Gaza si è svegliato prigioniero di un incubo che si ripete ininterrottamente. L’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya, un luogo che dovrebbe incarnare speranza e guarigione, è stato trasformato in un campo di distruzione e umiliazione.
Quando il sole era appena un’idea dietro l’orizzonte, il rombo dei mezzi corazzati israeliani ha squarciato il silenzio. Accompagnati da droni che volteggiavano come predatori in cerca di prede, i soldati hanno circondato il complesso sanitario. Quattro ordigni piazzati attorno all’ospedale sono esplosi con un boato che ha piegato l’aria. Le fiamme, come serpenti, si sono insinuate tra i corridoi e le sale operatorie, divorando tutto: letti, strumenti medici, frammenti di vite.
Alle 7:15, il comando è arrivato tramite altoparlanti: evacuare. Il direttore dell’ospedale, il dottor Hussam Abu Safiya, ha avuto appena quindici minuti per svuotare ogni stanza, per convincere chi non poteva nemmeno reggersi in piedi a lasciare quel fragile rifugio. Quindici minuti, come se il tempo potesse misurare la dignità umana. Pazienti seminudi trascinati fuori al freddo, medici e infermieri umiliati, i loro volti schiacciati da una forza che sembra dimenticare cos’è l’umanità.
È difficile immaginare un livello più profondo di disumanità. Video e immagini, che già inondano i social come grida disperate, mostrano malati inermi spogliati anche della loro dignità, trascinati via verso un ignoto che profuma di paura. Ma l’orrore non è iniziato oggi. Per settimane, il Kamal Adwan era già stato ridotto a un simbolo di resistenza morente. Le scorte di medicinali erano finite, e anche l’acqua potabile si era trasformata in un miraggio. Ogni giorno era una battaglia per strappare alla morte chi si aggrappava a un filo di speranza.
Il giorno precedente, un assalto preliminare aveva già incendiato parte della struttura, ma il personale aveva continuato a lavorare. Una lotta contro l’impossibile, spinta da un senso del dovere che nessuna bomba era riuscita a cancellare. Fino a questa mattina. Le ambulanze inviate sul posto non sono più tornate, e i contatti con l’ospedale sono stati interrotti. L’unico messaggio è il silenzio. Un silenzio che urla.
Il Kamal Adwan, ora ridotto a cenere, è un simbolo tragico di una terra assediata, un luogo dove la sopravvivenza stessa è un atto di ribellione. Non si combatte solo contro le bombe, ma contro l’assenza di tutto ciò che rende la vita possibile: cibo, acqua, cure mediche, sicurezza.
Hani Mahmoud, giornalista palestinese, racconta che il dottor Abu Safiya è stato minacciato di arresto, mentre osservava impotente il suo ospedale bruciare. Le fiamme erano visibili da chilometri di distanza, come un monito macabro. Ogni mattone distrutto è un colpo inferto non solo a Gaza, ma all’intero corpo lacerato dell’umanità.
Eppure, ciò che resta impresso è l’immagine di quei volti, sbiaditi e sofferenti, che la nostra mente è costretta a immaginare. Camici bianchi di medici che, fino all’ultimo respiro, hanno cercato di salvare vite. Persone reali che probabilmente dimenticheremo troppo in fretta, inghiottiti dalla voracità della nostra indignazione momentanea. Scrolliamo un video, scriviamo un commento, e poi torniamo alle nostre vite. Ma Gaza brucia ancora.
Questo è il paradosso del nostro tempo: un mondo connesso eppure distante, dove la sofferenza può essere osservata in diretta, ma è sempre qualcun altro a doverla vivere. Mentre leggiamo, mentre guardiamo, mentre ci indigniamo per un istante, una parte del mondo continua a bruciare sotto le bombe.
l’autore: Andrea Umbrello è direttore editoriale & Founder di Ultimavoce