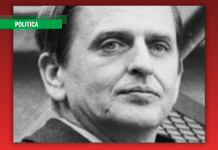A San Giuliano Terme l’addio a Marah non è un rito: è una deposizione. Vent’anni, evacuata da Gaza, è morta a Pisa di corpo sfinito e di assedio. I medici hanno parlato di malnutrizione estrema, il Comune di «genocidio». La procura, per ora, ha scelto di non aprire un’indagine. Intanto, a poche ore di distanza, il governo israeliano rilancia il piano di colonizzazione E1, e l’esercito annuncia la nuova spinta su Gaza City. I puntini si uniscono da soli.
Il funerale dice l’essenziale che la politica tace: «Marah è il simbolo della sofferenza» e della responsabilità che rimbalza dall’Europa a Tel Aviv. Chi chiama “incidenti” le morti da fame confida nella stanchezza dell’opinione pubblica; chi interrompe i corridoi umanitari, o li riduce a vetrina, si fida dell’impunità. Da mesi la strategia è l’esibizione della forza come comunicazione: mostrare il crimine per normalizzarlo, amministrare il lutto per renderlo invisibile.
C’è un punto di non ritorno in questa estetica dell’occupazione: la giuridicizzazione al contrario. Le autorità amministrano la tragedia con verbali, determine, protocolli, ma sospendono la domanda centrale: da dove viene questa morte. Finché l’Italia accetta di assistere in silenzio, continueremo a contare i funerali e a distribuire responsabilità in frazioni.
Il nome di Marah obbliga a scegliere. O si prende sul serio il diritto internazionale – cessate il fuoco, fine dell’assedio, stop a colonie e complicità – oppure si decide che la ragione di Stato vale più della vita. Nel primo caso la democrazia respira; nell’altro, si abitua a trattenere il fiato.
Buon giovedì.