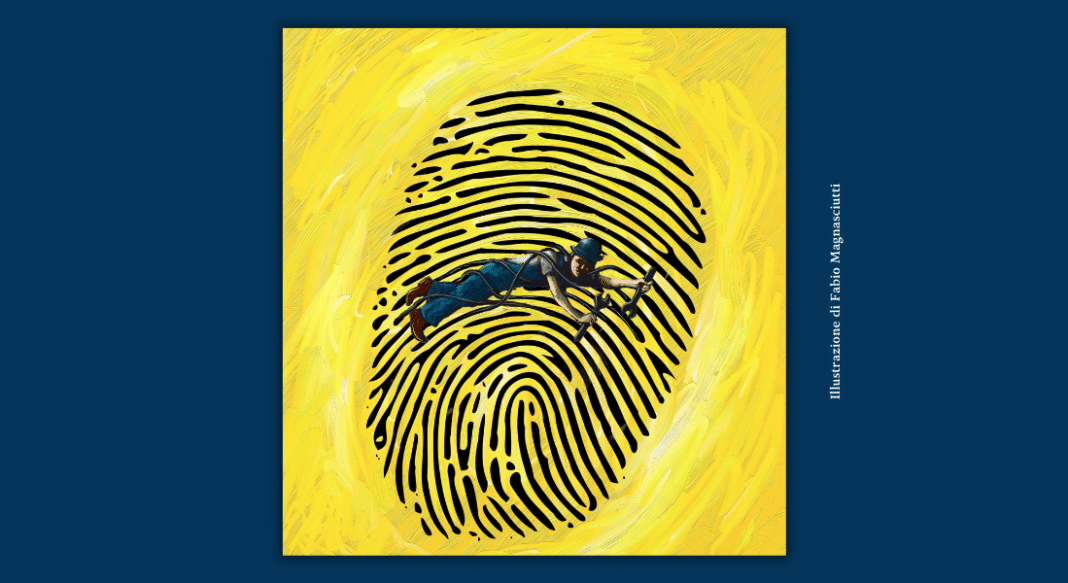Due milioni di lavoratori in Italia si sono dimessi nel 2021. Sono dati del ministero del Lavoro. E il fenomeno delle dimissioni volontarie continua a crescere nel 2022 mettendo a nudo tutti i deficit di un antiquato modo di fare impresa e di organizzazione neoliberista del mondo del lavoro.
Secondo l’Associazione italiana direzione personale (Aidp) il fenomeno delle grandi dimissioni (detto “Great resignation” negli Stati Uniti) interessa il 60% delle aziende italiane e riguarda soprattutto i giovani fra i 26 e i 35 anni, perlopiù nel Nord Italia. «Ad alimentarlo concorrono in modo particolare la ricerca di condizioni economiche più soddisfacenti e la speranza di trovare un migliore equilibrio fra vita privata e lavoro». A riportarlo è Il Sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria. Le aziende si trovano così finalmente costrette a considerare e a mettere al centro la questione del benessere non solo economico ma anche psicofisico dei lavoratori, fosse pure «per non perdere talenti».
Beninteso il fenomeno delle “grandi dimissioni” riguarda uno spicchio di lavoratori a fronte di un mare magnum di lavoratori precari, a contratto a termine, lavoratori a chiamata, working poor, disoccupati. Ma è rivelatore: segnala che quei posti fissi non sono quello che sembrano. Nascondono condizioni di sfruttamento intensivo. Per uno stipendio spesso neanche sufficiente si è costretti a mettere a valore tutto di se stessi, fino allo sfinimento, fra straordinari, rinuncia alle ferie e alla vita privata. (Le inaccettabili affermazioni di Elisabetta Franchi sono emblematiche e rappresentano solo la punta di un iceberg).
Il fatto nuovo è che sono soprattutto i giovani a rifiutare queste realtà di sfruttamento e sottomissione, costi quel che costi. Non è dunque solo la scelta elitaria di chi si può permettere di lasciare il posto fisso. Anche perché dalla nostra indagine risulta che molti di quelli che, per scelta, si dimettono, sono alla ricerca di un work-life balance, anche in assenza di un’altra opportunità di impiego, senza avere le spalle coperte come accadeva invece alla generazione dei baby boomers.
Quindi, andando più a fondo, cosa c’è dietro questa onda che è cresciuta anche in Italia durante e dopo la pandemia?
La risposta non è semplice, né univoca. Ciò che colpisce è che il fenomeno delle dimissioni di massa ha che vedere con una complessiva riconsiderazione delle priorità della vita e dei valori maturata durante la pandemia. In alcuni casi le dimissioni sono concomitanti a situazioni acute di stress, di depressione, di burnout (basta guardare quel che sta accadendo in ambito medico e infermieristico dopo due anni di pandemia).
Più in generale le “grandi dimissioni” esprimono un rifiuto, seppur solitario, non organizzato, di condizioni di sfruttamento considerando che si vive una sola volta. (Negli Usa il fenomeno inizialmente è stato denominato come Yolo economy, dove “Yolo” sta per “you only live once”, (vedi Left del 30 luglio 2021 e su questo numero l’intervista a Sarah Jaffe, autrice del libro inchiesta Il lavoro non ti ama (Minimum Fax).
Periodi di crisi come quello che stiamo attraversando - fra pandemia e guerra - ci spingono a ripensare ciò che davvero conta: gli affetti, la qualità dei rapporti umani, la possibilità di potersi realizzare insieme agli altri, il rifiuto della violenza, della sopraffazione, dello sfruttamento.
Molte storie di giovani che abbiamo raccolto ci parlano dell’esigenza di trovare un’occupazione più interessante e creativa, ci parlano dell’esigenza di sperimentarsi, di fare “ricerca”, ma anche e soprattutto di un nuovo e netto rigetto di condizioni di sfruttamento. Difficile però dire se sia l’inizio di una consapevolezza politica.
Certamente le loro parole rivelano una maturazione sul piano personale, esistenziale, una interrogazione radicale di senso.
In sintesi: Lavorare per vivere ma non vivere per lavorare soltanto, costretti a una vita povera di socialità e relazioni private. Lavorare meno e lavorare tutti diceva un vecchio slogan oggi più attuale che mai come argomenta il sindacalista Cgil Fausto Durante nel suo nuovo libro, Lavorare meno, vivere meglio (Futura edizioni), che traccia una panoramica non solo europea delle proposte e delle sperimentazioni più avanzate in questo ambito.
Una riorganizzazione su larga scala del tempo di vita e di lavoro sarebbe utile anche per contrastare gli alti tassi di disoccupazione giovanile. In Italia il numero dei giovani che non studiano e non cercano lavoro (Neet) è tra i più alti in Europa.
Il tema delle grandi dimissioni dunque si intreccia a una più ampia problematica sociale.
La questione del lavoro nella società globale impone nuove sfide e problemi. Compreso un ripensamento più complessivo del senso del lavoro, che non è “solo” possibilità di vivere sul piano materiale, ma anche occasione di socialità e di realizzazione di sé e tuttavia non definisce tout court la nostra identità di esseri umani.
Il lavoro è un diritto e deve essere garantito in una Repubblica democratica come la nostra fondata sul lavoro. Ma al contempo “io non sono il mio lavoro”, come scriviamo in copertina, per dire che l’identità umana non coincide con quella razionale dell’Homo faber e comunque non si esaurisce in essa. Una persona disoccupata non ha meno dignità e diritti, non deve essere discriminata. Per questo da molto tempo portiamo avanti la battaglia per un basic income universale, tema purtroppo sparito dal dibattito politico, mentre c’è chi inopinatamente - facendo guerra ai poveri - raccoglie le firme per cancellare il reddito di cittadinanza.
Il punto cruciale è: quale modello di società vogliamo realizzare? Quale giustizia sociale? Che cosa è il lavoro oggi? Come integrarlo nei tempi di vita più intima?
Il dibattito è importante e ambizioso e parte anche dalla rilettura critica della storia, fin dall’antichità. Nella Grecia antica e nella romanità l’otium letterario era l’aspirazione del cittadino ma era realizzata da pochi e sulla pelle degli schiavi e delle donne.
Nel medioevo cattolico il lavoro era castigo divino, condanna biblica. Sono stati i protestanti poi a creare l’etica del lavoro e del razionalismo ascetico a tutto vantaggio del capitalismo.
Se per molti secoli il lavoro è stato per i più una necessità per la soddisfazione dei bisogni, oggi potrebbe essere mezzo per una realizzazione di sé nel rapporto con gli altri, purché ci sia tempo per esigenze di vita affettiva e di ricerca. Paradossalmente però proprio ora che la rivoluzione tecnologica ci potrebbe permettere di affrancarci dai lavori di fatica il turbo capitalismo produce disoccupazione e nuovi schiavi.
* L'illustrazione è di Fabio Magnasciutti per Left
[su_button url="https://left.it/left-n-21-27-maggio-2022/" background="#a39f9f" size="7"]SOMMARIO[/su_button]
 </a
</aDue milioni di lavoratori in Italia si sono dimessi nel 2021. Sono dati del ministero del Lavoro. E il fenomeno delle dimissioni volontarie continua a crescere nel 2022 mettendo a nudo tutti i deficit di un antiquato modo di fare impresa e di organizzazione neoliberista del mondo del lavoro.
Secondo l’Associazione italiana direzione personale (Aidp) il fenomeno delle grandi dimissioni (detto “Great resignation” negli Stati Uniti) interessa il 60% delle aziende italiane e riguarda soprattutto i giovani fra i 26 e i 35 anni, perlopiù nel Nord Italia. «Ad alimentarlo concorrono in modo particolare la ricerca di condizioni economiche più soddisfacenti e la speranza di trovare un migliore equilibrio fra vita privata e lavoro». A riportarlo è Il Sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria. Le aziende si trovano così finalmente costrette a considerare e a mettere al centro la questione del benessere non solo economico ma anche psicofisico dei lavoratori, fosse pure «per non perdere talenti».
Beninteso il fenomeno delle “grandi dimissioni” riguarda uno spicchio di lavoratori a fronte di un mare magnum di lavoratori precari, a contratto a termine, lavoratori a chiamata, working poor, disoccupati. Ma è rivelatore: segnala che quei posti fissi non sono quello che sembrano. Nascondono condizioni di sfruttamento intensivo. Per uno stipendio spesso neanche sufficiente si è costretti a mettere a valore tutto di se stessi, fino allo sfinimento, fra straordinari, rinuncia alle ferie e alla vita privata. (Le inaccettabili affermazioni di Elisabetta Franchi sono emblematiche e rappresentano solo la punta di un iceberg).
Il fatto nuovo è che sono soprattutto i giovani a rifiutare queste realtà di sfruttamento e sottomissione, costi quel che costi. Non è dunque solo la scelta elitaria di chi si può permettere di lasciare il posto fisso. Anche perché dalla nostra indagine risulta che molti di quelli che, per scelta, si dimettono, sono alla ricerca di un work-life balance, anche in assenza di un’altra opportunità di impiego, senza avere le spalle coperte come accadeva invece alla generazione dei baby boomers.
Quindi, andando più a fondo, cosa c’è dietro questa onda che è cresciuta anche in Italia durante e dopo la pandemia?
La risposta non è semplice, né univoca. Ciò che colpisce è che il fenomeno delle dimissioni di massa ha che vedere con una complessiva riconsiderazione delle priorità della vita e dei valori maturata durante la pandemia. In alcuni casi le dimissioni sono concomitanti a situazioni acute di stress, di depressione, di burnout (basta guardare quel che sta accadendo in ambito medico e infermieristico dopo due anni di pandemia).
Più in generale le “grandi dimissioni” esprimono un rifiuto, seppur solitario, non organizzato, di condizioni di sfruttamento considerando che si vive una sola volta. (Negli Usa il fenomeno inizialmente è stato denominato come Yolo economy, dove “Yolo” sta per “you only live once”, (vedi Left del 30 luglio 2021 e su questo numero l’intervista a Sarah Jaffe, autrice del libro inchiesta Il lavoro non ti ama (Minimum Fax).
Periodi di crisi come quello che stiamo attraversando – fra pandemia e guerra – ci spingono a ripensare ciò che davvero conta: gli affetti, la qualità dei rapporti umani, la possibilità di potersi realizzare insieme agli altri, il rifiuto della violenza, della sopraffazione, dello sfruttamento.
Molte storie di giovani che abbiamo raccolto ci parlano dell’esigenza di trovare un’occupazione più interessante e creativa, ci parlano dell’esigenza di sperimentarsi, di fare “ricerca”, ma anche e soprattutto di un nuovo e netto rigetto di condizioni di sfruttamento. Difficile però dire se sia l’inizio di una consapevolezza politica.
Certamente le loro parole rivelano una maturazione sul piano personale, esistenziale, una interrogazione radicale di senso.
In sintesi: Lavorare per vivere ma non vivere per lavorare soltanto, costretti a una vita povera di socialità e relazioni private. Lavorare meno e lavorare tutti diceva un vecchio slogan oggi più attuale che mai come argomenta il sindacalista Cgil Fausto Durante nel suo nuovo libro, Lavorare meno, vivere meglio (Futura edizioni), che traccia una panoramica non solo europea delle proposte e delle sperimentazioni più avanzate in questo ambito.
Una riorganizzazione su larga scala del tempo di vita e di lavoro sarebbe utile anche per contrastare gli alti tassi di disoccupazione giovanile. In Italia il numero dei giovani che non studiano e non cercano lavoro (Neet) è tra i più alti in Europa.
Il tema delle grandi dimissioni dunque si intreccia a una più ampia problematica sociale.
La questione del lavoro nella società globale impone nuove sfide e problemi. Compreso un ripensamento più complessivo del senso del lavoro, che non è “solo” possibilità di vivere sul piano materiale, ma anche occasione di socialità e di realizzazione di sé e tuttavia non definisce tout court la nostra identità di esseri umani.
Il lavoro è un diritto e deve essere garantito in una Repubblica democratica come la nostra fondata sul lavoro. Ma al contempo “io non sono il mio lavoro”, come scriviamo in copertina, per dire che l’identità umana non coincide con quella razionale dell’Homo faber e comunque non si esaurisce in essa. Una persona disoccupata non ha meno dignità e diritti, non deve essere discriminata. Per questo da molto tempo portiamo avanti la battaglia per un basic income universale, tema purtroppo sparito dal dibattito politico, mentre c’è chi inopinatamente – facendo guerra ai poveri – raccoglie le firme per cancellare il reddito di cittadinanza.
Il punto cruciale è: quale modello di società vogliamo realizzare? Quale giustizia sociale? Che cosa è il lavoro oggi? Come integrarlo nei tempi di vita più intima?
Il dibattito è importante e ambizioso e parte anche dalla rilettura critica della storia, fin dall’antichità. Nella Grecia antica e nella romanità l’otium letterario era l’aspirazione del cittadino ma era realizzata da pochi e sulla pelle degli schiavi e delle donne.
Nel medioevo cattolico il lavoro era castigo divino, condanna biblica. Sono stati i protestanti poi a creare l’etica del lavoro e del razionalismo ascetico a tutto vantaggio del capitalismo.
Se per molti secoli il lavoro è stato per i più una necessità per la soddisfazione dei bisogni, oggi potrebbe essere mezzo per una realizzazione di sé nel rapporto con gli altri, purché ci sia tempo per esigenze di vita affettiva e di ricerca. Paradossalmente però proprio ora che la rivoluzione tecnologica ci potrebbe permettere di affrancarci dai lavori di fatica il turbo capitalismo produce disoccupazione e nuovi schiavi.
* L’illustrazione è di Fabio Magnasciutti per Left
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE