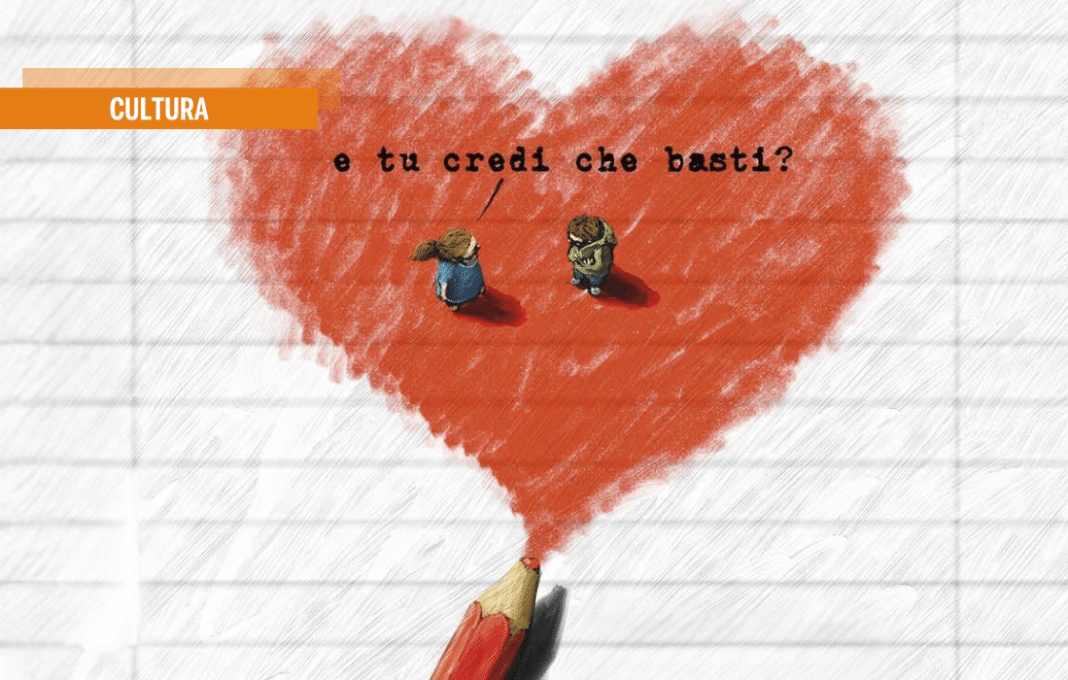Educazione può essere una parola bellissima se la si intende nell’accezione più legata alla sua origine etimologica, ovvero quando indica quell’azione o serie di azioni mirate a creare opportunità, rapporti, contesti umani e di apprendimento adatti a far sì che le potenzialità di ogni ragazzo ed ogni ragazza, di ogni bambino e di ogni bambina possano emergere e trasformarsi. Può essere, al contrario, un parola detestabile, da rifiutare, se la si intende come sinonimo di addestramento, come azione normalizzante mirata all’adeguamento di un comportamento ad un modello imposto dall’esterno basato su un sistema di pensiero o un costrutto culturale.
Il filosofo ed esponente della pedagogia progressista John Dewey, in Educazione e società scrive: «la storia della teoria dell’educazione è caratterizzata dall’opposizione fra l’idea che l’educazione sia sviluppo dal di dentro o che sia sviluppo dal di fuori». Che ci fosse un duplice significato era quindi già evidente nel 1938, quando il saggio è stato scritto e ciò che distingue le due versioni è l’idea che si ha dei bambini e dei ragazzi e di come funzioni la loro mente.
I bambini si possono infatti considerare «della stessa natura degli adulti», come diceva Freinet, cioè differenti solo nel grado di crescita dai più grandi, oppure menti da forgiare e, possibilmente, da contenere, se pensiamo che l’educazione sia sviluppo dal di fuori. La tradizione della scuola democratica e della pedagogia attiva che prende le mosse dalle teorie di Dewey e dalle proposte di Freinet proponendo un’idea di educazione come occasione di crescita di tutte le individualità, in Italia è stata principalmente rappresentata, fin dal 1951, dal Movimento di cooperazione educativa ed è tutt’ora presente in molte scuole pubbliche del nostro Paese vantando negli anni esponenti come Mario Lodi, Bruno Ciari, Nora Giacobini e Franco Lorenzoni. Nonostante ciò l’idea di educazione che prevale nell’immaginario comune è quella più direttiva, quella dello sviluppo dal di fuori, quella che i pedagogisti progressisti, seguaci di Dewey, definiscono “tradizionale”.
Certo, le esperienze della scuola democratica e delle tante altre pratiche affini sono realtà minoritarie rispetto alla maggioranza dei contesti educativi e scolastici. Di fatto la scuola italiana, pur contenendo al suo interno più anime e voci diverse, fa ancora fatica a togliersi di dosso i segni dell’eredità storica di quando l’istruzione era affidata alla Chiesa e quindi moraleggiante, orientata all’imposizione di un pensiero unico a cui era necessario adeguarsi per poter aspirare ad eccellere. Quel modello di scuola è poi confluito in modo naturale nella scuola gentiliana che ancora oggi, troppo spesso, caratterizza non tanto l’apparato normativo del nostro sistema scolastico, ma soprattutto una mentalità e spesso anche una prassi.
Capita, tuttavia, che i segni di una sincera trasformazione democratica della scuola diventino più visibili, ad esempio quando si propone il rifiuto di una scuola selettiva e irreggimentata o quando si chiede che l’obiettivo formativo non sia la performance o il prodotto, ma un’esperienza culturalmente e umanamente significativa per gli studenti. Quando questo accade, però la risposta di una folta schiera di giornalisti, esponenti della cultura pseudo progressista e, purtroppo, anche docenti, diventa feroce auspicando a gran voce il ritorno a contesti scolastici ed educativi più rigidi, punitivi e autoritari (confondendo clamorosamente rigore e rigidità, autorevolezza ed autoritarismo). Sono reazioni che si allineano ad una politica dominante orientata verso i valori di una destra spesso retriva, che si è addirittura scomodata ad inserire la parola merito nella denominazione del ministero riportando indietro di decenni quell’idea di formazione partecipativa ed inclusiva che deriva dal secondo comma dell’articolo 3 della nostra Costituzione.
È con queste premesse che dovrebbe essere letta la proposta del governo che in una direttiva ministeriale del 23 novembre 2023 parlava di «Educazione alle relazioni»: «Al fine di rafforzare l’impegno verso un’azione educativa mirata alla cultura del rispetto, all’educazione alle relazioni e al contrasto della violenza maschile sulle donne, il ministero dell’Istruzione e del merito promuove la realizzazione nelle scuole di progetti, percorsi educativi, attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali destinate, in particolare, agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione».
Si auspica, inoltre «lo svolgimento di un’adeguata formazione di ciascun docente-moderatore, secondo un programma che il ministero dell’Istruzione e del merito predispone anche con il supporto di organismi scientifici e professionali». Il tutto con l’investimento di 15 milioni di euro presi dal Pnrr.
L’urgenza di un simile intervento è scattata in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin quando il problema della violenza sulle donne e la discriminazione di genere si è rivelato agli occhi di una massa sconfinata di persone, una vera e propria emergenza. Si è avvertita quindi la necessità di dare una risposta a livello istituzionale ed è interessante che sia parso subito chiaro che dietro ad un problema tanto drammatico ci fosse una questione legata ai rapporti interumani, al modo di vivere le relazioni individuando, perciò, la scuola come il luogo prioritario in cui i ragazzi e le ragazze costruiscono i loro rapporti fuori dal contesto familiare. Ma la soluzione proposta dal ministero è pessima, non solo non è risolutiva del problema, ma rischia di peggiorarlo.
L’idea che sia necessario promuovere attività “altre” rispetto a quelle previste dalle varie istituzioni scolastiche che hanno a che fare principalmente con gli apprendimenti, porta con sé due istanze estremamente deleterie, la prima è quell’idea di educazione come addestramento che, se riportata all’affettività e alle relazioni, assume tratti preoccupanti. Non è accettabile, infatti pensare che affetti e relazioni siano comportamenti a cui adeguarsi, da apprendere in quanto non presenti nella realtà umana e personale di ogni ragazzo e di ogni ragazza. Come recentemente affermato in un comunicato del laboratorio scuola della Fondazione Massimo Fagioli «l’affettività si vive e si sperimenta, non si può apprendere».
Inoltre se recuperiamo l’idea che l’educazione sia un movimento che “parte da dentro” e che, come scrive Franco Cappa nell’introduzione ad Esperienza ed educazione “Solo se l’affettivo e il cognitivo si intrecciano si può dare esperienza educativa” si potrebbe pensare, allora, che l’inserimento di attività specifiche, diverse da quelle curriculari, volte a “favorire le relazioni”, possa aumentare la scissione dell’affettivo dal cognitivo facendo sì che l’esperienza non sia, in questo senso realmente educativa.
La scuola, oltre ad essere il luogo di socializzazione più importante per i bambini e gli adolescenti, si caratterizza per essere il luogo dell’apprendimento formale quindi l’idea di relazioni affettive valide dovrebbe andare di pari passo con quella dell’apprendimento e della costruzione della conoscenza. Non si tratterebbe, perciò, di inserire una nuova materia o nuove attività, ma di proporre modalità diverse di stare a scuola e di costruire insieme il sapere partendo innanzitutto dall’idea di cooperazione che introduce il rapporto come elemento irrinunciabile nell’attività di apprendimento: si impara insieme, si costruisce insieme il sapere e, costruendo ed imparando, ci si confronta, si condivide, ci si ascolta, ci si comprende.
Il cambiamento di cui abbiamo bisogno è un cambiamento più profondo, più strutturale, più lento e sicuramente più impegnativo, ma indubbiamente più efficace. La fortuna è che non si tratta di un’utopia, come già detto le realtà in cui si sperimenta una scuola attiva sono molte in Italia e se, fino a poco tempo fa, erano esperienze che riguardavano esclusivamente la scuola primaria con qualche caso nella secondaria di primo grado, da qualche tempo cominciano a diffondersi anche tra le scuole superiori, storicamente più restie al cambiamento soprattutto se appartenenti all’area dei licei che spesso, purtroppo, si pongono come baluardi della tradizione.
Non serve, quindi, una proposta costruita a tavolino da calare dall’alto nelle scuole (modalità che abbiamo imparato da tempo avere pochissimi risultati) sarebbe più utile, invece, partire dalle realtà virtuose e renderle un laboratorio di formazione per gli altri istituti.
È uscito per Mondadori un libro scritto da Vincenzo Arte, docente del Liceo Morgagni di Roma, dal titolo Crescere senza voti dove si racconta dell’esperienza di una scuola in cui i voti delle prove in itinere sono stati sostituiti da valutazioni descrittive, dove alla didattica tradizionale si alternano didattica cooperativa, lavori di gruppo, autovalutazione dei ragazzi e delle ragazze.
Il progetto, che da sette anni coinvolge due sezioni dell’istituto si chiama, ironia della sorte, «La scuola delle relazioni e delle responsabilità». Non l’educazione alle relazioni, ma la scuola delle relazioni perché tutta l’attività scolastica si basa sulle relazioni: tra studenti, tra studenti e docenti, tra docenti e famiglie.
È un’esperienza che dimostra che non solo si può fare, ma è già stato fatto con risultati eccellenti.
Si tratta di avere il coraggio di cambiare e prendere le distanza da quella tradizione che per troppo tempo ha paralizzato la scuola italiana rendendola sovente luogo poco accogliente e poco adatto alla crescita serena e alla libera espressione del pensiero e della realtà personale dei ragazzi e delle ragazze. Si tratta di avere il coraggio di trasformarla questa scuola e renderla un luogo dove ogni giorno l’incontro con l’altro è motivo di crescita intellettuale e affettiva.
Forse non potrà essere l’unica strada per affrontare in modo incisivo il problema della violenza sulle donne, ma certamente può essere la base su cui costruire idee e pensieri diversi in cui ci sia lo spazio affettivo e culturale per le identità di tutti e di tutte.
Questo articolo è tratto da Left di gennaio 2024
Illustrazione di Fabio Magnasciutti per Left