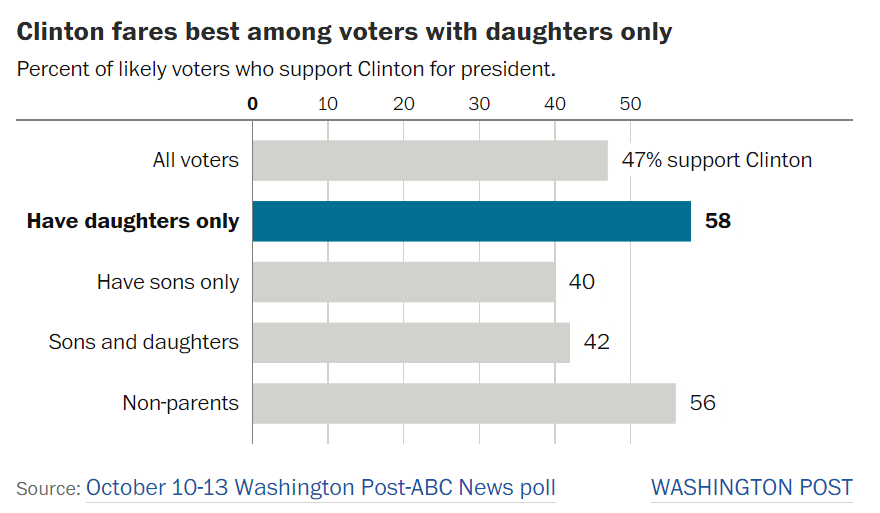Mentre la Lega pretende che si insegni il dialetto”lombardo” a scuola, l’italiano si prende una bella rivincita. Oggi è al quarto posto fra le lingue più studiate al mondo dopo l’inglese, lo spagnolo e il cinese. Nella Giornata ProGrammatica di Radio3 il 19 ottobre tutto il palinsesto è dedicato all’italiano, con decine di ospiti e il coinvolgimento di Istituti di cultura italiana. Anche questa quarta edizione si conclude con la serata speciale condotta da via Asiago a Roma da Giuseppe Antonelli che sarà trasmessa dalle 21 alle 23 in diretta su Radio3 e in streaming video sul sito radio3.rai.it. Ecco cosa ha detto il linguista Antonelli a Left:
La lingua lombarda rischia di estinguersi. Armata di questa convinzione la Lega Nord torna a voler imporre l’insegnamento della lingua lombarda nelle scuole. «Non ha proprio senso insegnare i dialetti», dice però il linguista Giuseppe Antonelli. «Il dialetto è sempre stato la lingua degli affetti, della vita quotidiana»,spiega il docente dell’università di Cassino e autore de La lingua batte ogni domenica su Radio 3. «E poi non è vero che i dialetti vadano scomparendo. Una ricerca Istat dice che sono molto vivi. Mentre sono scesi al 2 % gli italiani che parlano solo il dialetto». Una conquista importante. «La grammatica italiana è un diritto», scriveva Gramsci. E gli italiani lo hanno conquistato a fatica, come si evince dalle prove di italiano per l’iscrizione alle liste elettorali che Antonelli cita nel suo nuovo Un italiano vero. La lingua in cui viviamo (Rizzoli). «In tempi di email e social network è più che mai importante studiare l’italiano scritto» aggiunge il conduttore della IV edizione della Giornata pro-grammatica in onda su Radio3. «Per gran parte degli italiani il diletto rappresenta la dimensione familiare, giocosa, colorita. Pasolini, che preconizzava un italiano tecnocratico e freddo, aveva paura che la perdessimo». È accaduto invece che l’italiano è andato incontro a nuove sfide. «Non basta parlarlo, bisogna saperlo scrivere, in modo diverso, dagli sms. Per questo servono più ore di italiano a scuola, invitando alla lettura di romanzi e poesia».
Anche il linguista e critico letterario Gian Luigi Beccaria dice, da sempre, che non avrebbe senso studiare i dialetti in classe. «E poi quali? Il lombardo non esiste. Dovremo insegnare il bergamasco, il piacentino, il milanese? Il torinese o il biellese o il langarolo? I dialetti sono moltissimi ed è la nostra grande ricchezza. In dialetto si possono scrivere poesie, c’è un’ampia tradizione da Raffaello Baldini a Zanzotto, ma non per questo possiamo fare a meno dell’italiano», commenta il professore emerito dell’università di Torino, autore di molti saggi, di un dizionario di linguistica e filologia e ora de L’italiano che resta (Einaudi), un appassionato viaggio nella lingua come organismo vivo, in continuo cambiamento. Un libro di ricerca, ricchissimo di informazioni, che trasmette l’emozione della scoperta di parole nuove ma anche di perle ormai desuete. Si scopre così che tantissime espressioni dialettali innervano già l’italiano, che nel corso dei secoli ha mutuato termini da una pluralità di lingue antiche. Non solo dal latino. I prestiti dal latino liturgico vanno scomparendo in una società che oggi è sempre più secolarizzata, come ha documentato Beccaria in libri come Sicuterat, il latino di chi non lo sa e dedicati a santi, demoni e folletti.
Molti sono i termini venuti dal greco antico e di uso quotidiano. «L’italiano attuale deve molto al greco» sostiene Antonelli. «Secondo il dizionario di Tullio De Mauro più del 2 % delle parole italiane hanno un etimo greco, non solo termini specialistici, ma anche parole di uso comune come atmosfera, entusiasmo, fase, sintomo ecc.». Ancor più interessante è scoprire la quantità di termini arabi che l’italiano ha assorbito, passando attraverso il dialetto veneziano e quello siciliano. A questo tema Beccaria dedica una parte del suo nuovo libro. Solo per citare un esempio: zecchino nasce dalla Zecca veneziana dal 1540. E zecca è un arabismo.
«L’importanza dell’arabo è stata enorme nella nostra storia. Anche se oggi, purtroppo, il mondo musulmano ci offre parole legate ai conflitti, alla guerra, al Jihad ma non è sempre stato così», dice Beccaria a Left. «L’arabo nel medioevo, e anche in seguito, ci ha dato una quantità enorme di parole. Trasformarono la Sicilia in un giardino d’Europa. Lo stesso fecero in Andalusia. Parole come arancio, zucchero carciofo, albicocca, limone sono arabe. E tante vengono dall’ambito della scienza, dell’astronomia, all’algebra ecc. I latini e i greci non avevano una parola e un concetto per indicare lo zero, il nulla, il vuoto. L’uso dello zero nell’espressione dei numeri viene dagli arabi. Ci hanno veramente arricchito di parole e di cultura». «C’è una originaria vicinanza fra la cultura araba e la nostra lingua continua a recarne traccia», aggiunge Antonelli. Prima di parlare di scontro fra culture, dovremmo avere consapevolezza di quanto noi gli dobbiamo anche in termini linguistici». Basta camminare nella parte più antica di Palermo per notare nomi di strade scritti in arabo ed ebraico. Ma si possono vedere anche interni di palazzi, come la misteriosa sala blu, decorati con calligrafie arabe. Per il linguista rivelatori sono gli antichi nomi delle strade che spesso indicano nomi o lavori scomparsi. Anche i graffiti, le scritte sui muri, di cui Pompei era piena, sono tracce preziose, al pari dei testi letterari. Come insegna Beccaria che ne fa uno strumento affascinante di ricerca, insieme a canti anarchici e della resistenza, filastrocche trasmesse di generazione in generazione. La tradizione orale permette di capire molto di come è mutato l’italiano soprattutto in anni più vicini a noi. Più rare e fortunose sono le scoperte di documenti antichi. Ma a volte sono straordinarie come quella avvenuta qualche anno fa nell’archivio di Stato di Roma grazie al linguista Pietro Trifone.
Nel borgo di Collevecchio, Bellezze Ursini si manteneva facendo la domestica e la guaritrice, un’attività “mal vista” dalla Chiesa. Nel 1527 fu accusata di stregoneria e torturata. Stremata, scrisse una confessione autografa. Che non servì a niente. Prima di finire sul rogo, preferì suicidarsi. Quelle sue otto paginette ci dicono molto di un italiano popolare allora ancora in fieri, racconta Giuseppe Antonelli. «Ci dicono che nella campagna romana ci poteva essere, agli inizi del ‘500, una donna, una popolana, che sapeva scrivere». Colpisce anche la trascrizione ufficiale che ne fece il notaio Luca Antonio, normalizzando il linguaggio della donna per farle dire ciò che ci si sarebbe aspettati da una “strega”. «Quel modo di tradurre la grammatica di Bellezze in quella del potere mette bene in luce il confronto/scontro tra due mondi sociali e culturali di cui la lingua è al tempo stesso spia e strumento. Emerge la lotta, poi durata secoli, con la lingua ufficiale da parte di persone che invece venivano da situazioni socioculturali meno avvantaggiate», approfondisce Antonelli. Quel 1527, l’anno del sacco di Roma «fu anche un momento di svolta per l’italiano». Nonostante il dominio della Chiesa e il latino liturgico, il volgare si presentava come una lingua fluida, duttile, rivendicata da artisti come Leonardo che si definiva con orgoglio «omo sanza lettere», snobbando i latinisti tromboni. Ma proprio mentre si diffondeva un volgare vivo e popolare (fra romanzi, leggende e grammatiche) nel 1525 Pietro Bembo pubblicò Le prose della volgar lingua. «L’umanista veneziano fu rigidissimo nel prescrivere forme riconducibili al modello di Petrarca e di Boccaccio».
Così se Dante e il fiorino, ovvero la potenza economica dei mercanti toscani, «avevano contribuito alla diffusione del fiorentino come lingua di prestigio, tutto questo fu formalizzato dall’umanista veneziano», risponde Antonelli alla nostra domanda sulla discussa egemonia del fiorentino. «Nel 1525 Bembo indicò come modello per la lingua letteraria che oggi chiamiamo italiano quello usato da Boccaccio per la prosa e da Petrarca per la poesia». Quanto a Dante, «Bembo lo teneva un po’ fuori, giudicava il suo fiorentino troppo plebeo e concreto. Da studioso che amava le lingue morte come il latino, Bembo scelse una lingua che all’epoca era già estinta da due secoli». Dando origine così a una lingua letteraria, «basata sugli eccellenti scrittori» protetta dai puristi, anche quelli di fede giacobina, e deprecata da Mazzini che non sopportava di rivestire il pensiero «della lingua de’morti e d’uno stile pedantesco».
Del tutto nuova fu la posizione di Leopardi, al quale – seppur da differenti punti di vista- entrambi gli studiosi che abbiamo interpellato dedicano uno spazio di rilievo nei loro libri. «Leopardi era un amante della tradizione letteraria italiana, era un grande conoscitore della letteratura delle origini, ma non era un purista», spiega Antonelli. «Aveva un’idea della lingua come qualcosa di vivo, ne ammetteva la libertà. Mentre in tanti lottavano contro i francesismi lui li chiamava europeismi. E li considerava, come i grecismi, un patrimonio comune alle varie lingue d’Europa». Anche per liberare il poeta di Recanati da una mitizzazione che lo allontana dai lettori, Giuseppe Antonelli ha scritto il saggio Comunque anche Leopardi diceva le parolacce (Mondadori, 2014). «L’autore delle Operette morali era un raffinato, un fine conoscitore della nostra lingua, sapeva usare registri e toni diversi, passando dalla poesia ai saggi, alle lettere. Quando scriveva agli amici per sfogarsi di un amore non corrisposto o di un insuccesso letterario si lasciava andare. Era capace di passare dal sublime a uno stile concreto, a seconda dell’interlocutore. Tutto questo – ribadisce Antonelli – può avvenire solo si conosce profondamente la lingua, le sfumature le differenze di registro, di costrutto». Ad incipit di Un italiano vero cita, non a caso, un passo dello Zibaldone: «La libertà nella lingua- scriveva Giacomo Leopardi – dee venire dalla perfetta scienza e non dall’ignoranza».
Come poeta Leopardi sceglieva le parole per il suo
no, ma usando la parola scienza sembrava alludere anche di una scelta legata a una ricerca di conoscenza. «Interessante è ciò che emerge studiando le minute di Leopardi e osservando le varianti» commenta Beccaria con sguardo da filologo.
«Nel libro parlo di Giorgio Caproni e di altri autori ma Leopardi è il principe dei poeti. Studiando le “sudate carte”, gli scartafacci, emerge il suo lavorio continuo, e ci permette di vedere la direzione che voleva prendere», commenta Gian Luigi Beccaria, che nel libro, per esempio, pone l’accento su cambiamenti come il passaggio da «infinito spazio», quasi una citazione galileiana, a «infiniti spazi». «Al singolare Leopardi preferisce un plurale, perché è più “astratto”. È un poeta che cerca il vago e il concreto insieme, riuscendo a conciliare le due cose. Ha un dono particolare: saper orchestrare la sua partitura, i suoni delle vocali, i rimandi, le assonanze interne, le consonanze, c’è una musica interna. È come un musicista che cerca l’intonazione».

Continua su Left in edicola dal 15 ottobre