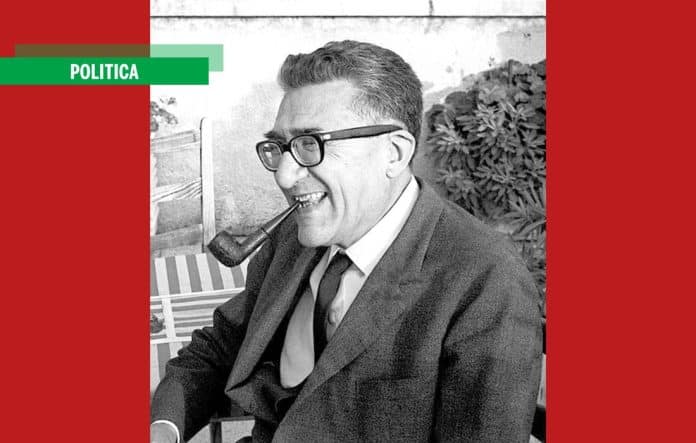L’arte è la più potente arma contro l’oppressione. Non a caso è il principale nemico di dittature e teocrazie. Un filo forte del pensiero lega il nuovo libro di Azar Nafisi, Leggere pericolosamente (Adelphi), ai lavori precedenti della scrittrice iraniana che da tanti anni vive esule negli Stati Uniti. Questo appassionante saggio, di cui parlerà il 23 settembre al Festival delle idee a Mestre (dopo aver ricevuto un premio a Pordenonelegge), forma una tetralogia intellettualmente sovversiva con altre sue opere come Quell’altro mondo, Leggere Lolita a Teheran e La repubblica dell’immaginazione.
«I dittatori e i tiranni odiano le idee e l’immaginazione. Le idee e l’immaginazione si oppongono alle dittature e alla tirannia perché sono conoscenze che mettono in collegamento le cose e permettono il cambiamento della realtà», risponde Nafisi a Left. «I tiranni e i dittatori odiano i cambiamenti e la libertà. Non solo: dittature e tirannidi si basano su falsità e menzogne. Ogni vera narrazione si basa su una polifonia di voci in dialogo tra di loro. Niente di più lontano da quello che succede in dittature e regimi».
Con Leggere Lolita a Teheran lei piazzò una vitale bomba intellettuale nel cuore del regime di Khomeini e fu espulsa dall’università di Teheran dove insegnava, anche perché si rifiutava di indossare il velo. Cosa pensa oggi di quella esperienza?
Con il mio Leggere Lolita ho cercato di creare uno spazio di libertà in cui si potessero leggere i libri e usare gli insegnamenti di scrittori e intellettuali senza paure di censure, punizioni, gabbie e prigionie. La consapevolezza che ne ho ricavato è che la letteratura è esattamente questo: libertà. Così come mi è capitato di conoscere l’Italia prima di venirci per la prima volta attraverso Collodi, Calvino, e ancora attraverso Antonioni, Rossellini e De Sica, così i miei allievi imparavano il mondo senza essere mai usciti dall’Iran.