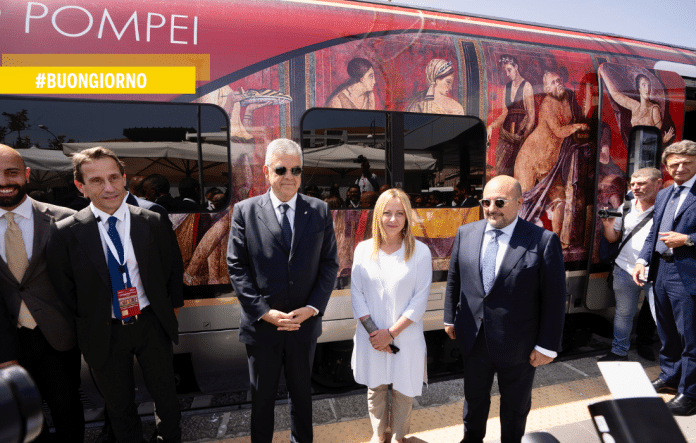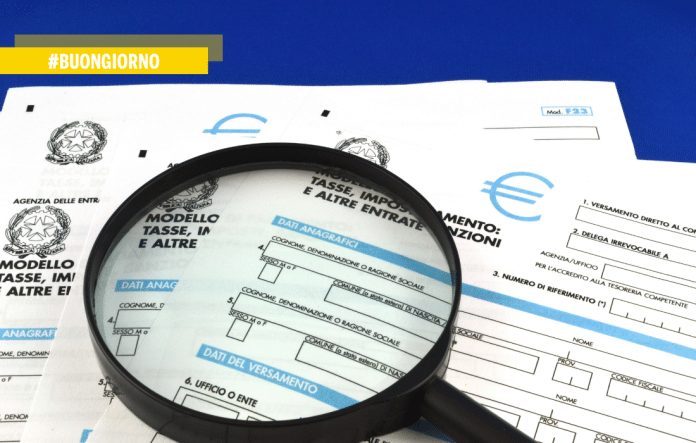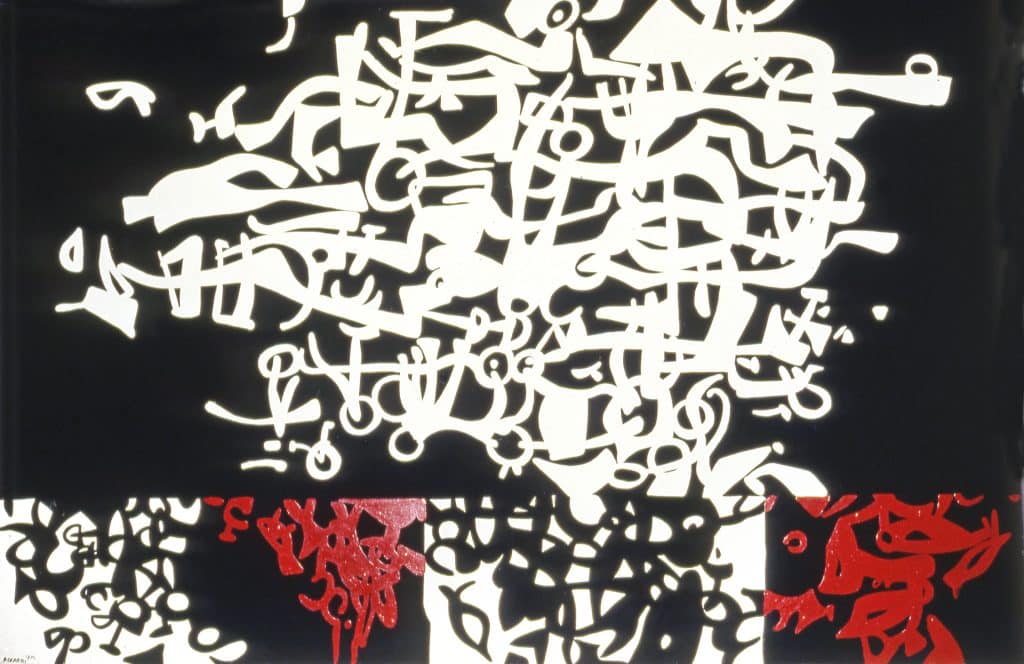Trent’anni fa, il 31 agosto 1994, l’Ira (Esercito repubblicano irlandese) annunciava il cessate il fuoco che avrebbe aperto la strada al processo di pace nell’Irlanda del Nord. «Riconoscendo il potenziale della situazione attuale e al fine di favorire il processo democratico», la dirigenza dell’Irish Republican Army rendeva noto che avrebbe sospeso «qualunque operazione militare» a partire dalla mezzanotte.
Nel comunicato si leggeva, fra le altre cose, «Riteniamo che siano state realizzate le condizioni per stringere un accordo giusto e destinato a durare». Veniva citata la Dichiarazione di Downing Street, il comunicato congiunto diffuso il 15 dicembre 1993 dal Primo ministro britannico John Major e dal Taoiseach (il capo del governo) della Repubblica d’Irlanda Albert Reynolds, anche se si osservava che la dichiarazione non rappresentava di per sé una soluzione. Quella, proseguiva il documento, sarebbe stata raggiunta solo «come risultato di negoziati inclusivi».
Il cessate il fuoco dell’Ira rappresenta una tappa decisiva nel processo di pace che portò alla firma dell’Accordo di Belfast, detto anche Accordo del venerdì santo, del 10 aprile 1998 e, successivamente, alle elezioni per l’assemblea legislativa locale e all’insediamento di un esecutivo “consociativo” (basato cioè sulla condivisione del potere fra i rappresentanti delle due principali comunità politico-religiose del Nord) con competenza su un certo numero di responsabilità devolute da Londra.
Le tappe che precedettero questo storico annuncio sono ben note. Nel novembre 1990, in un discorso pubblico del ministro per l’Irlanda del Nord Peter Brooke, fece la sua comparsa una formula che sarebbe ritornata nella Dichiarazione di Downing Street e che avrebbe rivestito un’importanza decisiva. Brooke, autorizzato dalla premier Margaret Thatcher e d’accordo con John Hume, il segretario del Partito socialdemocratico laburista (Sdlp) dell’Irlanda del Nord, dichiarò che il Governo britannico non aveva alcun «interesse strategico o economico nell’Irlanda del Nord». Nell’aprile 1993 venne pubblicato il primo comunicato congiunto emesso dai leader di Sinn Féin e del Sdlp: il documento era l’esito di una serie di incontri riservati che il repubblicano Gerry Adams e il moderato John Hume avevano avuto nella prima metà del 1988 allo scopo di riattivare il dialogo fra le due anime del nazionalismo. Nell’autunno dello stesso anno l’iniziativa Hume-Adams venne commentata favorevolmente dall’Ira mentre, grazie all’impegno del segretario del Sdlp, i risultati dei negoziati fra i due leader nazionalisti venivano studiati attentamente dai governi di Londra e Dublino.
Si giunse così alla Dichiarazione di Downing Street, che segnava un netto passo avanti sotto diversi aspetti. Londra riconosceva che spettava «soltanto alla popolazione dell’isola d’Irlanda… esercitare il diritto all’autodeterminazione in base al principio del consenso, affermato liberamente e simultaneamente, al Nord e al Sud, per realizzare l’unificazione dell’Irlanda, se questo sarà il suo desiderio». Il Primo ministro irlandese, da parte sua, affermava che «sarebbe sbagliato cercare di imporre un’Irlanda unita in assenza del consenso, liberamente espresso, della maggioranza della popolazione dell’Irlanda del Nord».
La Dichiarazione permise a Gerry Adams di vincere le resistenze degli elementi più sospettosi della dirigenza dell’Ira, che decise quindi di procedere con l’annuncio del cessate il fuoco il 31 agosto.
La natura del conflitto
Il conflitto, o meglio l’ultima fase del conflitto secolare fra i ribelli irlandesi e lo Stato britannico, divampa alla fine degli anni 60 del Novecento. Come data d’inizio si prende in genere l’invio dell’esercito britannico nelle Sei contee nell’estate del 1969, ma ci sarebbero ottime ragioni per assumerne altre: ad esempio il 7 maggio 1966, quando un gruppo di unionisti filo britannici guidati da Gusty Spence, un ex militare, diede il via a una serie di attentati contro cittadini nazionalisti o cattolici scelti del tutto a caso, riesumando il nome Corpo volontario dell’Ulster (Uvf) e facendo tre morti prima di finire in cella alla fine di giugno. Oppure il 5 ottobre 1968, data della prima risposta violenta della polizia del governo unionista, a Derry, alla mobilitazione pacifica per i diritti civili dei cittadini irlandesi. Quest’ultima sarebbe a mio parere la più indicata, perché permetterebbe di ricordare la vera ragione dietro lo scoppio del conflitto, vale a dire l’incapacità, o la mancanza di volontà, dello Stato britannico, di garantire a tutti i propri cittadini, anzi a tutti i propri sudditi, parità di condizioni e uguaglianza davanti alla legge.
L’estate del 1969, invece, è più funzionale alla narrazione che diventerà quella prediletta di una delle due principali parti in causa, cioè Londra, soprattutto a partire dalla metà degli anni 70, per spiegare il conflitto. L’estate 1969, infatti, è la stagione dei violenti pogrom scatenati dagli estremisti unionisti, con la connivenza della polizia nordirlandese, contro la popolazione nazionalista e cattolica: l’esercito verrà schierato nelle Sei contee principalmente per difendere i cattolici dalla violenza degli estremisti protestanti e della polizia. Questa è appunto la lettura che diventerà narrazione dominante, cioè i Troubles come esito del secolare conflitto fra due comunità in lotta fra loro, divise dalla religione e dall’identificazione nazionale, gli uni fedeli alla Corona e gli altri all’obiettivo di un’Irlanda unita e sovrana.
La vera natura del conflitto emerge peraltro chiaramente dalla storia dei contatti segreti fra Londra e l’Ira susseguitisi nel corso degli anni nel tentativo di mettere fine alla violenza. Il primo contatto ebbe luogo già agli albori dei Troubles: il 20 giugno 1972 Dáithí Ó Conaill, uno dei comandanti dell’Ira nonché uno dei suoi principali strateghi, incontrò due funzionari del governo britannico guidato dal conservatore Edward Heath e del MI6 (il servizio segreto esterno) con il benestare del ministro per l’Irlanda del Nord William Whitelaw. All’incontro, che si tenne in una casa di campagna al confine con il Donegal, partecipò un giovane Gerry Adams che, a testimonianza dell’autorevolezza che gli veniva riconosciuta già all’età di 23 anni, fu appositamente scarcerato per ordine dello stesso Whitelaw. L’incontro si rivelò positivo e servì a preparare un successivo incontro che si sarebbe tenuto due settimane dopo, questa volta a Londra. Il 7 luglio una delegazione dell’Ira guidata dallo stesso capo di stato maggiore Seán MacStiofáin venne caricata in gran segreto su un aereo della Raf e portata a Londra per incontrare lo stesso Ministro Whitelaw. Questo incontro, che si tenne in uno dei quartieri più esclusivi della capitale britannica, non ebbe alcun esito, soprattutto per l’intransigenza di Seán MacStiofáin. Della delegazione faceva parte un altro giovane, di appena 22 anni, che sarebbe diventato di lì a poco uno dei principali alleati di Gerry Adams e si sarebbe rivelato una delle figure centrali sia della lotta del movimento repubblicano sia del lento cammino verso la pace: Martin McGuinness.
Nel maggio 1973 un altro funzionario del MI6, Michael Oatley, nome in codice “Mountain-climber” (lo scalatore) riuscì a stabilire una linea di comunicazione segreta con un negoziante di Derry, Brendan Duddy, vicino a Martin McGuinness, ora comandante della Brigata Derry dell’Ira. Questo canale non diede frutti immediati, ma si rivelò estremamente importante negli anni successivi, soprattutto durante gli scioperi della fame del 1980-81 e, ancora di più, all’inizio degli anni 90. Intanto, contatti segreti avevano avuto luogo fra l’Ira e il governo laburista di Harold Wilson a cavallo fra il 1974 e il 75; anche in quel caso furono coinvolti Michael Oatley e Brendan Duddy. Nel febbraio 1977 perfino l’allora leader dell’opposizione a Westminster, Margaret Thatcher, autorizzò un proprio rappresentante a incontrare Gerry Adams e Danny Morrison a Belfast. Infine, nell’ottobre 1990, Brendan Duddy organizzò un incontro fra Michael Oatley e Martin McGuinness, che ricopriva anche la carica di vice presidente di Sinn Féin, che si tenne a Derry. Il canale di comunicazione fondamentale era stato di nuovo stabilito e avrebbe garantito contatti costanti e proficui per i successivi 4 anni, fino al cessate il fuoco dei repubblicani del 31 agosto 1994.
La pressione militare
Nei lunghi anni dei Troubles, i contatti segreti fra l’Ira e Londra procedettero di pari passo con l’evoluzione del conflitto armato. La violenza rese sempre ovviamente tutto più complicato. In alcuni casi fece fallire i negoziati. In altri casi, d’altro canto, costituì uno sprone per esercitare autocontrollo, pazienza e rinnovare l’impegno per mantenere attivi i canali di comunicazione o per riattivarli.
La seconda metà degli anni 80 non fu un periodo semplice per le prospettive di pace. L’Ira riuscì a ripristinare il rapporto con il colonnello Gheddafi, a seguito degli scioperi della fame del 1981, garantendosi una nuova insperata fonte di approvvigionamento di armi e denaro che diede nuovo impulso alla propria campagna militare. Nel 1987 le autorità intercettarono un carico di 150 tonnellate di armi proveniente dalla Libia e si scoprì così che nei due anni precedenti l’Ira ne aveva già ricevuti ben quattro. I dettagli arrivarono qualche anno dopo, nel 1992, quando Gheddafi cercò di recuperare il rapporto con Londra e rivelò i dettagli del suo sostegno ai repubblicani irlandesi, iniziato nel 1973 e poi messo da parte per circa un decennio. In anni recenti sono stati pubblicati documenti d’archivio che rivelano che, più ancora delle armi, fu l’entità del contributo economico che lasciò esterrefatti gli inglesi. Pare che nel corso di quei circa 15 anni il governo libico abbia fatto arrivare ai Provos, in contanti, l’equivalente di 40 milioni di Euro dei nostri giorni.
Così, l’Ira potè intensificare la propria offensiva sia nelle 6 contee sia in Inghilterra (i Provos hanno sempre insistito che non avrebbero mai colpito la Scozia o il Galles): il 7 febbraio 1991 l’Ira attaccò a colpi di mortaio nientemeno che il numero 10 di Downing Street mentre era in corso una riunione del gabinetto di guerra del premier conservatore John Major per discutere della situazione in Iraq. Il 10 aprile 1992 i Provos fecero esplodere un furgone pieno di Semtex presso il Baltic Exchange, nella City di Londra. La bomba, la più potente esplosa in Gran Bretagna dalla fine della Seconda guerra mondiale, causò tre morti e danni per ottocento milioni di sterline. Il 20 marzo 1993 l’Ira fece esplodere due ordigni a Manchester; le esplosioni causarono la morte di due bambini di tre e dodici anni. Poco più di un mese dopo, il 24 aprile, i repubblicani colpirono di nuovo la City di Londra con un camion bomba che esplose presso il grattacielo 99 Bishopsgate. La deflagrazione devastò l’intero quartiere e causò oltre un miliardo di sterline di danni. Grazie a un preavviso più preciso rispetto a quello di attentati precedenti ci fu una sola vittima, un fotografo che ignorò gli avvertimenti della polizia per avvicinarsi il più possibile alla zona segnalata. Intanto, l’Ira aveva intensificato la propria offensiva nell’Irlanda del Nord colpendo perfino alcuni elicotteri dell’esercito britannico: fra il 1988 e il 1994 riuscì a colpirne ben quattro con mitragliatrici o con mortai artigianali, abbattendoli o costringendoli ad atterraggi di fortuna.
Dal canto loro, i militari britannici non intendevano porgere l’altra guancia: l’8 maggio 1987 l’esercito tese un agguato a un commando dell’Ira che intendeva assaltare una caserma della polizia a Loughgall, nella contea di Armagh. Un’unità dello Special Air Service (Sas) aprì il fuoco uccidendo otto guerriglieri e un passante. Il 6 marzo 1988, a Gibilterra, tre volontari dell’Ira, due uomini e una donna, furono intercettati dal Sas e uccisi a sangue freddo con diversi colpi di arma da fuoco. Tutti e tre erano disarmati e vestiti con abiti leggeri. Il Sas colpì ancora il 3 giugno 1991 uccidendo tre volontari dell’Ira armati in un’auto a Coagh, nella contea di Tyrone.
Gli stessi anni videro anche una recrudescenza della violenza delle milizie lealiste filo britanniche, volta principalmente a colpire civili cattolici scelti a caso per terrorizzare la popolazione nazionalista e scoraggiarne il sostegno all’Ira. Nel 1987 Brian Nelson, un ex soldato originario di Shankill Road, a Belfast, che due anni prima era stato reclutato dal servizio segreto britannico e infiltrato nella milizia lealista Associazione per la difesa dell’Ulster (Uda), si recò in Sud Africa per trattare l’acquisto di un grosso quantitativo di armi. Una parte delle armi venne intercettata e confiscata dalla polizia, ma una parte venne distribuita fra le principali milizie lealiste, principalmente l’Uda e l’Uvf. Contemporaneamente Brian Nelson, che nel frattempo era assurto al ruolo di responsabile del servizio informazioni dell’Uda, passava documenti riservati su persone sospettate di fare parte dell’Ira, fornendo così ai miliziani lealisti gli obiettivi da colpire. Quello di Brian Nelson fu uno dei casi esaminati all’inizio degli anni 90 dal funzionario di polizia britannico John Stevens nel corso dell’inchiesta che condusse sulle denunce di collusione fra le autorità e le milizie lealiste filo britanniche. Interrogato dalla commissione Stevens, Brian Nelson confermò di avere agito in base a istruzioni delle autorità britanniche. Condannato a una serie di pene detentive nel 1992, Brian Nelson scontò sei anni di prigione. Morì nel 2003 a soli 55 anni.
Nei primi anni 90 sia l’Ira sia Londra riconoscevano, in alcuni casi pubblicamente, che una soluzione militare del conflitto era impossibile. L’Ira sapeva di non essere in grado di cacciare gli inglesi dall’Irlanda e Londra si rendeva conto che avrebbe potuto anche contenere l’Ira, ma non sconfiggerla. I tempi erano maturi per una soluzione di altro tipo.
Il processo di pace
Il percorso non fu né rapido né semplice, anche se nelle prime settimane dopo la tregua annunciata dall’Ira vi furono segnali incoraggianti. Il 13 ottobre 1994 le principali milizie filo britanniche annunciarono il cessate il fuoco con un comunicato congiunto che venne letto da Gusty Spence, l’uomo che aveva guidato l’inizio della campagna di terrore contro la popolazione nazionalista di Belfast nel maggio 1966. I lealisti vennero così coinvolti attivamente nel processo di pace, attraverso due piccoli partiti che da qualche anno si stavano proponendo come interlocutori politici a nome dei miliziani armati. Questa configurazione del processo di pace era ovviamente funzionale alla narrazione alla quale ho già accennato, quella della riconciliazione fra le due comunità in lotta fra loro; un’impostazione non certamente gradita ai repubblicani che, tuttavia, Sinn Féin dovette giocoforza accettare.
Ci vorranno più di tre anni per giungere alla firma dell’Accordo di Belfast, nell’aprile 1998, e ai successivi referendum popolari confermativi svoltisi su entrambi i lati del confine, e altri nove per giungere alla formazione del secondo esecutivo consociativo che vide l’adesione del Partito unionista democratico (Dup), ora partito di maggioranza della comunità unionista, e l’inizio della coabitazione con Sinn Féin.
I recenti successi elettorali di Sinn Féin, ora guidato da due donne, Mary Lou McDonald e Michelle O’Neill, hanno premiato la lungimiranza di chi 30 anni fa si assunse rischi non indifferenti per convincere il movimento repubblicano a proseguire la lotta sul terreno politico: Sinn Féin è attualmente il primo partito all’Assemblea di Belfast, nel voto amministrativo locale e persino in quello per il Parlamento di Westminster. Dallo scorso febbraio Michelle O’Neill ricopre la carica di Primo ministro dell’esecutivo di Belfast, affiancata da un’altra donna, nel ruolo di Deputy First Minister, Emma Little-Pengelly (Dup), figlia di un ex miliziano lealista.
Le sfide che deve affrontare il governo consociativo di Belfast sono tante, a partire dallo stato in cui versa la sanità pubblica nelle Sei contee, ma è bene ricordare che il solo fatto di avere istituzioni locali finalmente funzionanti è di per sé un grande risultato e che non sarebbe mai stato possibile senza una pre-condizione fondamentale, vale a dire la pace.
L’autore: Carlo Gianuzzi è co-autore e co-conduttore di Diario d’Irlanda, trasmissione diffusa da Radio Onda d’Urto. Sua la foto di apertura