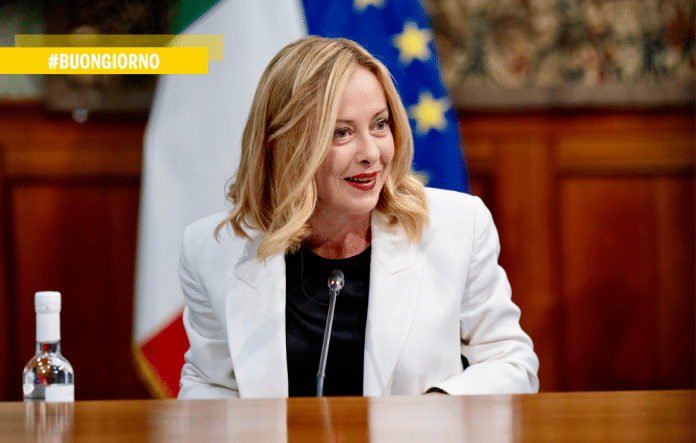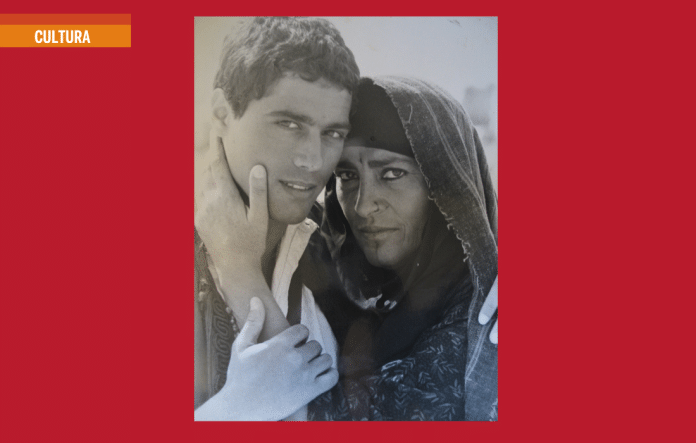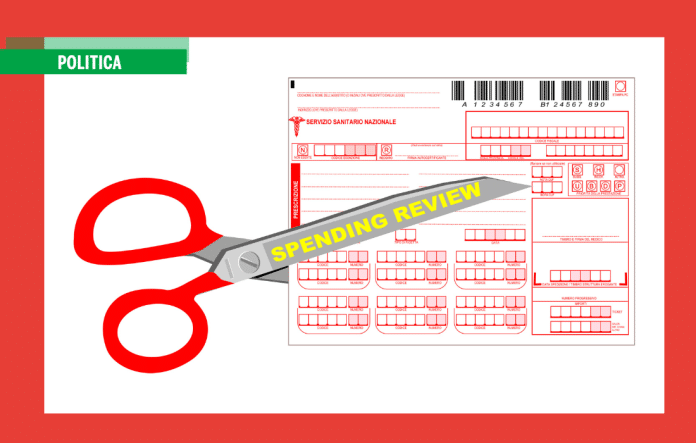“Icchè Ci Vah Ci Vole” è un nome che suona bene e che colpisce subito. È il nome dell’organizzazione, ente del terzo settore, che ha dato vita al progetto LUMEN Laboratorio Urbano MENsola. Ma cosa significa “Icchè Ci Vah Ci Vole”? È un’espressione fortemente fiorentina che vuol dire “quel che ci va, ci vuole” – ciò che sentiamo di fare è necessario e deve essere realizzato con impegno. Si possono avere molte idee, ma ci vogliono impegno, passione, dedizione, tanta creatività e una grande voglia di mettersi in gioco per realizzarle davvero.
L’organizzazione fiorentina Icchè Ci Vah Ci Vole (ICVCV), nata nel 2017 dall’unione delle associazioni Riot Van, No Dump e Progeas Family, ha creato uno spazio meraviglioso alle porte di Firenze. Non solo per la bellezza del luogo, immerso nel verde e immediatamente accogliente, ma soprattutto per la sua missione.
LUMEN è uno spazio concesso gratuitamente dal Comune di Firenze, in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria. Si tratta di un importante progetto di rigenerazione urbana basato sulla cultura, che riqualifica il patrimonio immobiliare comunale e crea socialità in uno spazio pubblico dismesso. L’obiettivo è quello di creare un nuovo polo culturale accanto al neonato Parco del Mensola. Il nome LUMEN significa “Laboratorio Urbano Mensola”, ma “lumen” è anche l’unità di misura del flusso luminoso, che rappresenta la quantità totale di luce emessa da una sorgente luminosa. Una bella immagine per uno spazio che mira a rigenerare gli spazi attraverso la cultura.

Abbiamo incontrato l’architetto e dottoranda in tecnologia dell’architettura Arianna Camellato durante un corso di formazione organizzato dall’organizzazione capofila ICSE & co. ETS e accreditata nel settore gioventù presso l’Agenzia nazionale per la gioventù. Questo corso, finanziato dall’Unione Europea, era incentrato sulle dinamiche di apprendimento e sulla promozione dei processi partecipativi tra i giovani. Ha coinvolto operatori giovanili provenienti da tutta Europa, riuniti a Firenze. La collaborazione di ICSE&co., esperta nell’educazione non formale nel settore giovanile, il know-how di Arianna Camellato sul tema dei processi partecipativi e gli spazi di LUMEN messi a disposizione, hanno reso tangibile il concetto di partecipazione. Il prossimo corso, intitolato “Your game”, si terrà dal 30 agosto al 6 settembre, con l’obiettivo di migliorare le competenze degli operatori giovanili nell’uso e nella creazione di giochi educativi. Un esempio quest’ultimo di come diverse sinergie del territorio fiorentino si siano unite per fare cultura, esportandola a livello europeo tramite il programma Erasmus+.
Arianna Camellato, membro del direttivo di Icchè Ci Vah Ci Vole, originaria di Treviso, è arrivata a Firenze per studiare scienze dell’architettura dopo un passato da attivista nella sua città natale. Con la Rete degli studenti medi di Treviso come capofila, un gruppo di associazioni del territorio, e con il sostegno di Cgil e Sspi, hanno partecipato a un bando del Comune per recuperare uno stabile dismesso al fine di trasformarlo in un nuovo luogo aggregativo, capace di produrre cultura, integrazione, nuove forme di socialità, intergenerazionalità e cittadinanza attiva. «Abbiamo risistemato questo spazio, dismesso da anni, che è diventato un circolo Arci ed è stato restituito alla cittadinanza dopo vent’anni. Un circolo tuttora attivo che si chiama Binario 1».

Il background di Camellato si inserisce perfettamente in questo nuovo progetto che è LUMEN. Ma quando è nato esattamente così come lo conosciamo oggi? «Nasce nell’estate 2021, tra Settignano e Rovezzano, nel cuore del Parco del Mensola di Firenze. Sono stati recuperati 400 mq di immobile e 4.000 mq di verde, comprese 4 serre da 3.000 mq, in precedenza abbandonati, con la pratica dell’autocostruzione basata su criteri etici e di economicità. Possiamo affermare che LUMEN rappresenta un unicum nel territorio nazionale perché c’è stata un’assegnazione diretta da parte dell’amministrazione e non tramite bando come si era verificato con Binario 1. Il lungo curriculum dell’associazione e l’idea ben precisa di riqualificazione degli spazi ha fatto sì che ci fosse questa assegnazione diretta», racconta Camellato. Un accordo di concessione temporanea di 18 mesi che sarebbe stato propedeutico all’attivazione di una concessione trentennale, sempre finalizzato a restituire a questo spazio una nuova vita per la cittadinanza.
«Questa attivazione a livello trentennale ancora non si è verificata. Siamo all’interno di una serie di proroghe della concessione temporanea. Si tratta di progetti altamente sperimentali; non essendoci nulla del genere a livello nazionale, significa che non ci sono ancora le leggi e le condizioni burocratiche adatte alla gestione di questo tipo e noi vorremmo costruire un precedente».
Ma come è stato possibile ottenere la concessione degli spazi senza la presenza di un bando? «Abbiamo studiato molto e abbiamo rinvenuto l’esistenza dell’Articolo 20 del regolamento sui Beni Immobili del Comune. L’articolo, datato 2017, esprimeva la possibilità che in casi eccezionali, i beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile potessero essere assegnati in concessione gratuita a soggetti terzi sulla base di un progetto che evidenziasse utilità per la collettività».
Ci chiediamo a questo punto com vedete il futuro di LUMEN? “Vorremmo che LUMEN diventasse un laboratorio di sperimentazione per le realtà del territorio. Uno spazio dove le persone possano avviare imprese e creare valore attraverso attività culturali, costruendo reali opportunità lavorative nel terzo settore. Il terzo settore è molto collegato all’ottica del volontariato; invece, a noi piacerebbe riuscire a costruire delle reali occasioni lavorative nel settore culturale. Le possibilità, anche in termini burocratici, esistono, e quindi perché anche il terzo settore non potrebbe essere un motore di lavoro? Abbiamo avuto la necessità di prorogare la fase di concessione temporanea. Non ci sono state le condizioni politiche per riuscire a costruire un framework burocratico che fosse adatto a quello che volevamo fare. Nella volontà di costruire un precedente concreto e riproducibile, preferiamo aspettare che queste condizioni si allineino. Una volta che il progetto si dimostrerà veramente possibile e sostenibile, puntiamo a procedere».
La missione di LUMEN è creare uno spazio in cui le persone possano costruire autonomamente le opportunità per intervenire attivamente nella loro comunità. Attraverso la partecipazione e l’empowerment individuale, promuovendo la creatività, la partecipazione civica e la rigenerazione urbana, si incoraggia la costruzione di un ambiente in cui ogni individuo possa contribuire al cambiamento positivo. E riprendendo le parole del presidente di ICVCV Antonio Bagni: «Se realtà simili esistono a Berlino e Barcellona, perché non possiamo farlo anche noi a Firenze?».
Siamo pienamente d’accordo e chi visita LUMEN oggi percepisce subito una sensazione di accoglienza. Si può partecipare a laboratori, concerti, momenti di co-design, centri estivi e tante altre attività dell’associazione. Le persone possono stare in compagnia, godere delle attività, leggere un libro, mangiare una pinsa o semplicemente bere una birra da soli o in compagnia.
Ogni mese esce la programmazione, e si può partecipare a lezioni di medicina tradizionale giapponese, di kintsugi (la tecnica giapponese di restauro con l’oro), di yoga, dell’arte marziale kinomichi, e tanto altro ancora. Per i bambini ci sono molte attività di educazione in natura, diverse attività creative o legate ai libri. Il tema del gioco è una parte importante e, in collaborazione con l’Ingegneria del Buon Sollazzo, si è creato uno spazio giochi che è diventato un catalizzatore di scambio continuo: si possono vedere prima i bambini giocare, poi adulti e bambini insieme, fino a vedere nelle ore più tarde giocare solo gli adulti.
Un insieme quindi di iniziative creative e collaborative che dimostrano come spazi abbandonati possano essere trasformati in vivaci centri culturali.
L’autrice: Amarilda Dhrami è giornalista freelance