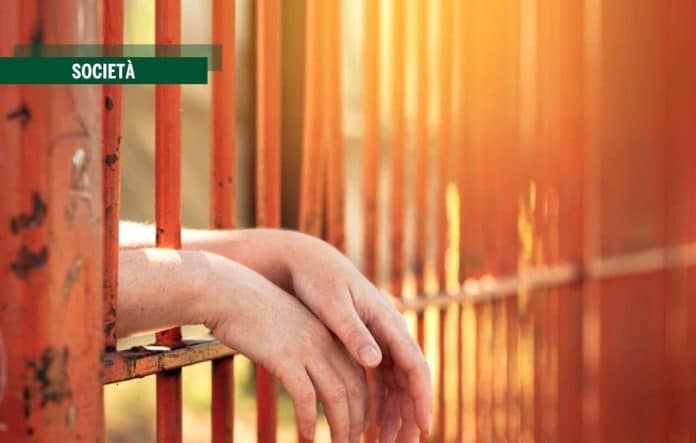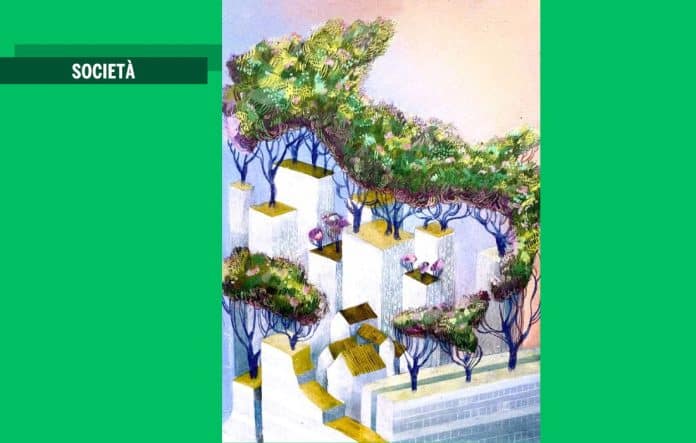Nel dibattito pubblico italiano le affermazioni di stampo razzista fanno parte della “normalità”, sono un dato acquisito su cui ci si può indignare, ma che, raramente danno luogo a provvedimenti giudiziari e che, soprattutto, non destano riprovazione sociale. Si impone una narrazione, fondata su ipocrisia e scarsa conoscenza della storia secondo cui “gli italiani non sono razzisti ma reagiscono all’immigrazione incontrollata”. Come a dire che, chi subisce atti di discriminazione, anche violenta, in fondo, restandosene a “casa” propria, li avrebbe evitati, “se la sono cercata”.
Ma la percezione dell’Italia fondata su una identità bianca e cristiana, non nasce ora e ed è connessa con una tematica mai seriamente affrontata, quella del passato coloniale. La lettura del volume Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria, dall’età liberale ai nostri giorni, di Valeria Deplano e Alessandro Pes e pubblicato da Carocci, aiuta a ricostruire un percorso che non è solo storico ma, utilizzando diversi aspetti dell’esperienza coloniale e post coloniale, prova a dare un’interessante e intensa traccia interpretativa. Gli autori, entrambi professori associati di Storia contemporanea all’Università di Cagliari, sono riusciti in un’impresa non facile. Attraverso un linguaggio coinvolgente e divulgativo quanto rigoroso dal punto di vista storiografico, in un volume denso e ricco di riferimenti bibliografici, attraversano un secolo e mezzo di vicende complesse, messe in evidenza in maniera netta. Il volume si compone di tre parti: il periodo colonialista nell’Italia liberale, con l’acquisto della baia di Assab, quello del ventennio fascista, e i cascami che si sviluppano nell’Italia repubblicana, i cui effetti permangono. Gli autori hanno recepito decenni di studi classici sul colonialismo italiano (Del Boca, Rochat, Labanca) elaborando, grazie a fonti archivistiche, studi sul campo, ricerca trasversale, una propria visione dell’esperienza coloniale come tratto fondativo dell’identità italiana. Utilizzando modalità di dominio diverse, tanto i tentativi di occupazione che iniziano a fine Ottocento, che quelli, fascisti, partono – come era cultura dell’epoca – dall’idea di “portare la civiltà”. Non è estraneo il ruolo propulsivo della Chiesa, continuato durante il fascismo, ma la convinzione di una superiorità razziale, in quanto tale destinata a imporsi, era parte integrante già nelle prime missioni in Eritrea, con l’acquisto, da parte della società di navigazione Rubattino, della baia di Assab a cui non era estraneo l’interesse del Regno d’Italia che, come le altre nazioni doveva avere le colonie perché, da nazione civile, le spettavano di diritto. Maturò un’impronta razzista resa più forte con le prime sconfitte militari, da Dogali ad Adua, che contribuì a creare un’immagine dell’indigeno come “nemico”. La pubblicistica tentava già di costruire, nelle scuole come nel mondo accademico e nell’immaginario popolare, il radioso futuro che poteva realizzarsi con una politica di potenza. L’occupazione della Libia fu un passo in avanti, la “quarta sponda” servì a sedimentare quello che sarebbe stato il punto di forza del fascismo: la presenza di vestigia archeologiche dell’Impero romano a cui bisognava rifarsi e di cui era lecito appropriarsi. Il fascismo, documentano Deplano e Pes, attuò l’accelerazione di un processo che era già in atto.
Quel che resta dell’impero è il razzismo
Maaza Mengiste: Vi parlo del “bravo italiano” in Etiopia
Il 1974 fu un anno cruciale per l’Etiopia. Hailé Selassié imperatore dal 1930 – esclusi i 6 anni di dominazione coloniale italiana – venne detronizzato, accusato di essere a capo di un governo corrotto e accentratore. L’avvento al potere dei militari, purtroppo, spinse successivamente il Paese in una drammatica guerra civile.
Nello stesso anno nasce ad Addis Abeba la scrittrice Maaza Mengiste, autrice di Lo sguardo del leone (Neri Pozza) e Il re ombra (Einaudi), considerati tra i migliori libri di letteratura africana post-coloniale. Costretta con la famiglia a lasciare il suo Paese, dove nessuno era più al sicuro, dall’età di tre anni Mengiste vive in America, dove tuttora insegna scrittura creativa presso l’Università di New York. Ambedue i libri, in modo diverso, fanno riferimento al 1974: il primo è ambientato nel turbolento periodo successivo alla caduta dell’imperatore, il secondo dedica a quei giorni solo alcune pagine all’inizio e alla fine per poi immergersi, come in un lungo flashback, negli anni del colonialismo e dell’occupazione italiana dell’Etiopia.
Il re ombra, vincitore per la narrativa del Premio The Bridge, del Gregori von Rizzori di Firenze e finalista del prestigioso Booker Prize, è stato recentemente ripubblicato e presentato alla Casa della memoria e della storia di Roma. Magistralmente tradotto da Anna Nadotti, il racconto prende lo spunto da alcune fotografie scattate durante il dominio coloniale in Africa, l’antico obiettivo che l’Italia perseguiva già dopo aver raggiunto l’unità e che, nonostante gli insuccessi, era stato ripreso da Benito Mussolini, con l’assenso dei Savoia, per «riportare l’impero sui colli fatali di Roma» come declamò all’indomani della caduta di Addis Abeba, il 9 maggio 1936. Si aprì, per l’imperatore Selassié, un periodo di esilio in Inghilterra, terminato solo nel 1941, quando le forze alleate liberarono il Paese.
La fotografia, come il cinema, è stato uno strumento molto utilizzato per la diffusione delle narrazioni dei vincitori ma stavolta le immagini, sotto l’acuto sguardo dell’autrice, hanno riportato alla luce la resistenza etiope. Dopo anni di un lungo lavoro di ricerca e di scrittura, Maaza Mengiste racconta una pagina di storia dimenticata, in particolare attraverso le donne, doppiamente violate durante le guerre e di cui non si parla o se ne parla troppo poco: Hirut, la giovanissima serva nella ricca casa del comandante Kidane, sua moglie Aster, e la silenziosa cuoca, figura preziosa e sempre attenta a quello che accade. Sono Hirut e Aster che di fronte all’occupazione straniera, superando ruoli e tradizioni patriarcali, diventano in grado di scegliere da che parte stare, cioè quella della difesa del proprio territorio, ritrovandosi a fianco degli uomini, senza più paura.
La ricostruzione della resistenza del popolo etiope consente di riscrivere una storia diversa da quella raccontata dai vincitori, scardinando inoltre quel mito di “Italiani, brava gente” come ha già fatto lo storico Filippo Focardi sulle pagine di questo giornale ed è stato dimostrato dall’uso dei gas nervini (l’Italia si ostinerà a negarlo fino al 1996) e dai massacri indiscriminati per fiaccare la resistenza degli etiopi.
La magnifica scrittura di Maaza Mengiste non mette in confronto storie di popoli e nazioni, ma racconta gli oppressi – chi si trova espropriato del proprio territorio – e gli oppressori, obbedienti esecutori del progetto di colonizzazione italiano. Tra gli italiani, l’autrice si sofferma su Ettore Navarra, veneziano, ebreo, il militare fotografo incaricato di immortalare le immagini della conquista dell’Etiopia e che, per la sua religione, verrà a sua volta discriminato perché per le leggi razziali non può più far parte dell’esercito.
Le foto che Ettore Navarra scatta, sono il filo che lo lega a Hirut la cui immagine ha fissato tante volte, quando, da donna-soldato qual era diventata, era stata fatta prigioniera e che nonostante le violenze alle quali era stata sottoposta, aveva mantenuto la dignità che derivava dalla sua scelta. Ed è lui che, a differenza di Hirut, dopo tanti anni, si rivela incapace di separarsi dal quel passato. In occasione della presentazione de Il re ombra abbiamo posto alcune domande a Maaza Mengiste, che ringraziamo per la cortese disponibilità.
Il suo libro Il re ombra propone tanti e diversi piani di lettura e vorremmo chiederle di analizzarne alcuni. Il rapporto tra memoria e storia è diverso per gli oppressi e per coloro che si presentano come dominatori?
La storia è la narrazione del potere, creata da chi detiene il potere, che fa errori, fatti volutamente e deliberatamente. È un insieme di prospettive e di omissioni. La memoria è la narrazione della collettività e una serie di storie individuali che raccontano una nazione. Penso alla storia come un prisma con tantissime sfaccettature che riflettono la luce secondo il modo in cui vengono esposte facendo nascere nuove narrazioni che nascono da questi nuovi riflessi. Ed è così che ho voluto strutturare il mio libro, come un prisma per poter ricomprendere tutte le varie sfaccettature.
Il vento del cambiamento rinfresca il Senegal
Il colpo di coda dell’ancien régime senegalese – con il rinvio imposto dal presidente uscente Macky Sall delle elezioni presidenziali di febbraio a dicembre 2024 ed il loro ri-anticipo obtorto collo al 24 marzo scorso, dopo la sollevazione delle opposizioni e dell’opinione pubblica e l’intervento del Conseil Constitutionnel – da una parte ha mostrato la resistenza al cambiamento di una parte dell’establishment, quello legato a filo doppio con la Francia, ma dall’altra ha dato prova della vitalità della società civile e del corpo elettorale.
Ma anche della capacità di tenuta delle istituzioni democratiche: uno stress test mai vissuto prima dal Senegal, il Paese africano tradizionalmente più stabile e pacifico dell’area, dove tuttavia la stabilità perseguita dal vecchio presidente rischiava la torsione autocratica e illiberale di fronte al tentativo di manipolazione della Costituzione senegalese.
Ha vinto in modo netto la proposta politica di radicale cambiamento del Pastef, il partito di Ousmane Sonko, imprigionato ed escluso dalla competizione durante il crepuscolo della corte di Sall ma oggi a capo del nuovo governo, dopo l’elezione a presidente della Repubblica Bassirou Diomaye Faye, un ex funzionario dell’agenzia delle imposte di Dakar, 43 anni, al fianco di Sonko fin dalla creazione del movimento, di cui ha condiviso ogni passaggio.
Diomaye, come ama chiamarlo la sua gente, è un presidente di rottura col passato, è l’interprete, insieme a Sonko e al movimento ampio e plurale che accompagna questo progetto politico, di quello che alcuni commentatori occidentali hanno definito del panafricanismo di sinistra: un’etichetta appiccicata con molta superficialità e approssimazione ad un progetto che sfugge alle categorie della politica cui è abituata l’Europa. Certo, l’impronta progressista c’è ed è ben visibile ma si interfaccia, in un dialogo non privo di aspetti contraddittori, con una visione valoriale conservatrice, improntata alla tradizione e alla cultura anche religiosa del popolo.
Nei primi 100 giorni, il nuovo governo senegalese ha messo mano ad alcuni dei dossier sociali e politici più spinosi e carichi di aspettative per il popolo che l’ha condotto al potere: il pagamento dei debiti nei confronti degli agricoltori e una vera e propria rivoluzione nella distribuzione delle sementi per la produzione agraria con il coinvolgimento, per la prima volta, dell’esercito per arginare il fenomeno degli intermediari che si arricchivano alle spalle dei coltivatori, l’abbassamento dei prezzi dei beni di prima necessità (pane, olio, zucchero, riso ecc.), la sospensione di alcuni accordi sulla pesca (dal 15 luglio le navi che non potranno esibire una valida licenza in corso non saranno più autorizzate alla pesca, essendo in corso la verifica di tutte le licenze per individuare armatori stranieri che operano nascosti dietro licenze senegalesi), il blocco delle licenze di costruzione sul demanio marittimo, l’audit nella pubblica amministrazione per scoprire le sacche di corruzione e di inefficienza nascoste nelle pieghe della vecchia burocrazia, la nomina di un dicastero dedicato all’Ambiente che sta elaborando progetti ambiziosi.
Le nuove amazzoni in difesa dei nativi
«Basta averli visti una volta per esserne edificati, queste cime di ghiaccio, queste grotte abissali, queste foreste profonde, templi di alte e proficue rivelazioni». Così scriveva l’antropologo Claude Levi Strauss a proposito dei suoi primi contatti con nativi brasiliani tra il 1935 e il 1939. Erano Bororo, Caduveo, Nambikwara con pitture facciali come costellazioni, con capanne come gioielli vegetali incastonati nella foresta. “Proficue rivelazioni” anche per le centottanta persone che hanno gremito la Sala Palestrina dell’Ambasciata del Brasile a Piazza Navona, di fronte a una donna del popolo Guajajara dal volto sorridente, incorniciato dalle piume colorate del suo cocar. Sônia Bone de Souza Silva Santos Guajajara, è ministra di una istituzione che non esisteva, voluta e battezzata dal presidente Lula l’11 gennaio del 2023 come ministero dei Popoli indigeni, il primo al mondo, che vede per la prima volta una donna nativa dirigere un dicastero.
Nata nella terra indigena di Arariboia, nello Stato del Maranhão, attivista molto impegnata, dal 2013 coordinatrice del Apib, organismo che riunisce le principali organizzazioni indigene del Brasile, candidata alla vicepresidenza, deputata federale per lo Stato di San Paolo e ora ministra, Sônia Guajajara è la punta di diamante di un movimento ampio e articolato, cresciuto dall’unione di migliaia di donne appartenenti a oltre trecento popoli, consolidatosi politicamente a partire dalle proteste del 2004 e strutturatosi nel 2019 con la prima “marcia delle donne indigene” nella capitale Brasilia. Con le loro pitture corporee, copricapi e collane di piume, canti e danze, denunciarono a gran voce le devastazioni ambientali dei cercatori d’oro, incendi, omicidi e violenze in epoca Bolsonaro, sfilando così vicine ai palazzi del potere da riuscire poi ad entrarci, quando Lula vinse le elezioni.
Oggi le native che ricoprono ruoli di potere governativo sono cinque, un numero record – tra i 513 membri della Camera dei deputati. La più votata è stata Célia Xakriabà, che ha denunciato dettagliatamente la massiccia esportazione di prodotti brasiliani provenienti da territori indigeni, che comporta l’invasione dei villaggi, lavoro schiavo, violenze e gravi conflitti. Anche a capo della Funai, ente governativo di difesa dei popoli indigeni, per anni uno strumento ambiguo di potere e manipolazione, c’è ora una donna indigena, l’ex deputata Joenia Wapichana, la prima nativa a diventare avvocata in Brasile, autrice del libro Povos indígenas e a lei dos “brancos”: o direito à diferença (Popoli indigeni e legge dei bianchi: il diritto alla differenza). Molte sono le protagoniste di spicco di questo sfaccettato movimento che lancia appelli efficaci come “riforestiamo il pianeta, riforestiamo le menti” o come “la terra è il nostro corpo e il nostro spirito”, indicando un modo di fare politica universale che include la crescita interiore e la consapevolezza globale.
Essere donna in Brasile è un reato
In Brasile lo stupro è una delle pochissime situazioni che consentono l’interruzione legale della gravidanza. Le altre sono il rischio di morte della gestante e l’anencefalia fetale. In questi casi, non esiste un limite di età gestazionale per la procedura, che deve essere offerta dal Sistema sanitario nazionale (Sus) in servizi specializzati e accreditati.
Ora però anche le donne vittime di violenza che decidono di abortire potrebbero rischiare il carcere. Una misura che, come vedremo, colpisce anche le minori di 14 anni.
È quanto prevede un progetto di legge 1904/2024 presentato alla Camera dei deputati il 17 maggio dal pastore neopentecostale Sóstenes Cavalcanti – appartenente all’estrema destra bolsonarista – e sottoscritto da 32 deputati della stessa area politica. La norma di Cavalcanti, soprannominata da giuristi e associazioni femministe “Lei do estupro e do estuprador”, è sostenuta dai vescovi cattolici e dai pastori evangelici presenti in Parlamento, e prevede una pena da 6 a 20 anni per le donne che abortiscono dopo la ventiduesima settimana, anche se vittime di stupro. Si tratta in pratica del doppio della pena prevista per uno stupratore. Le vittime saranno costrette a partorire anche nel caso fossero delle bambine, un dato aberrante che mette in luce un netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel Codice penale del 1940 che non stabiliva alcun limite legale all’aborto in casi di stupro.
Il progetto di legge contro l’aborto tanto caro ai vescovi cattolici brasiliani prevede per le minori che abortiscono dopo la ventiduesima settimana, anche in caso di violenza sessuale, a seconda della “gravità” dei casi: l’ammonimento, l’obbligo di riparare il danno, la prestazione di servizi, la semilibertà, la libertà vigilata, o persino l’internamento per tre anni, presso un “istituto educativo”. In quest’ultimo caso, il rilascio avviene obbligatoriamente non prima del compimento del ventunesimo anno di età. La cosa ulteriormente sconcertante è che, oltre al dolore di aver subito una violenza sessuale, le vittime saranno separate dai loro familiari, i quali dovranno affrontare un processo penale per averle accompagnate ad abortire.
In fretta e furia, il 12 giugno scorso, i parlamentari hanno stabilito il “regime d’urgenza” per votare la legge, forse per il timore avvertito da parte del mondo religioso cattolico ed evangelico, che prevalessero nell’opinione pubblica i fondamenti scientifici e giuridici, favorevoli alla depenalizzazione dell’aborto nelle prime dodici settimane di gestazione (e a prescindere dalle circostanze), esposti da Rosa Weberl, giudice della Corte Suprema. Nel settembre del 2023 Weber ha messo nero su bianco che prima della nascita, non esiste il diritto alla vita, aggiungendo che la difesa della “vita” sin dal concepimento viola l’articolo 5 della Carta Magna, in quanto attribuisce a embrione e feto la titolarità di diritti fondamentali, paragonandoli a quelli di un essere umano: la donna.
Caro Starmer, non è vero che si vince al centro
Volendo applicare alle elezioni britanniche il famoso adagio della luna e del dito, potremmo dire che fermarsi a contare solo il numero di seggi vinti dal Labour sarebbe guardare il dito, mentre ci sono una serie di trend “nascosti” nei risultati che hanno una portata molto grande, a parere di scrive, chiaramente. Da tutte le analisi dei flussi elettorali, infatti, si evince che il Paese ha votato compattamente per impedire ai Tories di tornare al governo dopo quattordici anni al potere che hanno portato ad una situazione economica e sociale disastrosa. Il mandato politico di Starmer, a partire dal misero 33% ottenuto nel voto popolare, associato alla bassa affluenza (meno 6% rispetto al 2019) appare però estremamente debole, in netto contrasto con la grande maggioranza parlamentare che gli permetterà di operare incontrastato per i prossimi cinque (o quattro) anni.
E proprio questo risultato elettorale ambivalente che ci permette di fare alcuni ragionamenti sull’assioma – a mio modesto parere fallace – per il quale Starmer ha dimostrato che si vince solo “andando al centro”.
Quello che è successo nelle urne ci dimostra al contrario come la necessità di una proposta elettorale più progressista era talmente forte che, nonostante il Labour si trovasse ad affrontare una delle battaglie elettorali più facili della sua storia, il risultato è stato ben lontano dai risultati straordinari del primo Blair, per fare un esempio senza scomodare giganti come Attlee o Wilson, questo proprio perché il Labour non è riuscito a conquistare un forte entusiasmo popolare attorno alla propria proposta politica.
Questa tesi viene anche dimostrata dal risultato straordinario dei LibDem, che hanno fatto una campagna elettorale molto progressista distanziandosi decisamente dalle loro posizioni più moderate del passato e – soprattutto – la grande affermazione dei Verdi, che per la prima volta portano quattro parlamentari alla House of Commons in un sistema elettorale studiato appositamente per espungere piccoli partiti come il loro.
C’è poi il risultato eccezionale di ben cinque candidati indipendenti, tra cui l’ex leader laburista Jeremy Corbyn, che hanno sfidato e sconfitto il Labour su posizioni di sinistra e in particolare mettendo al centro del loro messaggio la pace e un cambiamento di posizione nei confronti del conflitto israelo-palestinese.
In molti collegi “rossi” si è infatti aperta una “questione musulmana”, con l’enorme comunità britannica di cittadini originari delle ex colonie britanniche di religione musulmana che si stanno allontanando dal Labour mettendo in crisi le maggioranze di molti collegi laburisti.
Il revisionismo anni 90, che regalo per Meloni & C.
«Non c’è spazio, in Fratelli d’Italia, per posizioni neofasciste, razziste o antisemite, come non c’è spazio per i nostalgici del fascismo e dei totalitarismi del ’900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore. I partiti di destra dai quali molti di noi provengono hanno fatto i conti con il passato e con il ventennio fascista già diversi decenni fa …» (Giorgia Meloni in una lettera inviata ai dirigenti di Fratelli d’Italia il 2 luglio, in seguito all’inchiesta di Fanpage “Gioventù meloniana”).
Le parole in corsivo, ovviamente, non compaiono nel testo della presidente del Consiglio, ma le ho volute inserire per restituire l’impatto che avrebbero creato nel lettore qualora lo fossero state. D’altro canto, chiedere a FdI di rinnegare il fascismo quale modello storico di regime antidemocratico e autoritario, suonerebbe come pretendere che un partito di ispirazione liberal-democratica ripudiasse gli ideali della rivoluzione francese. È la loro base ideologica, il loro orizzonte identitario; ci possiamo solo acconciare ad osservare le funamboliche contorsioni cui sono costretti, per evitare che i loro riferimenti storico-politici siano d’intralcio al mantenimento di posizioni di potere e di consenso. Perché è da quelle posizioni che possono non solo “riscrivere la storia”, quanto soprattutto restituircela “sub specie modernitatis”, rendendo attuale e reale una prospettiva di tipo illiberale e antidemocratico che, se non può definirsi fascista in senso proprio, è tuttavia da quel paradigma che trae ispirazione e nutrimento. Lo smantellamento della Costituzione del ’48 con la legge sull’autonomia differenziata e la proposta del premierato; la morsa sull’informazione con l’occupazione manu militari del servizio pubblico e la stretta sulle intercettazioni; i decreti sicurezza appena approvati e le politiche di contrasto all’immigrazione; l’attacco alla legge sull’aborto, con l’ingresso dei volontari “pro-vita” nei consultori pubblici: tutti questi provvedimenti disegnano un quadro i cui contorni sono ben definiti, e rinviano ad un regime ibrido, una sorta di «democratura», che pare essere il progetto politico cui guarda, in verità, tutta l’estrema destra in Occidente da una decina d’anni a questa parte, e sul quale i neofascisti registrano più di una convergenza con l’area neoliberal (come è stato messo in evidenza, il 3 luglio su Left, da Andrea Ventura). Però, mentre il disegno delle destre reazionarie e sovraniste negli Usa e in Europa viene costruito intorno ad una prospettiva che, pur richiamandosi al fascismo storico, è in realtà totalmente modellata sul presente (come risposta regressiva alla globalizzazione, facendo leva sulle sue contraddizioni in termini socio-economici), la destra al governo in Italia si distingue dai partner europei ed americani perché, diversamente da loro, si muove su uno sfondo in cui anche il passato conta: ha una storia da vendicare e rivendicare, e una lettura di essa che vorrebbe diventasse memoria pubblica, cultura egemone, storia condivisa. Per il momento la prospettiva di “riscrivere da capo” la storia repubblicana, riabilitando il Ventennio mussoliniano e soprattutto i suoi epigoni missini, non pare avere molte possibilità di realizzarsi, nonostante la moda revisionistica degli ultimi trent’anni.
Edoardo Albinati: «Il mondo chiuso chiamato carcere»
«Per avere un pensiero critico bisognerebbe prima conoscere, sapere, vedere per capire». A parlare è uno tra i più attivi intellettuali engagés italiani: Edoardo Albinati. Scrittore – premio Strega con La scuola cattolica (Rizzoli, 2016) -, sceneggiatore – Il racconto dei racconti insieme a Matteo Garrone o Rapito con Marco Bellocchio – e insegnante per circa trent’anni nel carcere romano di Rebibbia. La sua lunga esperienza tra i detenuti attraversa anche i suoi libri, come Maggio selvaggio (Rizzoli) per esempio, ma Albinati esce anche fuori da quelle mura, alla ricerca della verità indagando il nostro tempo come atto di responsabilità e impegno civile. Come il carcere, così esplora infatti anche la situazione altrettanto complessa delle persone migranti con la loro uguale condizione di esclusi, la cui libertà è soppressa, i diritti violati. E lo fa da reporter, percorrendo parte della rotta balcanica che porta le persone in Europa oppure andando in Niger, crocevia non solo di profughi, ma anche di armi, di capitali occidentali e cinesi, di militari, fino all’uranio.
Edoardo Albinati, scrittori, artisti e associazioni si sono occupati di promuovere l’arte all’interno delle carceri attraverso progetti, laboratori, incontri. In base alla sua esperienza, l’arte quale contributo può dare ai detenuti?
Bisogna partire dal fatto un po’ desolante che in carcere attività di qualsiasi genere che permettano di rendere un po’ più permeabile la detenzione sono molto poche. Il vero problema della realtà carceraria è che è un mondo chiuso, extraterritoriale, dove invece dovrebbero essere favoriti gli scambi dal dentro al fuori. Non esiste nulla di istituzionale che sia rieducazione o risocializzazione e queste sono comunque sempre affidate a singole persone o associazioni. Nel carcere di Rebibbia, che è quello che ho conosciuto meglio avendoci insegnato molto a lungo, il teatro, per esempio, era molto importante ed era affidato al regista Fabio Cavalli di cui ricordo una favolosa rappresentazione de La tempesta di Shakespeare. Uno spettacolo con delle intuizioni notevoli degli attori, alcuni dei quali sono diventati veri professionisti una volta usciti dal carcere. Nella mia modesta posizione di insegnante carcerario, ho pensato più alla grammatica, alla lingua, alla letteratura. Ecco, non posso dire che quello che facevo lì fosse un insegnamento creativo. Era scuola, una delle poche cose che serve quantomeno a riscattare il tempo trascorso lì dentro che altrimenti è tempo morto, perduto.
Ora l’amnistia, segno di civiltà
Nelle carceri del nostro Paese esiste la pena di morte: quella inflitta dallo Stato a chi è privato della libertà. Quella inflitta a ragazzi spesso malati, che convivono con gravi dipendenze e disagi psichiatrici, in condizioni sanitarie precarie. Sono soprattutto loro, i giovani, a mettere fine alla loro esistenza all’interno di strutture dove la dignità e il diritto non esistono. Dove regna il sovraffollamento, l’abbandono, dove i diritti della persona vengono calpestati. Nonostante la strage di detenuti continui, nonostante i dati inquietanti sul sovraffollamento, le difficoltà del personale penitenziario, si va avanti nella totale indifferenza delle istituzioni.
Aspettavamo tutti con urgenza il decreto del ministro Nordio approvato in questi giorni. Avrebbe dovuto dare soluzioni, mandare un segno di civiltà e dimostrare responsabilità. Invece è una delusione, una manovra inefficace che non affronta le radici del problema delle carceri italiane. Mi domando se, chi l’ha scritto e sostenuto, abbia mai messo piede in un istituto detentivo. È un’offesa per garanti, operatori del sistema penitenziario e associazioni per i diritti umani, oltre che per i detenuti, ovviamente, ai quali uno Stato inefficiente, ingiusto, inconsapevole, si permette di chiedere loro buona condotta non rispettando esso stesso i principi fondamentali del diritto.
Le cifre parlano di 61.480 detenuti per 51.234 posti regolamentari, che in realtà sono 47mila. Questo sovraffollamento «criminogeno» come sottolineato dal presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Santalucia, riprendendo un concetto usato da sempre da Marco Pannella, non viene minimamente risolto.
Il decreto Nordio anziché portare aria di cambiamento complica le cose, per i detenuti che vedranno ritardate le scarcerazioni, per i magistrati di sorveglianza – appena 230 in tutta Italia – a cui è stato imposto un metodo di lavoro che risulterà in sostanza impraticabile. L’onere di esaminare le richieste di libertà anticipata rimane come prima, infatti, per questi magistrati, i cui carichi di lavoro già esorbitanti rischiano di aumentare ulteriormente. È la burocrazia in sostanza a farla da padrona, rimanendo una volta in più un ostacolo insormontabile; non ci sarà nessuna semplificazione. In questo contesto, non si è peraltro pensato minimamente ad aumentare l’organico della magistratura di sorveglianza, così come quella degli psichiatri, degli psicologi e degli educatori che servirebbero a fiumi.
Sorrido amaramente quando sento parlare della tanta proclamata “umanizzazione” del sistema penitenziario sventolata dal ministro Nordio. Basterebbe facesse funzionare le cose con razionalità e buon senso. Ma, accettando il buon proposito, mi domando di quale umanizzazione parli, non riuscendo peraltro a determinare un cambiamento in meglio delle esistenze dei detenuti, mentre ciò che serve al “pianeta carcere” non è solo e tanto un’umanizzazione – fin troppo umani , se vogliamo, nella loro organizzazione tanto fallimentare i nostri istituti – quanto il rispetto dei diritti e del diritto, a iniziare da quello costituzionale.
Il futuro delle città a misura di anziani
Che siano percorse da fenomeni di gentrificazione (quel processo di trasformazione, fisica e socioculturale dei quartieri che porta a un graduale cambio della cittadinanza che può permettersi di viverci) o da fenomeni di degrado (inquinamento, perdita dei servizi essenziali, sovraffollamento, effetti dei mutamenti climatici) le nostre città diventano sempre più inospitali, soprattutto per i soggetti più fragili. Parliamo degli anziani e delle anziane che a dispetto dei dati demografici (l’indice di vecchiaia continua a crescere con un aumento di 5,5 punti percentuali, raggiungendo, al primo gennaio 2023, quota 193,1 anziani ogni cento giovani, confermando la crescita costante dell’indice, in atto oramai da un ventennio – dati Istat) continuano a perdere “diritti di cittadinanza” ovvero la possibilità di vivere e sopravvivere nei nostri centri urbani. Potremmo dimostrare le difficoltà che vivono le persone anziane in città partendo dalla mancanza sempre più drammatica di servizi di prossimità come un semplice negozio di alimentari o in maniera ancora più cruda raccontare l’assenza di presidi sanitari di quartiere che possano assisterli. Ma la nostra vera sfida è dimostrare che una città che nega i diritti alle persone anziane è una città più inospitale per tutti e tutte. Una città che non si cura degli anziani è una città che destina i propri abitanti all’infelicità. La città che si prende cura della popolazione più anziana invece è una città che organizza gli spazi pubblici, gli usi dei luoghi e la mobilità collettiva nel segno della prossimità e delle relazioni. Per tutte e tutti, anche considerando che spesso mano nella mano, a fianco degli anziani, camminano i bambini e le bambine che possono contare solo sul welfare dei nonni che se ne prendono cura, certo per affetto, ma anche per sopperire a quell’assenza di spazi e servizi di cui l’infanzia di questo Paese avrebbe urgente bisogno. Insomma, per dirla “da ambientalista” gli anziani sono dei bioindicatori di qualità della vita e soprattutto sperimentano in maniera diretta e drammatica alcuni degli aspetti più duri delle crisi della modernità. Penso alla crisi climatica con il suo portato di effetti devastanti in termini di danni e vittime. Sono due le “parole climatiche” più ripetute negli ultimi anni: alluvioni e temperature record. Il fenomeno delle ondate di calore è comune a tutte le città, con una tendenza di crescita che appare già in atto e con incrementi significativi ma diversificati nelle diverse realtà: 50 giorni in più di caldo intenso l’anno negli ultimi decenni del secolo per Napoli rispetto a inizio secolo. Ma è un fenomeno che interessa in maniera significativa anche Milano (+ 30 giorni), Torino (+ 29) e Roma (+28) (fonte Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Cmcc). I problemi legati agli allagamenti da piogge intense sono esacerbati dall’ambiente urbano a causa della densità dell’ambiente costruito, dell’impermeabilizzazione del suolo e di specifiche caratteristiche delle singole città. A farne le spese la popolazione più anziana soprattutto per quanto riguarda le ondate di calore.