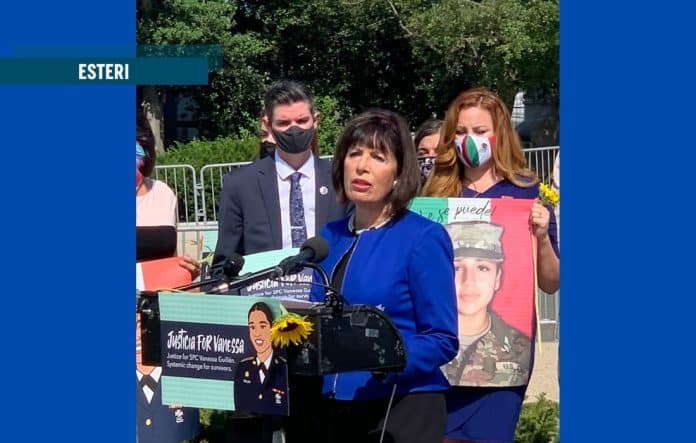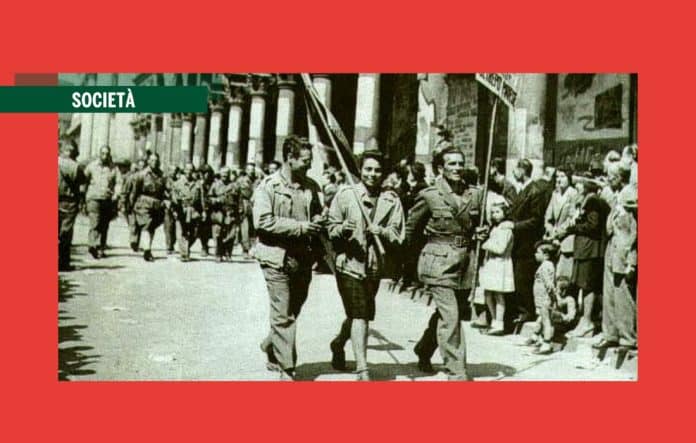Quasi 500mila studenti e studentesse si stanno preparando a sostenere la prova di maturità. Per ognuno di loro, passato questo traguardo, giungerà una consapevolezza: la vera corsa deve ancora iniziare.
Superate le scuole superiori, con tutte le problematiche legate alla crescita e alla limitata autonomia della minore età, arriva il primo vero carico di responsabilità verso il proprio futuro: se a tredici anni si era troppo piccoli per scegliere in completa autonomia un percorso di studi, senza lasciarsi influenzare dai consigli di insegnanti e genitori o da fattori squisitamente logistici (la lontananza della scuola, la presenza di altri amici in questo o quell’istituto), con la scelta del percorso post liceale per la prima volta si è davvero soli, chiamati a scelte capaci di influenzare molto di più che un ciclo di studi.
Quand’è che ci si chiede “cosa voglio fare nella vita”? E chi è che a meno di vent’anni è in grado di rispondere? Non si può negare che sulla risposta influisca il proprio punto d’osservazione sul futuro, il contesto sociale, culturale ed economico.
Il figlio del medico per esempio avrà maggiori possibilità di scegliere quel tipo di percorso, così come non è improbabile che uno studente pressato da esigenze familiari (dettate da indigenza o, al contrario, dalla necessità di portare avanti un’attività remunerativa già avviata) possa ritenere sufficiente gli studi già svolti.
Non mancano valutazioni inquinate dal comune sentire. “Cosa ci fai con quella laurea?” è una domanda che chiunque abbia scelto di proseguire gli studi in materie che non rientrano fra le cosiddette “Scienze dure”, si è sentito fare almeno una volta.
Dalle statistiche emerge il peso dei fattori familiari. L’Istituto nazionale analisi delle politiche pubbliche-Inapp ha calcolato che un genitore laureato triplica le possibilità del figlio di conseguire lo stesso titolo rispetto a studenti con genitori privi di laurea o diploma.
Oltre al contesto familiare incide quello sociale inteso in senso più ampio. Secondo un’analisi di Openpolis sulla dispersione scolastica, ci sono grandi differenze tra Nord e Sud, centro e periferie, grandi città e aree interne: nel 2022 le Regioni in cui la scuola era abbandonata con maggiore frequenza sono state Campania (19,8%), Sardegna (18,7%), Calabria (18%) e Sicilia (16%). Si tratta di numeri coerenti con quelli riportati nel 2019 dallo stesso istituto, quando i maturandi che decisero di proseguire gli studi erano stati solo il 47,5% del totale nel Sud e nelle isole, in ribasso rispetto alla già non elevata media nazionale (51,4%).
Tuttavia le ultime edizioni del Rapporto annuale delle forze di lavoro elaborate dall’Istat dicono che anche al Nord, dove le opportunità professionali per giovani non laureati sono maggiori, questi ultimi hanno più probabilità di essere successivamente esclusi dal mondo del lavoro e minori possibilità di essere ricollocati.
Un quadro aggravato dai cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training), giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono in formazione e che scegliendo di non scegliere compromettono almeno in parte il loro futuro, ma anche quello del sistema Paese. In Italia Oltre un ragazzo su cinque si trova in questa condizione (fonte Openpolis), con punte del 35% in nove provincie, tutte del Sud, a conferma dell’influenza di condizioni sociali sulla programmazione e l’immaginazione del proprio futuro.
Non tutti i fattori condizionanti sono però di tipo economico: molti intellettuali e docenti ritengono che complichi la scelta di maturandi anche la scarsa predisposizione della scuola a fornire adeguati strumenti di valutazione.
Quella che viene meno in molti casi è la capacità di un’indagine reale sul tipo di persona che si vuole diventare, al di là degli aspetti legati a convenienze economiche e opportunità professionali, che dovrebbe costituire un contraltare importante nella scelta del percorso post maturità. Si tratterebbe tra l’altro di un elemento su cui, ove gli fosse data la dovuta importanza, si fonderebbero gran parte delle possibilità di riuscita di un percorso accademico o professionale.
Ritorna dunque prepotente la necessità di una scuola pubblica che non si limiti a verificare l’apprendimento di nozioni uguali per tutti ma favorisca la conoscenza delle proprie inclinazioni, inserita in una società in grado di fornire a chiunque (indipendentemente dalle condizioni di partenza) la possibilità di valorizzarle: sarebbe un elemento imprescindibile perché la risposta alla prima vera domanda che ci si fa sul proprio futuro, potesse avere qualche possibilità di essere quella giusta.
Nei mesi scorsi Alma Diploma ha presentato a tal proposito una rilevazione su quasi 29mila neodiplomati da cui emerge che, sul 78,5% di quanti hanno svolto attività post-diploma organizzate dalla scuola, solo il 47,9% ha reputato tale attività rilevante per la scelta finale. Principale fattore incidente sembra essere ancora la famiglia, specie se i genitori sono laureati, confermando la necessità di un orientamento efficace laddove il contesto familiare non riuscisse a svolgere questa funzione.
Per molti il modello scolastico basato su lezioni frontali e apprendimento mnemonico e nozionistico, risponderebbe all’esigenza pubblica di produrre risultati oggettivamente misurabili, ma non sempre a quella di formare persone consapevoli delle proprie capacità e aspirazioni, dunque facilitate nelle scelte post diploma.
Studenti, docenti, politici e intellettuali si sono spesso confrontati su questo aspetto, su cui nessuna riforma scolastica ha inciso davvero. Già Umberto Eco aveva stigmatizzato il nozionismo (“colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua vita in cui gli serve”), mentre in anni più recenti lo scrittore (e docente) Andrea Bajani auspicava una scuola capace di far “uscire i ragazzi con la capacità di immaginare un mondo diverso da quello che hanno consegnato loro, e non solo (quella di essere, ndr) bravi ad inserirsi dentro caselle già disegnate” (La scuola non serve a niente, Laterza, 2014).
A rincarare la dose è stato anche Nuccio Ordine, tra i massimi studiosi del Rinascimento: «Non diciamo agli studenti ‘devi studiare per acquisire una conoscenza che consenta di diventare donne e uomini liberi’ ma ‘devi scegliere la scuola sulla base del lavoro che devi fare e di quanto guadagnerai’… Questo significa promuovere una educazione mercantilistica, contraria a qualsiasi idea di educazione che deve formare cittadini colti».
Si tratta di un allarme reale o delle preoccupazioni di un umanista incapace di cogliere le esigenze del mondo del lavoro rispetto alle ambizioni del sistema educativo? Dobbiamo chiedere ai giovani di seguire le loro inclinazioni o le indicazioni del mercato?
Comunque si voglia rispondere, resta un dubbio: sicuri che siano gli adulti di oggi a poter indicare ai maturandi la via migliore per diventare gli adulti di domani?
*
L’autore: Fabrizio Moscato, giornalista, è direttore del festival “Liberi sulla carta”