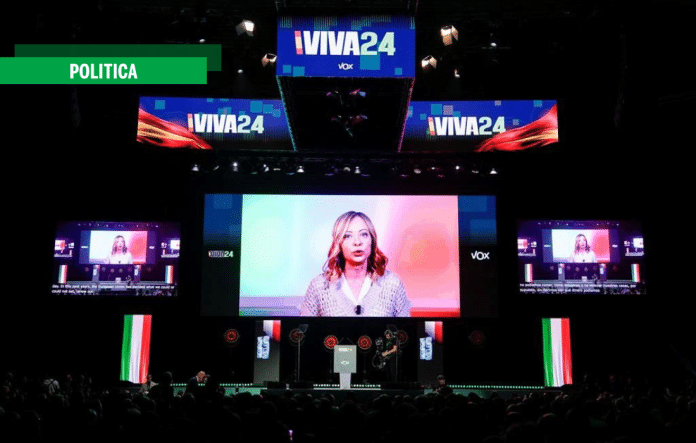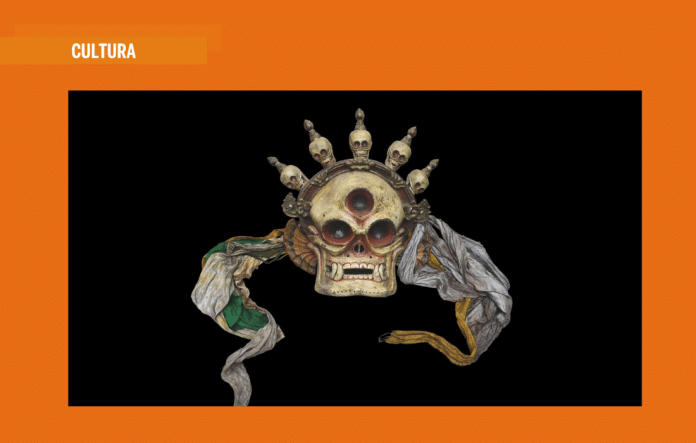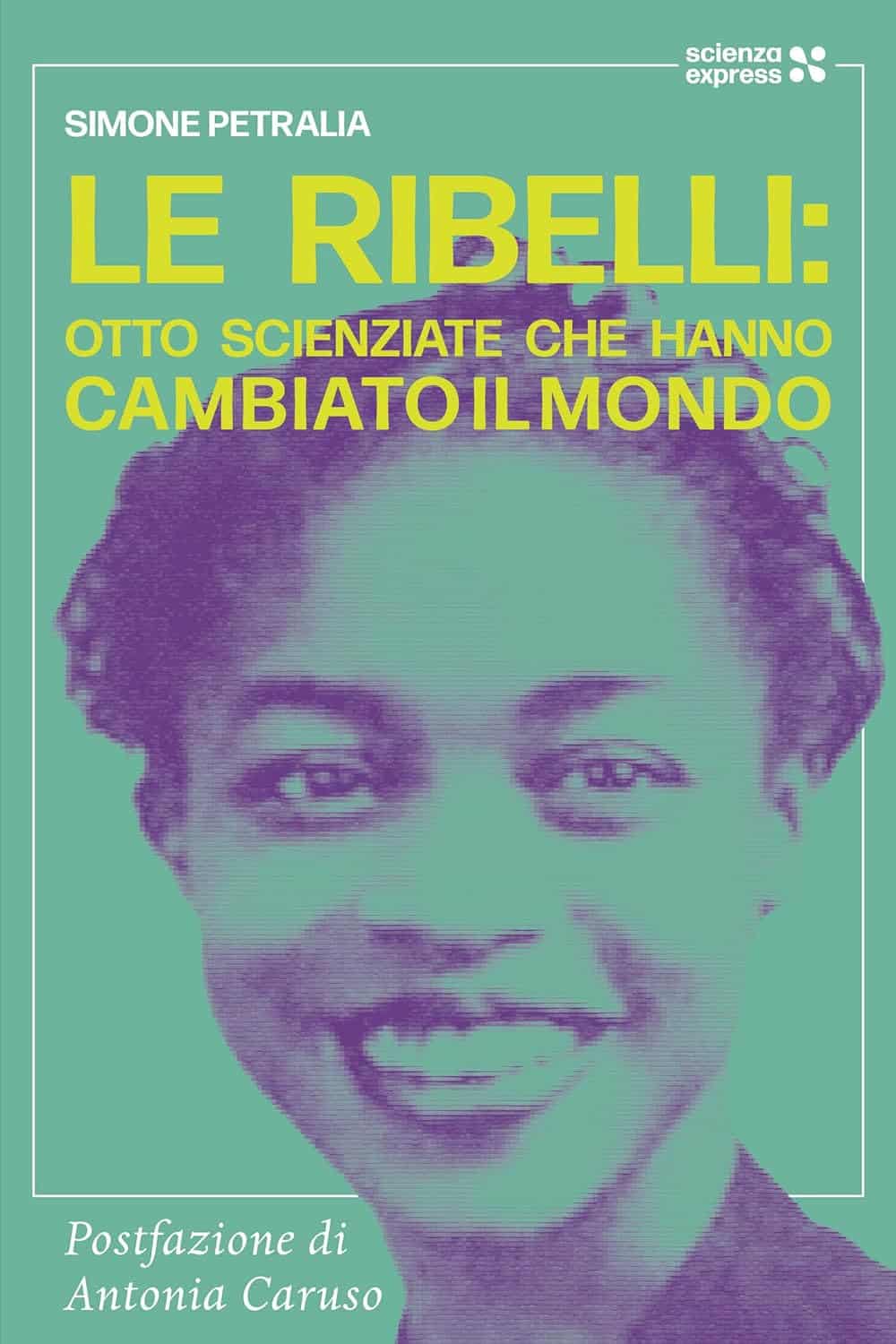Per capire il funzionamento della Tv pubblica, ai tempi di TeleMeloni, non dobbiamo partire dalla censura che si è abbattuta contro lo scrittore Antonio Scurati alla vigilia del 25 aprile, festa nazionale che celebra la Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.
Certo, l’episodio ha fatto il giro del mondo. Si è conquistato le prima pagine dei quotidiani.
Scurati, autore di una tetralogia dedicata al fascismo e a Mussolini, vincitore nel 2019 del più importante premio letterario italiano, il Premio Strega, aveva firmato un contratto per recitare un monologo sul 25 aprile durante il programma del canale pubblico Rai3, Che sarà.
Il giorno precedente alla messa in onda, la conduttrice Serena Bortone viene a sapere che il contratto è stato annullato per decisione aziendale. In una mail dei vertici Rai, emersa successivamente, si scopre che la scelta si deve a “motivi editoriali”.
Malgrado i tentativi di giustificazione dell’azienda pubblica, che cerca di ricondurre il mancato intervento a ragioni di carattere economico, a un mancato accordo sul cachet di 1.800 € richiesto da Scurati, è chiaro che a dare fastidio è stato il contenuto di quel monologo.
Scurati parte dall’omicidio Matteotti, il parlamentare socialista ammazzato il 10 giugno 2024 da sicari al soldo di Mussolini, per proseguire con la definizione del fascismo come di un “fenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista”. Chiedendosi, a quel punto, se Meloni & Co. Avranno il coraggio di riconoscerlo una buona volta. “Tutto, purtroppo, lascia pensare che non sarà così. […] Finché quella parola – antifascismo – non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana” (qui il testo del monologo).
Troppo, evidentemente, per l’ultradestra di governo che continua a tener fede al motto del partito neofascista Movimento sociale italiano – nella cui giovanile Meloni si è formata: «Non rinnegare, non restaurare». Soprattutto, viene da dire, “non rinnegare”.
Il miglior modo di capire, infatti, non è inseguire ciò che fa rumore, ma provare ad ascoltare ciò che passa in silenzio.
Perché, come scriveva Kapuściński, «il silenzio è un segnale di disgrazia, spesso di un crimine. … Tiranni e occupanti hanno bisogno del silenzio per nascondere il loro operato. Basta osservare il modo in cui i vari colonialismi hanno mantenuto il silenzio, con quanta discrezione lavorasse la Santa Inquisizione … . Dagli stati dove le prigioni sono piene emana un gran silenzio».
Partiamo dunque da ciò che raramente si racconta e che però succede in Rai da un anno e mezzo a questa parte, da quando cioè Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni del settembre 2022 e ha nominato uomini di fiducia nei posti chiave dell’azienda pubblica.
In Italia, infatti, dal 2015 la Rai è passata dal controllo del Parlamento a quello dell’esecutivo. Si è dunque legato un pezzo del potere mediatico al potere governativo. Per opera di chi? Non della cattivissima ultradestra, ma della “presentabile” socialdemocrazia in salsa italiana, di quel Partito Democratico, erede del Pci, all’epoca capitanato dall’enfant prodige Matteo Renzi (oggi a capo di un piccolo partito di centro).
Sono utili le parole di due dipendenti Rai, pronunciate in occasione dello sciopero dell’Usigrai, sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, del 6 maggio scorso.
Una protesta che metteva insieme ragioni di carattere sindacale – stabilizzazione dei precari, concorsi per nuove assunzioni, ecc. – e la difesa della libertà di espressione e di informazione.
Enrica Agostini, del Comitato di redazione di Rai News 24, ha dichiarato di non aver “mai subito delle pressioni e delle censure come quelle che sto subendo in questo periodo”.
Proseguendo: “Non abbiamo dato la notizia di Lollobrigida in treno (quando il ministro dell’Agricoltura, cognato di Giorgia Meloni, fece fermare un treno a una stazione non prevista perché rischiava di arrivare in ritardo a un appuntamento istituzionale, abusando così del suo ruolo) se non dopo molte ore, dopo che il CdR di cui faccio parte aveva scritto una nota molto dura”.
Terminando, asserisce che capita spesso che i vertici impongano titoloni per esaltare Meloni, come nel caso dell’ampio spazio dato all’articolo del britannico Telegraph del 3 aprile (“L’Italia di Meloni sta facendo ciò che la disperata Gran Bretanga può solo sognare”).
Uguale risalto dato, certo casualmente, ben 3 giorni dopo il titolo del Telegraph, anche dai quotidiani dell’ultradestra di proprietà del parlamentare leghista e grande proprietario di cliniche private, Angelucci.
Non siamo ancora ai livelli della “velina” che il 4 luglio 1938 il Minculpop, il ministero della Cultura Popolare, il Ministero della Propaganda di Mussolini, inviava alla stampa, invitandola a “notare come il Duce non fosse affatto stanco dopo quattro ore di trebbiatura”, ma pian piano rischiamo di avvicinarci.
Federica Bambogioni, giornalista del Tg2 di Rai2, ha evidenziato invece il tentativo di un superiore di far eliminare o minimizzare in un servizio Tv il dato relativo al calo degli italiani in partenza per le vacanze a causa di inflazione e ristrettezze economiche.
Un po’ come quando il 12 novembre 1941, con la guerra mondiale che già mordeva, il Minculpop intimava la stampa di “non occuparsi in alcun modo delle ‘code’ (per i generi alimentari)”.
Le testimonianze di Agostini e Bambogioni potrebbero essere derubricate a episodi minori. Il problema, però, sta nella ripetitività, nella sistematicità di tali comportamenti. Non più singoli episodi, ma anelli di catene che danno forma a un “sistema”. A TeleMeloni, per l’appunto.
E per ogni tentativo censorio che trova opposizione e resistenza, ce ne sono sicuramente molti di più che vanno a segno. A maggior ragione quando indirizzati a giornalisti precari, quindi con le spalle meno coperte. Non a caso, Macheda, segretario del sindacato dei giornalisti Usigrai, durante la giornata di sciopero sottolineava l’importanza della rivendicazione della “stabilizzazione … perché anche in una giornata come questa devono andare in onda, perché il rischio è quello di perdere la paga giornaliera …, ma in un clima come questo anche di vedersi al prossimo giro detto ‘guarda, non abbiamo bisogno di te’”.
Un altro tassello su cui si sta cercando di costruire l’egemonia dell’ultradestra nella Tv pubblica è la distruzione della forza sindacale dei giornalisti Rai. Tradizionalmente c’è stata un’unica organizzazione a rappresentarli, Usigrai (che può contare circa 1.600 iscritti sui poco più di 2mila giornalisti Rai). Da dicembre 2023, però, le cose sono cambiate ed è entrato in scena un nuovo sindacato: UniRai.
Uno strano sindacato, a dire il vero. Nato su input di Giampaolo Rossi, direttore generale Rai, cioè di uno dei nuovi vertici aziendali di nomina governativa. Uomo di fiducia che per Meloni cura da sempre gli affari interni alla Tv pubblica. I due sono legati dalla militanza giovanile nel post-fascista Msi, quello della fiamma di Mussolini da tenere viva. Sezione Colle Oppio, per l’esattezza.
Uno strano sindacato, se è vero che dei 350 iscritti che dichiara, quasi la totalità sarebbero quadri, dirigenti, capistruttura.
Ancora, uno strano sindacato ad ascoltare le dichiarazioni di Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana ed ex segretario Usigrai: “Non ho memoria di una organizzazione, che si dichiara sindacato, che inviti i propri iscritti a rinunciare al giorno di riposo, a cambiare i turni di lavoro per mettersi a disposizione di direttori e dirigenti, tentando così di depotenziare lo sciopero proclamato da una sigla sindacale”.
E, in fondo, è la stessa UniRai a rivendicare la messa in onda di Tg1 e Tg2, sebbene in edizione ridotta e rimaneggiata, grazie alla propria azione di “crumiraggio”: “Oggi è caduto un muro. È la fine del monopolio …. Oggi è una giornata storica per la Rai. Chi pretendeva di imporre la sua visione alla totalità dei giornalisti Rai è stato sonoramente sconfitto”.
A lavorare contro lo sciopero, però, non c’è stato solo il boicottaggio interno dei crumiri. Si aggiunge lo scetticismo generato in tanti, all’esterno della Rai, verso un sindacato e un corpo lavoratori che troppo spesso in passato sono rimasti fermi e silenti quando pure si registravano pressioni e censure.
A marzo 2022 a finire vittima della censura del Tg1 fu addirittura Papa Francesco per il suo discorso contro le spese militari. E, all’epoca, non c’erano certo al governo i nipotini del Duce, ma sua eccellenza Draghi.
Un presidente del Consiglio che, a proposito di “inchini” dei giornalisti, non era certamente secondo a Giorgia Meloni. Basti ricordare gli applausi preventivi di tanti giornalisti il 21 dicembre 2021, all’ingresso di Draghi nella sala stampa dove avrebbe dovuto tenere la conferenza di fine anno. Non certo il comportamento che ci si aspetterebbe da “cani da guardia del potere”.
Le critiche a TeleMeloni, tra l’altro, aprono il rischio di scenari tutt’altro che democratici. Per contrastare infatti la stretta dell’esecutivo sulla Tv pubblica, stanno tornando con forza sulla scena politica le posizioni di quanti da tempo chiedono “fuori la politica dalla Rai” o, più esplicitamente, la privatizzazione della Rai.
Di fatto questo passaggio segnerebbe la consegna del servizio pubblico nelle mani di presunte entità indipendenti – che poi indipendenti non sono mai, rispondendo a poteri meno pubblici di quelli politici – o di nuovi privati, ancor più svincolati da ogni possibile forma di controllo popolare e democratico.
Oltre a porre nuovamente la Rai sotto controllo del Parlamento, togliendola dalle mani del governo, ciò che occorrerebbe è una riflessione sulla censura e sull’esclusione quotidiana che soffrono ampi settori della nostra società, a partire dalle classi lavoratrici e popolari. Un’enorme maggioranza che non ha capitali per costruire media di respiro nazionale e che sempre meno si vede rappresentata dalla Tv pubblica.
Sarà forse giunto il momento di pensare a nuove strade? Qualche tempo fa, in Argentina, fu avanzata una proposta che prevedeva la tripartizione del “campo mediatico”: un terzo al pubblico, un terzo ai privati, un terzo a media popolari, finanziati anche dallo Stato. L’obiettivo era infrangere il “latifondo mediatico” che consegna il potere di Tv e stampa nelle mani di pochi operatori che, uniti a grandi gruppi industriali e finanziari e ai principali gruppi politici, costituisce la trama di potere che soffoca gli spazi di democrazia e libertà per la maggioranza della nostra gente.
Questo articolo di Giuliano Granato (portavoce di Pap) è pubblicato in collaborazione con Canal Red, fondato e diretto da Pablo Iglesias
Nella foto: Giorgia Meloni, frame del video di Fratelli d’Italia, 15 maggio 2024