Come ha fatto Ken Loach a sopravvivere alla caduta del muro di Berlino, al fallimento del comunismo, lui, unico regista schierato nel panorama cinematografico internazionale che mette al centro dei suoi film i lavoratori, gli immigrati, le donne, gli emarginati?
Viene il sospetto che Loach nutra il pensiero che la ribellione sia una condizione naturale dell’uomo ancor prima di venir esaltata o deprezzata dalle ideologie e dagli intellettuali. Che l’umanità sia naturalmente di sinistra e che l’uomo sia fondamentalmente un animale sociale. E che la religione, il fascismo, l’egoismo, l’individualismo liberista siano una perversione del pensiero umano, non la sua essenza.
Tutto questo lo avverti nei film del britannico da come inquadra i suoi personaggi, dalle storie che racconta, dal vento di forte umanità che spira dalle sue pellicole. Vi è la convinzione in Loach, al pari di Camus, che nell’uomo vi sia un’invincibile estate dura a morire anche di fronte al più rigido inverno. Che non è il sol dell’avvenire né il paradiso in terra per gli uomini di buona volontà. E’ un’idea di uguaglianza che non può essere toccata nell’uomo pena la rivolta. Questo per Loach è il motore della storia e delle sue storie.
 Jimmy’s hall non fa eccezione. Irlanda Anni Trenta. Jimmy è un ragazzo di provincia con idee progressiste (già costretto a fuggire per questo) che desidera semplicemente creare uno “spazio caldo” (dice proprio così!) per la sua comunità lontano dallo sguardo delle guardie e del clero. Una sala da ballo che sia anche luogo di incontro, di lettura, di studio. Tutte cose che non possono esistere sotto l’imperio di Santa madre Chiesa. Nella sala di Jimmy si balla, le ragazze vi giungono belle, le loro gambe e le loro braccia si muovono sinuose. Per il clero e le autorità irlandesi è una colpa imperdonabile, più dei sabotaggi dell’Ira perché infine anch’esse odorano di incenso. La curia impersonata da padre Sheridan a braccetto con le forze di repressione minaccia, scheda, terrorizza la vita di donne e bambini. Considera pericoloso quel ritrovo perché sa che quella rivolta partita dalle gambe potrebbe giungere alla testa.
Jimmy’s hall non fa eccezione. Irlanda Anni Trenta. Jimmy è un ragazzo di provincia con idee progressiste (già costretto a fuggire per questo) che desidera semplicemente creare uno “spazio caldo” (dice proprio così!) per la sua comunità lontano dallo sguardo delle guardie e del clero. Una sala da ballo che sia anche luogo di incontro, di lettura, di studio. Tutte cose che non possono esistere sotto l’imperio di Santa madre Chiesa. Nella sala di Jimmy si balla, le ragazze vi giungono belle, le loro gambe e le loro braccia si muovono sinuose. Per il clero e le autorità irlandesi è una colpa imperdonabile, più dei sabotaggi dell’Ira perché infine anch’esse odorano di incenso. La curia impersonata da padre Sheridan a braccetto con le forze di repressione minaccia, scheda, terrorizza la vita di donne e bambini. Considera pericoloso quel ritrovo perché sa che quella rivolta partita dalle gambe potrebbe giungere alla testa.
A Loach è riuscita l’impresa di fare un film storico col tempo presente. Jimmy’s Hall è il più riuscito dei tre (Terra e Libertà e Il vento che accarezza l’erba) perché va dritto all’essenziale, non eccede in retorica e non fa sconti a nessuno. Che l’Irlanda non sia cambiata e che i nemici siano quelli di sempre, Santa Romana Chiesa e una forza straniera che ne condiziona il destino?
Ken Loach conferma la coerenza e lo stile di una vita, anche se occorre ricordarlo, il suo cinema ha compiuto una svolta fondamentale a metà degli anni Novanta con la collaborazione dello sceneggiatore Paul Laverty che gli ha tolto il grigiore di Piovono pietre e Ladybird Ladybird rendendo la sua opera meno manichea, più complessa e aperta ai molteplici umori del mondo. I tipi di Loach e Laverty sono gente comune: precari, adolescenti smarriti, donne che provano a farcela da sole. Un popolo che pensa.





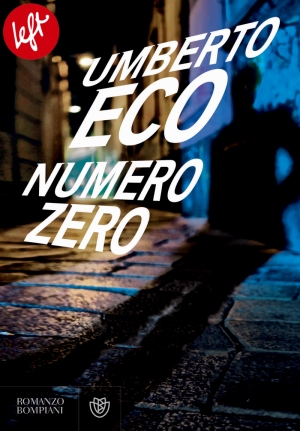 Sviluppa un teorema del Cimitero di Praga (se si può fabbricare un falso che sembra autentico cade la distinzione tra vero e falso), declinandolo nella manipolazione giornalistica, che può consistere anche solo nell’allineare notizie eterogenee creando allarme. E aggiungendo un’intuizione notevole: la trasparenza vige nei regimi dittatoriali, mentre i misteri ci sono solo in democrazia, ma a nessuno gliene importa più nulla perché qualsiasi verità viene presa per l’ennesima “narrazione”. Un universo orwelliano, morbidamente dispotico.
Sviluppa un teorema del Cimitero di Praga (se si può fabbricare un falso che sembra autentico cade la distinzione tra vero e falso), declinandolo nella manipolazione giornalistica, che può consistere anche solo nell’allineare notizie eterogenee creando allarme. E aggiungendo un’intuizione notevole: la trasparenza vige nei regimi dittatoriali, mentre i misteri ci sono solo in democrazia, ma a nessuno gliene importa più nulla perché qualsiasi verità viene presa per l’ennesima “narrazione”. Un universo orwelliano, morbidamente dispotico.


Da Auschwitz a Srebrenica. L’importanza di ricordare
Auschwitz sta lì a ricordare a tutti noi perché abbiamo fatto l’Europa Unita. Srebrenica ci serve a cambiarla. La memoria è materia impegnativa perché quando presa sul serio, costituisce un vincolo all’azione politica che diventa Storia. La memoria di Auschwitz ha provocato il più grande “agglutinamento” pacifico tra identità nazionali mai avvenuto prima e questo è un bene grande che sarebbe un delitto sminuire e logorare a colpi di cinismo e indifferenza.
Molto da allora è stato fatto, ma guai a pensare che le conquiste abbiano a che fare con lo stato solido: hanno piuttosto a che fare con quello liquido, per questo servono continuamente mani pronte a rinnovare lo sforzo costruttivo. La realtà non è mai un dato, è sempre un processo, fissato temporaneamente nel racconto, più che nell’esperienza. Avidità e violenza possono vestire dell’abito nero del terrore, in ogni momento, brandendo questo o quel dio. Dio è una variabile dipendente dalla volontà di potenza.
Quest’anno saranno trascorsi 20 anni dalla strage di Srebrenica: era luglio del 1995 e almeno 8.000 bosniaci musulmani vennero ammazzati a sangue freddo da spietati militi cristiani, nel cuore dell’Europa. Un’Europa inadeguata. Dovremmo andarci a Srebreni- ca quest’anno, con le medesime modalità con le quali ogni anno andiamo in tanti ad Auschwitz: disposti a ricapitolare in noi un orrore banale, che ci impone di essere vigili e capaci di un futuro migliore.
Ancora una volta ci diranno che siamo folli e ingenui, ancora una volta sceglieremo l’incontro e il dialogo per costruire pace e giustizia. Per restare umani. Eventi come Auschwitz e Srebrenica sono talmente gravi e grandi, che dovrebbero servire a ciascuno per ritrovare, anche soltanto nella circostanza della commemorazione, le superiori ragioni della convivenza pacifica tra gli esseri umani: una boccata di ossigeno e di senso del limite.
Spiace e preoccupa quindi registrare l’annunciata assenza del presidente Putin ad Auschwtiz il 27 Gennaio. Quei cancelli terribili, il 27 Gennaio del 1945, furono abbattuti proprio dall’Armata Rossa.
[social_link type=”twitter” url=”https://twitter.com/mattiellodavide” target=”on” ][/social_link] @mattiellodavide
*deputato Pd, presidente fondazione Benvenuti in Italia