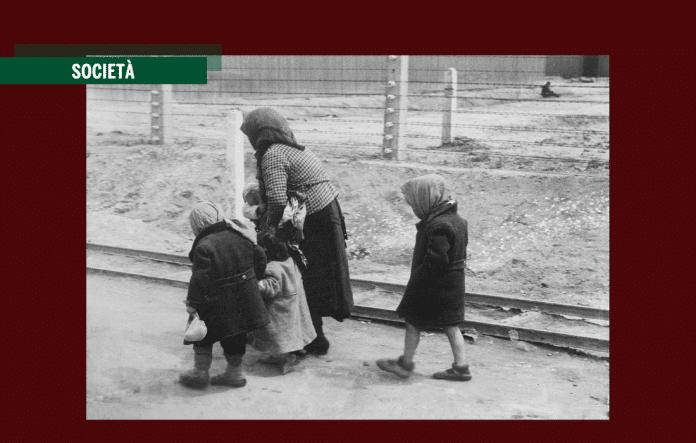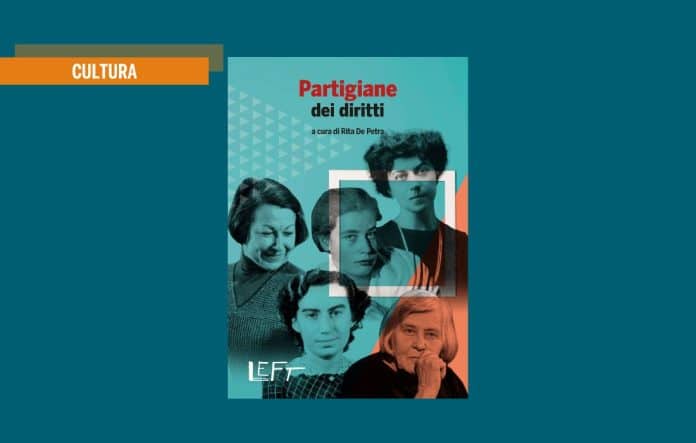La guerra continua da oltre un anno e mezzo senza neanche un giorno di tregua. La controffensiva che avrebbe dovuto portare l’Ucraina alla vittoria è iniziata da più di tre mesi, senza produrre nessuno spostamento significativo del fronte. È in corso una orribile guerra di attrito che ci ricorda quella delle prime undici battaglie dell’Isonzo combattute da giugno 1915 a agosto 1917. Battaglie combattute praticamente senza spostamenti significativi del fronte, ma con centinaia di migliaia di morti da entrambe le parti. «La realtà, da un lato e dall’altro, è una guerra di trincea – ha scritto il generale Antonio Li Gobbi su Analisi difesa – che pensavamo fosse relegata con le sue brutture nella nostra preistoria. Combattimenti senza gloria condotti in fetide trincee dove le lacrime si mischiano al sudore, il sangue agli escrementi, il fango ai cadaveri che non possono trovare tempestiva sepoltura». I numeri di questa carneficina, fatti trapelare dal colonnello Douglas Macgregor (cfr Mini, il Fatto quotidiano, 13/9/2023), già consigliere del Pentagono, sono impressionanti. «Valutiamo che gli ucraini abbiano avuto 400 mila morti in combattimento. Nell’ultimo mese di questa presunta controffensiva che avrebbe dovuto spazzare il campo di battaglia, hanno avuto almeno 40.000 morti. Non sappiamo quanti siano i feriti, ma sappiamo che probabilmente tra i 40 e i 50.000 soldati hanno subito amputazioni, che gli ospedali sono pieni».
Gli esperti militari avevano avvertito i responsabili politici che la “vittoria” sul campo dell’Ucraina era un obiettivo impossibile. In particolare, il Capo di Stato maggiore dell’esercito americano, gen. Mark Milley, aveva avvisato: «Né l’Ucraina né la Russia sono in grado di vincere la guerra che, invece, può solo concludersi ad un tavolo negoziale». Le scelte degli Usa e della Nato, invece, puntano ad istigare Zelensky alla guerra ad oltranza. Da ultimo il segretario di Stato Antony Blinken si è recato a Kiev, il 6/7 settembre, portando aiuti per un miliardo di dollari. Gli aiuti statunitensi – ha detto Blinken – consentiranno alla controffensiva ucraina di “acquisire slancio”. L’orientamento degli architetti della politica internazionale dell’Occidente di proseguire la guerra ad oltranza (promettendo a Zelensky una vittoria impossibile) comporta il prolungamento di un massacro senza senso e senza nessuno sbocco, come fu la guerra di Corea, che si concluse con un armistizio lasciando inalterata la linea del fronte, dopo aver provocato quasi tre milioni di morti. L’armistizio, firmato il 27 luglio del 1953, pose fine ai combattimenti ma non allo stato di guerra poiché dopo settant’anni non è stato ancora stipulato un Trattato di pace.
Mentre continua il coro, intonato da politici e mass media sulle note di Biden e Stoltenberg, che invoca la vittoria e promette la continuazione del massacro, nessuna Cancelleria, nessuna forza politica è capace di aprire una finestra sul futuro. Nessuno è in grado di azzardare un progetto per il futuro, anche perché gli eventi che hanno provocato la guerra e che determinano la sua continuazione ad oltranza, annunziano un futuro oscuro del quale è meglio non parlare. È stato uno dei principali interpreti della prima guerra fredda, Henry Kissinger (in un intervista al Corriere della Sera del 28 giugno 2022) ad avvertirci che bisogna guardare come porre fine al conflitto: «Stiamo arrivando a un momento – afferma – in cui bisogna affrontare la questione della fine della guerra in termini di obiettivi politici altrettanto che militari: non si può semplicemente continuare a combattere senza un obiettivo».
Per Kissinger l’unico obiettivo realistico che può garantire la pace è di reintegrare la Russia nell’Europa, non certo spingerla ad est nelle braccia della Cina. Perché questo è il punto centrale del suo ragionamento: va sconfitta l’invasione dell’Ucraina, «non la Russia come Stato e come entità storica». E dunque, quando le armi alla fine taceranno, «la questione del rapporto fra Russia ed Europa andrà presa molto seriamente». Il presupposto, sottolinea Kissinger, è che la Russia è stata parte della storia europea per cinquecento anni, è stata coinvolta in tutte le grandi crisi e «in alcuni dei grandi trionfi della storia europea»: e pertanto «dovrebbe essere la missione della diplomazia occidentale e di quella russa di tornare al corso storico per cui la Russia è parte del sistema europeo. La Russia deve svolgere un ruolo importante».
Senonchè l’obiettivo di reintegrare la Russia nel sistema europeo è diametralmente opposto agli obiettivi perseguiti da una politica che, attraverso l’allargamento ad est della Nato e la svolta russofoba dell’Ucraina dopo il golpe di Maidan, ha identificato la Russia come nuovo nemico da sostituire alla dissolta Unione Sovietica, scavando un solco per dividere per sempre la Russia dal resto dell’Europa. Questo solco adesso si è trasformato in una cortina di ferro fondata sul sangue e sull’odio. Una cortina invalicabile perché alimentata dall’odio generato da 500.000 morti, milioni di profughi e distruzioni incommensurabili.
Il conflitto in corso rischia di essere una guerra costituente su cui si decideranno gli equilibri geopolitici internazionali, la posta in gioco è il futuro del mondo. Un mondo nel quale, alla collaborazione fra le principali potenze posta a base del progetto di pace delle Nazioni Unite, si sostituirebbe la logica della contrapposizione inevitabile e del confronto politico-militare fra l’Occidente collettivo a guida Usa e la Cina, in un crescendo di tensioni e di corsa al riarmo. Questo vale soprattutto per Europa dove – qualora si dovesse giungere ad una tregua di tipo coreano – la guerra proseguirebbe con altri mezzi. Resterebbero in piedi le sanzioni, la separazione economica e l’apartheid nei confronti della società e della cultura russa. Resterebbe in piedi l’accumulo delle minacce militari e la corsa al riarmo, a danno delle spese sociali. Una cappa di terrore e di odio, graverebbe sul continente avvelenando la vita delle nazioni.
Non bisogna rassegnarsi al futuro orribile che il conflitto in corso lascia intravedere. Se è indifferibile un’azione politica per fermare la prosecuzione della guerra, a cominciare dal blocco della fornitura di armi, è altrettanto urgente pensare a come uscire dalla guerra e dalle cause che l’hanno generata.
In realtà è proprio durante la guerra che è più forte l’esigenza di pensare la pace, di delineare un progetto che consenta di superare le cause che hanno provocato la guerra per ristabilire la convivenza pacifica fra le nazioni. Come fecero quei visionari che nel 1941 misero mano al Manifesto di Ventotene. Come ci ha ricordato Pasqualina Napoletano (CRS:Pensare la pace sotto le bombe): «quel gruppo di visionari, riuscì a concepire un progetto capace di andare oltre l’odio, con l’intento di riappacificare popoli e nazioni, responsabili di due Guerre Mondiali. Un progetto coraggioso, che non si fondasse sull’umiliazione e sulla vendetta ma sulla integrazione economica e politica: gli Stati Uniti d’Europa». Quale progetto per la riappacificazione e la convivenza pacifica, o quanto meno per la sicurezza collettiva in Europa abbiamo articolato? Quale progetto abbiamo in mente per prosciugare l’oceano di odio che la guerra ha creato fra due popoli fratelli e ripudiare il conflitto tribale fomentato dai nazionalismi, l’un contro l’altro armati? Se si oscurano le cause che hanno portato alla scoppio del conflitto, ivi compreso il fatto che per oltre 25 anni gli Usa hanno praticato una nuova guerra fredda per umiliare ed isolare la Russia, come si fa a rimediare agli errori commessi per impostare un nuovo criterio di convivenza pacifica?
La visione del futuro può nascere solo da una revisione critica del passato, dal ripudio di una politica orientata a costruire l’ostilità nei rapporti fra le nazioni, a perseguire la “sicurezza” di una parte (la nostra) a danno dell’altra parte, incrementando le minacce militari e l’assedio geopolitico al “nemico”. Bisogna costruire un percorso a ritroso, riprendendo la strada che portò alla Conferenza sulla Sicurezza e cooperazione in Europa, conclusasi nel 1975 con l’Atto finale di Helsinki. I principi della Conferenza, condensati nell’Atto finale sono serviti a favorire la distensione fra i contrapposti blocchi militari in un’epoca in cui erano ancora presenti tutte le insidie della guerra fredda, ed hanno configurato la sicurezza in Europa come sicurezza collettiva fondata sul disarmo. Questi principi sono stati calpestati da una politica che ha privilegiato la contrapposizione al posto della cooperazione, l’emarginazione al posto del dialogo, il riarmo unilaterale al posto del disarmo negoziato, la costruzione dell’ostilità al posto dell’amicizia fra i popoli.
Per prima cosa occorre ripudiare la pretesa di costruire la pace attraverso la “vittoria”, cioè l’umiliazione della Russia e la negazione dei suoi interessi. Questa pretesa esclude ogni possibilità di negoziato, la mediazione non contempla vittorie, ma è, per antonomasia, la conciliazione di interessi geopolitici contrapposti, a cui si deve dare identica legittimità .
Bisogna pensare ad un futuro “disarmato”, in cui la sicurezza per i singoli Stati e per l’Europa nel suo complesso non sia fondata sul riarmo e l’estensione della minaccia militare, bensì sul disarmo negoziato e sulla riduzione della pressione militare. La Nato deve cessare di “abbaiare” ai confini della Russia e l’Ucraina non può essere la lancia della Nato nel costato della Russia. Deve essere restaurata la convivenza pacifica fra i due popoli dell’Ucraina e fra l’Ucraina e la Russia. Il baratro di dolore che la guerra ha scavato fra i due popoli può essere colmato solo col negoziato e non con le armi o la vendetta. Un negoziato sotto l’egida dell’Onu che dia la parola alle popolazioni interessate, perché se le frontiere sono inviolabili, ancora più inviolabili sono gli esseri umani, che non possono essere sacrificati dai loro governi per tracciare i confini con i coltelli.
È questo il momento di definire un progetto che superi non solo il conflitto in armi, ma quel sistema di dominio e di contrapposizione politica e militare che ha generato la guerra e sta distruggendo l’Europa. È il momento di pensare che un altro mondo è possibile e di progettarlo, come fecero quegli intellettuali cattolici che scrissero fra il 18 e il 24 luglio del 1943, prima della caduta del fascismo e nella fase più drammatica della guerra, il “codice dei Camaldoli”, prefigurando un nuovo ordinamento che trovò inveramento, grazie al contributo fecondo di altre culture, nella Costituzione della Repubblica italiana.
Bisogna pensare a come reintegrare la Russia nell’Europa, ad un negoziato che punti a ristabilire il dialogo, il confronto, la fiducia, gli scambi culturali con il popolo russo, in modo che la Russia non sia più avvertita come una minaccia per l’Europa e l’Europa non sia più avvertita come una minaccia per la Russia. Bisogna ripensare all’Europa recuperando l’impostazione originaria dei padri fondatori che hanno messo la costruzione della pace a fondamento del progetto europeo.
Il mondo che verrà sarà orribile se non saremo capaci di ripudiare le scelte che hanno aperto la strada al ritorno della guerra in Europa e nel resto del mondo. Questo è il momento di progettare un altro mondo per non andare tutti all’altro mondo.
L’autore: Il magistrato Domenico Gallo è stato presidente di sezione della Corte di Cassazione. Già senatore della Repubblica, fa parte del comitato esecutivo del Coordinamento per la democrazia costituzionale. Ha scritto il libro Il mondo che verrà (Deltra3edizioni)