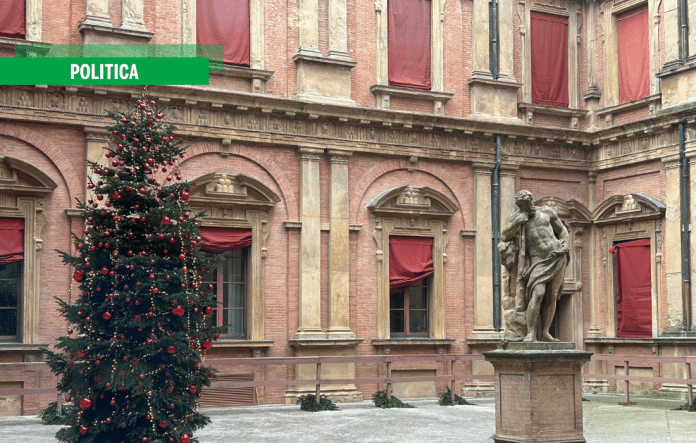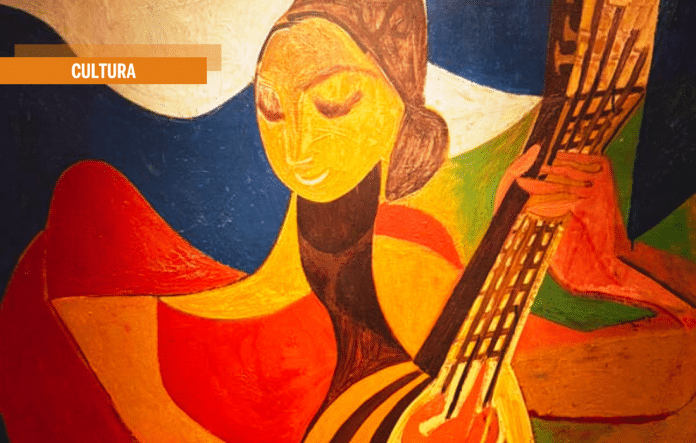La notizia notizia del diniego dell’Università di Bologna alla richiesta, avanzata dall’Accademia militare di Modena, di istituire un corso ad hoc per gli allievi militari ha improvvisamente polarizzato per giorni il dibattito politico e pubblico. Ma tante inesattezze sono state dette. Proviamo a fare chiarezza. Ottobre 2025: i componenti del Consiglio di dipartimento di filosofia dell’ateneo felsineo leggono che all’ordine del giorno della seduta prevista per il 23 ottobre vi è la discussione della proposta dell’Accademia militare modenese – avanzata nella persona del generale Carmine Masiello – di organizzare un curriculum del corso di Laurea Triennale in Filosofia (che attualmente prevede due curricula) dedicato esclusivamente a 15 allievi dell’Accademia. La richiesta era stata avanzata prima dell’estate al Rettore Molari ma solo in autunno è giunta alla discussione del Consiglio. Quest’ultimo avrebbe dovuto decidere nella stessa seduta se approvare o respingere tale richiesta. E già qui appare la prima assurdità: come può un organo così ampio come il Consiglio di dipartimento, del quale sono parte non solo docenti ma anche studentesse e studenti nonché il personale tecnico-amministrativo, poter esprimersi su una questione così delicata senza un congruo preavviso e una discussione articolata? Peraltro, molti delle e dei docenti presenti alla seduta del Consiglio sarebbero stati chiamati a essere titolari di alcuni degli insegnamenti destinati agli allievi e, secondo quanto previsto dall’accordo, avrebbero dovuto svolgere le lezioni presso l’Accademia a Modena e non nei locali dell’ateneo. Una seconda assurdità: da quando docenti, dei funzionari statali, svolgono lezioni a domicilio? Ma andiamo avanti.
Alla seduta del 23 ottobre sono presenti, come accennato, anche i e le rappresentanti della componente studentesca (e vi sarà anche l’irruzione di altri esponenti di collettivi e movimenti universitari, seppur breve) la cui posizione è – a differenza di quella di molti altri membri del Consiglio – ben chiara: a Bologna non c’è spazio per la militarizzazione dell’università. Il dibattito prosegue, con il formarsi di schieramenti opposti che non vedono contrapposti solo corpo docente e studentesco ma anche gli stessi docenti tra loro. Un siparietto che aprirebbe una lunga riflessione sull’effettiva capacità di chi afferma di poter insegnare il pensiero filosofico ad essere realmente portatore di un sapere critico e di una capacità di analisi libera da pressioni esterne. La discussione lascia il tempo che trova, e qualche giorno dopo tutte le componenti della Facoltà ricevono una mail dal Direttore del Dipartimento, Prof. Luca Guidetti, in cui si afferma che non sussistono più “le condizioni materiali e formali per portare avanti il progetto di convenzione con l’Accademia militare di Modena per un curriculum di filosofia”. Questa frase racchiude tutto ciò che si dovrebbe sapere. Racchiude le motivazioni dell’Ateneo alla negazione del nuovo curriculum (banalmente i costi per l’attivazione e per l’organico); racchiude la volontà dei componenti del Consiglio – o quanto meno della sua maggioranza; racchiude lo spirito di autonomia e di autodeterminazione di cui le università sono portatrici e in base al quale devono agire. Tuttavia, come era prevedibile, la questione non termina qui. Proprio in questi giorni, lo stesso generale Masiello ha parlato di una volontà di rifiuto dell’Alma Mater di accettare l’iscrizione degli allievi. Un modo molto peculiare di parlare della libertà accademica. Le parole del generale, come era prevedibile, sono immediatamente state raccolte dagli esponenti maggioranza che non hanno atteso prima di gridare alla dittatura ideologica della sinistra, al tradimento dei valori costituzionali, a una chiusura dettata da interessi di parte. Dalla premier Meloni al ministro dell’Interno Piantedosi, dal ministro della Difesa Crosetto alla ministra dell’Università e della Ricerca Bernini, è stato un susseguirsi di strumentalizzazione e di distorsione dei fatti.
Chiariamo immediatamente un punto: a nessuno è stato negato il diritto all’istruzione universitaria. Gli Allievi dell’Accademia militare possono iscriversi agli esistenti curricula del corso di filosofia esattamente come chiunque altro sia in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso. Semmai, se di negazione al diritto di istruzione si vuole parlare, bisognerebbe pensare alle migliaia di studentesse e studenti che quest’anno hanno avuto ridotta l’ammontare della borsa di studio, che non hanno la possibilità di far fronte alle spese per acquistare i materiali didattici, che non trovano un alloggio dignitoso a un prezzo accessibile nella città che si vanta di essere la più progressista d’Italia ma che non si occupa neppur lontanamente di trovare una soluzione alla crescente crisi abitativa. Del vittimismo di facciata non ce ne facciamo nulla. In un mondo che vede crescere la precarietà, che vive nella paura di possibili eventi catastrofici, che si trova a dover vedere ogni giorno l’impunità con cui viene commesso il genocidio in Palestina con la complicità degli atenei e delle aziende italiane (Leonardo S.p.a. in primis), l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è compiangere chi in realtà vuole solo manipolare e comandare. Perché di questo si tratta. Di un attacco alla libertà organizzativa dell’università, alla sua autonomia e alla sua decisionalità. Quello che il corpo militare con il benestare dell’attuale governo vuole realizzare è la militarizzazione del sapere universitario, la sua sottomissione alle rigide regole del conflitto, alla volontà di distruzione. Se l’attuale esecutivo ha così a cuore, come ha ammesso in queste ore, la crescita degli atenei perché non investe nella ricerca invece di imporre un corso pensato per una stretta e privilegiata nicchia. Perché, mi chiedo, continua a tagliare i fondi destinati alle università se è così importante concedere a chiunque la possibilità a una formazione superiore (almeno stando alle loro parole). Forse perché ciò che è realmente importante non è la libertà di pensiero, il confronto dialettico, la crescita umana e culturale ma il controllo delle forme del sapere e della sua organizzazione. È piegare anche i centri universitari alla logica del profitto, della guerra e del liberalismo. Il riarmo passa anche da qui. Del resto, la storia ci insegna come il potere abbia sempre avuto bisogno di sottomettere il sapere e le sue molteplici forme per potersi sentire realmente al sicuro.
L’autrice: Ludovica Micalizzi è borsista presso l’Università di Bologna