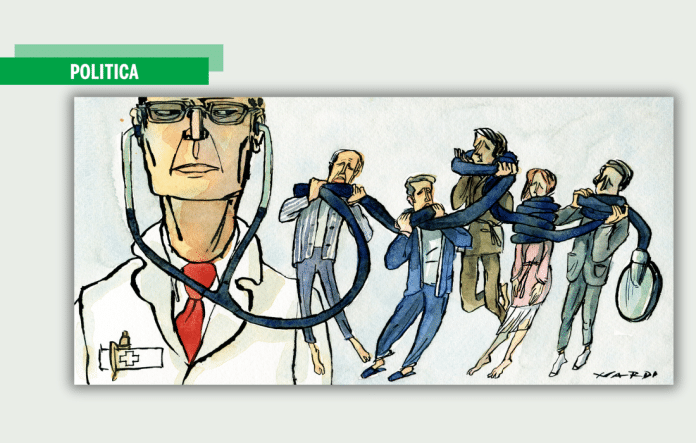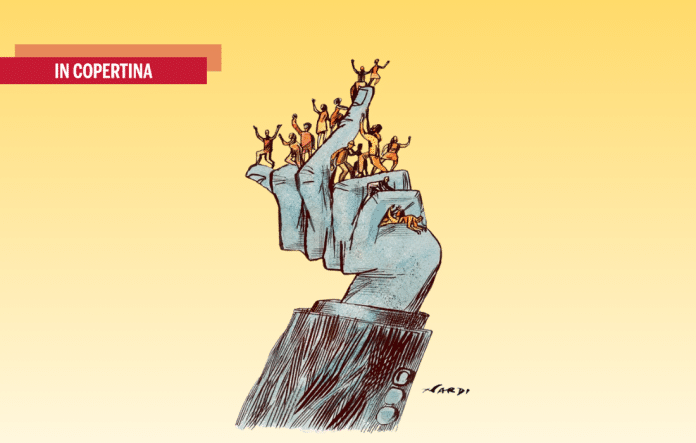Siska De Ruysscher, una ragazza belga, bellissima, dai lunghi capelli biondi, occhi verdi, raffinata nel vestire, domenica 2 novembre se n’è andata, lasciandoci tutti attoniti e un po’ smarriti. Ora, lei, con le notizie riguardanti la procedura per l’eutanasia, avviata da oltre un anno e giunta a compimento nello scorso ottobre, è diventata un nome, che il medico, che le ha praticato l’iniezione, ha l’obbligo di trascrivere nel registro della Commissione federale di controllo e valutazione.
Ma lei ha deciso di non diventare solo un dato statistico da comunicare al Parlamento, ogni due anni e il 17 ottobre, compiuti 26 anni, ha infranto il muro di riservatezza, che protegge la privacy in Belgio e, tramite interviste e video, ha annunciato «de se faire euthanasier», per porre fine a dolori psichici «insopportabili». La giovane donna ha denunciato la sua condizione: «Da molti anni lotto contro un disturbo depressivo acuto, un disturbo da stress post-traumatico, un disturbo dell’attaccamento e pensieri suicidi». La legge belga in vigore dal 2002 prevede che «un paziente, maggiorenne e un minore emancipato, capace di intendere e volere al momento della richiesta, possano presentare istanza, meditata e reiterata, e non indotta da pressioni esterne; se versa in una condizione sanitaria senza speranza e la sua sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile».
Guardando Siska De Ruysscher ho pensato ai commenti sulla stampa: “Che peccato! Una così gran bella ragazza!” e se non fosse stata “bella”? La cosa “strana” è che lei pareva saperlo bene. Però ti accorgevi che quella bellezza era come messa lì a coprire la monotonia del tono della voce, a cui faceva da contrappunto, l’affiorare dal trucco perfetto di un sorrisetto appena percepibile. E pensavi: un viso fermo, una sicurezza di sé che sfida il mondo, un’immagine che mal si concilia con la melanconiatipica dei dipinti di Dürer o di Hayez, a cui eri abituata. Poi la compassione per tutto il dolore delle malattie psichiche che le hanno diagnosticato e per il pensiero che a soli 13 anni voleva già morire, per il bullismo subito all’asilo e alle elementari. Violenze che le hanno fatto sentire di essere «in qualche modo diversa». «Le mie difficoltà erano più grandi di quelle dei miei compagni di classe, e loro mi hanno delusa» ha detto Siska De Ruysscher. In dieci anni, questa giovane donna si è accanita sul proprio corpo reiterando il tentativo di suicidio: «La gente pensa: “Quaranta tentativi, voleva davvero morire?”». Ed ora, giunta alla fine della strada, sente che il suo corpo ha ceduto: «Sono esausta. Lavorare non è più possibile e anche le più piccole cose quotidiane sono diventate una lotta impossibile: alzarsi, fare la spesa, vestirsi, aprire le persiane». Nel commiato sulla sua pagina facebook, rivolge accuse durissime al sistema sanitario e a quello sociale, riassumibili in: “Nessuna cura”. «La prima persona a cui ho detto quanto fosse buio nella mia testa è stata l’insegnante di assistenza a scuola. Poi sono passata da uno psicologo all’altro e da un assistente all’altro, forse una ventina. Ho sempre ricevuto le stesse domande, sempre gli stessi fascicoli in cui dovevo mettere le crocette».
E da “esperta” elencava