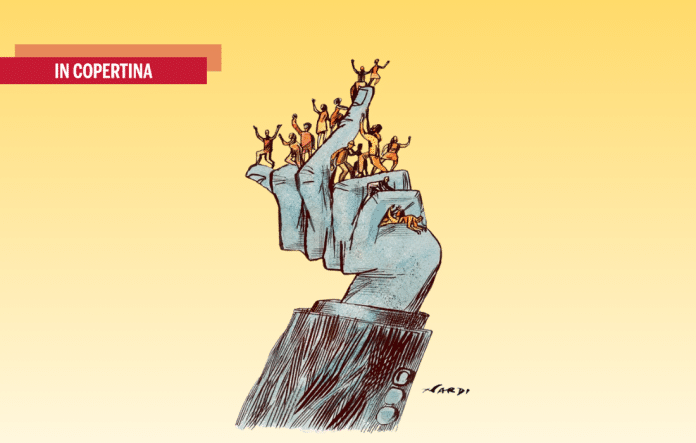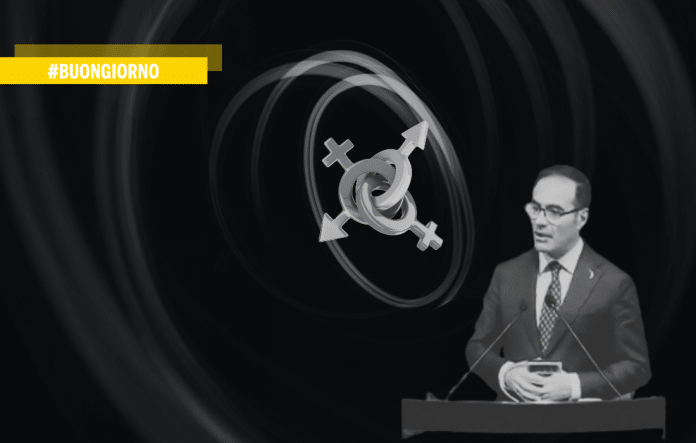Quale Stato non tutela la memoria dei suoi concittadini? Se lo chiedono da cinque anni i genitori di Mario Paciolla, cooperante Onu italiano morto in Colombia il 15 luglio 2020. Ufficialmente si tratterebbe di un suicidio. Il 5 novembre Anna Motta e Pino Paciolla hanno raccontato per l’ennesima volta la storia del figlio, sottolineando i punti oscuri, le ombre e le mille contraddizioni della versione ufficiale. Lo hanno fatto per promuovere la proposta di legge che intende istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sul suo caso. Una commissione che, oltre al caso di Mario, dovrà occuparsi anche dell’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio, morto in un agguato in Congo insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all’autista congolese Mustapha Milambo.
Si tratta chiaramente di due vicende distinte, ma con alcuni elementi comuni, primo fra tutti il ruolo non chiaro dell’Onu e di alcuni suoi funzionari. La proposta porta la firma di numerosi parlamentari dei principali partiti d’opposizione. Nessuno interessamento è arrivato, almeno per ora, dai banchi della maggioranza. «Si tratta di un impegno politico e morale non soltanto verso la memoria delle vittime e verso i loro familiari, ma anche verso l’intera società italiana», dichiara l’on. Marco Lombardo, senatore di Azione e primo firmatario della proposta. Durante il suo intervento si appella alle massime cariche dello Stato e al Governo affinché l’iter per l’approvazione venga calendarizzato il prima possibile. Anche i genitori di Mario si uniscono all’appello. «Il diritto alla verità non è un privilegio da riconoscere a qualcuno e non ha colori politici», ammonisce Anna, la madre, durante il suo intervento. E poi aggiunge: «Senza verità muore la giustizia e muore la fiducia nelle istituzioni». Per loro, questa commissione d’inchiesta, rappresenta la speranza di ottenere finalmente le risposte che inseguono da anni.
La battaglia di Anna e Pino per la verità, che mai avrebbero voluto ritrovarsi a combattere, comincia il 15 luglio 2020 con una telefonata. La voce proviene dall’altra parte del mondo e li avverte, in un perfetto italiano, di avere brutte notizie. Mario è stato infatti trovato impiccato quella mattina, con dei tagli sui polsi, a casa sua, in Colombia. Ad annunciare alla coppia la morte del figlio è una donna che si qualifica come un legale delle Nazioni Unite. Senza fornire ulteriori spiegazioni, chiede loro se vogliono la restituzione della salma. «Ci disse che si trattava di una domanda di prassi», racconta Pino. Sarà l’ultima comunicazione che riceveranno dall’ONU. Mario Paciolla, 33 anni, giornalista, originario di Napoli, lavorava in Colombia dal 2016. Prima un periodo con le Brigate Internazionali di Pace, poi dal 2018 con le Nazioni Unite, come osservatore. «Era un professionista, laureato in relazioni internazionali, non uno sprovveduto», chiarisce la madre, «e aveva già esperienza nella cooperazione». Al momento della morte si trovava San Vincente del Caguán, un paese di nemmeno 50000 abitanti. Lì, ai margini della foresta amazzonica, il suo compito era quello di vigilare sul rispetto degli accordi di pace tra il governo colombiano e i guerriglieri delle FARC.
I genitori e gli amici lo ricordano come un ragazzo pieno di vita, animato da un sincero e vivo interesse per il suo lavoro e per la comunità. «Fin dal principio non abbiamo mai creduto che nostro figlio potesse essersi tolto la vita», spiega Anna. A mettere in crisi la versione adottata dalle Nazioni Unite e dalle autorità colombiane è una serie di elementi. Anzitutto ci sono gli ultimi messaggi scambiati dai genitori con il figlio. Mario, infatti, il giorno prima li aveva contatti manifestando l’intenzione di rientrare al più presto in Italia. Aveva già preso anche un biglietto aereo da Bogotà. I genitori riferiscono che mostrava una certa preoccupazione. Voleva lasciare la Colombia. Poi c’è la perizia medica di parte, svolta dal professor Vittorio Fineschi, secondo cui i segni presenti sul collo di Mario sarebbero più compatibili con lo strangolamento che con un tentativo di togliersi la vita impiccandosi. Non è convincente nemmeno la dinamica, come ricostruita dalle autorità colombiane, che appare confusa e contraddittoria. Mario avrebbe dapprima provato a tagliarsi le vene e solo successivamente, con i polsi lacerati, sarebbe salito su una sedia posta sul tavolo per impiccarsi, senza però lasciare macchie di sangue in giro. La famiglia Paciolla e i suoi legali hanno più volte posto all’attenzione della magistratura italiana queste e altre prove, che minano la tesi del suicidio. Subito dopo la notizia della morte la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo, disponendo anche un sopraluogo dei R.i.s. in Colombia per ispezionare la scena del crimine.
La casa di Mario però era stata già pulita a fondo con della candeggina e alcune prove fondamentali, come i quaderni del giovane ed altri suoi effetti personali, erano scomparse. Il responsabile della sparizione, secondo la ricostruzione dei legali della famiglia, sarebbe proprio il capo della sicurezza della missione Onu di Mario. Si tratta di Christian Thompson, un ex militare riciclatosi come impiegato dell’Onu, il cui ruolo nella vicenda appare ancora oggi estremamente opaco. Nell’ottobre del 2022, dopo due anni di indagini, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione. «Non ce lo aspettavamo», ammette il padre, «le tesi della procura erano la copia della ricostruzione fatta dalla polizia colombiana». La stessa polizia sospettata di aver aiutato ad alterare la scena del crimine. Un anno dopo, il giudice per le indagini preliminari accoglie le obiezioni della famiglia e rigetta la richiesta di archiviazione. Secondo il gip l’ipotesi del suicidio destava «numerose perplessità sul piano logico». A giugno del 2024 è arrivata dai magistrati una seconda richiesta di archiviazione, con le stesse motivazioni della prima. Stavolta la richiesta viene accolta. Il 30 giugno 2025, dopo quasi cinque anni dalla morte, il caso di Mario è archiviato. La delusione e la rabbia dei genitori è incontenibile.
«Con il nuovo gip avevamo buone speranze», racconta il padre, «ci sembrava che finalmente si fossero presi nella giusta considerazione tutti gli elementi». «La procura non ha mai indagato a fondo su cosa Mario potesse aver scoperto nel suo lavoro», insiste la madre. Poi si rivolge ai colleghi del figlio all’Onu: «se sapete qualcosa fatevi avanti». Tuttavia, senza nuovi elementi, l’indagine è conclusa. La versione sostenuta dalle autorità colombiane e dalle Nazioni Unite viene accolta e fatta propria anche dalla magistratura italiana. «Siamo coscienti delle difficoltà di individuare i responsabili, ma ci saremmo aspettati che almeno non venisse avallata la storia che Mario si è ammazzato», concludono entrambi. Con l’archiviazione si è chiusa, salvo colpi di scena, la strada giudiziaria. La commissione parlamentare d’inchiesta potrebbe aprire ora la strada politica, forse la più adatta per abbattere le reticenze delle Nazioni Unite e del governo colombiano. Serve soltanto la volontà.
Foto WP