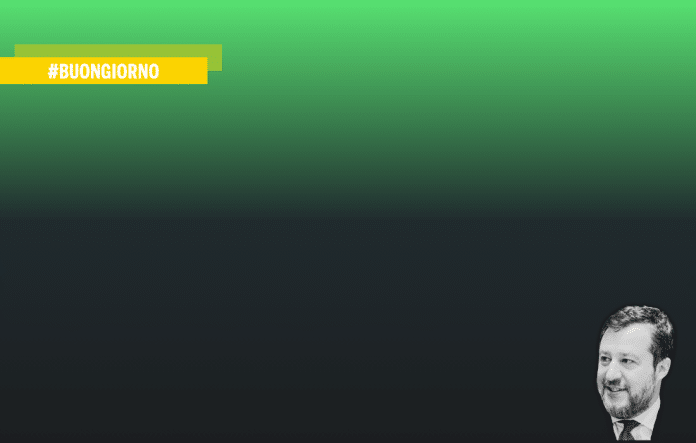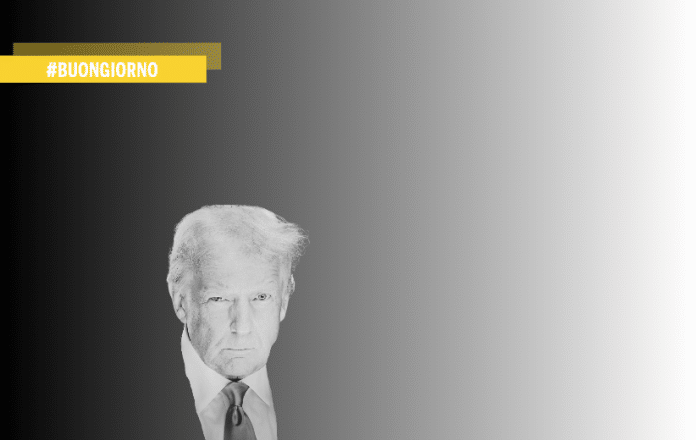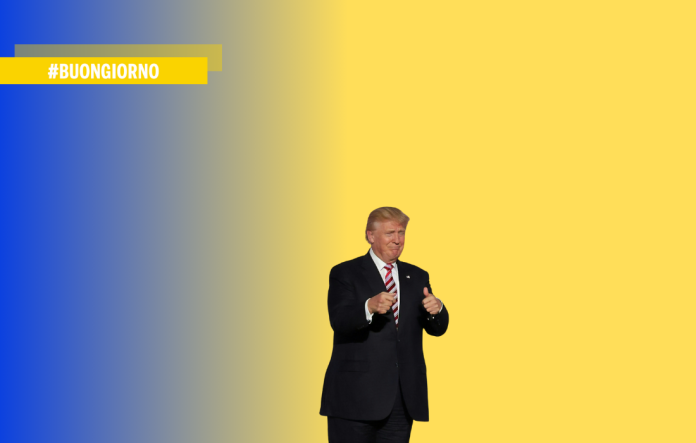La cattiva notizia è che, in Italia e nel mondo, le donne continuano a essere uccise. Nel nostro Paese, nell’82% dei casi l’assassinio si consuma in ambito familiare; nel 60% dei casi, l’omicida è il partner o ex partner. La buona notizia è che tutti i numeri sono in miglioramento: nei primi nove mesi del 2025 i femminicidi in Italia sono stati 73 (-20% rispetto allo stesso periodo del 2024). In sensibile riduzione anche gli omicidi familiari di donne (-24%). I femminicidi a opera di partner, o ex, sono passati da 48 a 44 (-8%).Le donne muoiono numericamente meno degli uomini, ma lo fanno prevalentemente in ambito familiare e affettivo e soprattutto per mano di partner o ex. Al ritmo di una alla settimana. Sempre una di troppo.Ma cosa si può fare per arrestare questo fenomeno che rappresenta una piaga sociale e una vergogna civile?
Prova a dare il suo contributo Irene Vella. Giornalista, scrittrice e content creator con il libro Era mia figlia. Per ritrovare le voci delle donne che abbiamo perduto (Solferino).
Irene, come nasce l’idea del libro?
Nasce da una mancanza enorme: la voce di chi non c’è più. In ogni femminicidio parlano tutti – giornali, tribunali, vicini, perfino gli assassini – tranne loro. Le vittime vengono zittite due volte: prima dalla violenza, poi dal racconto che le riduce a un fatto di cronaca. Un giorno mi sono detta: E se potessi restituire la voce a queste ragazze? Se potessero tornare a raccontare chi erano, e non solo come sono state uccise?” Così è nato Era mia figlia: dai 66 milioni di visualizzazioni in due mesi sui social, dall’urgenza collettiva di ascoltare, e dal mio bisogno di trasformare il dolore in un servizio. Io so fare una cosa: scrivere. E ho deciso di mettere la mia penna al servizio di chi non può più parlare».
Quali storie ti hanno turbato di più?
Sono tutte devastanti, ma ce ne sono due che mi hanno colpita nel punto più fragile: Sofia Castelli e il piccolo Daniele. La storia di Sofia mi ha spezzata, perché i miei figli hanno la sua stessa età. Sofia era nel letto della sua camera, il luogo più sicuro del mondo. Era appena rientrata, aveva rassicurato la mamma con un messaggio – “Mamma, tranquilla, sono a casa” – e poi si era addormentata. Nell’altra stanza c’era la sua amica del cuore: avevano parlato, riso, condiviso quella normalità che appartiene ai vent’anni. Quello che nessuno poteva immaginare era che il suo ex si fosse nascosto nell’armadio per sette ore, aspettando il momento giusto. Quando Sofia dormiva, lui è uscito e l’ha uccisa. Poi è scappato ed è stato arrestato più tardi. La mattina dopo, la sua amica l’ha trovata riversa nel sangue. Una scena che non si dimentica. La storia del piccolo Daniele è una ferita che non si rimarginerà mai. Un bambino di sette anni, un padre con un codice rosso attivo, un uomo che aveva già tentato di uccidere un collega. Daniele che fa gli aeroplanini con scritto “Ti voglio bene, papà”. Lui lo fa girare di spalle, gli taglia la gola e gli dice: “Fanne uno anche per il nonno.” Poi nasconde il suo corpo nell’armadio e va da Silvia, la madre, per uccidere anche lei. Queste due storie mi fanno male fisicamente. Perché mostrano una ferocia lucida, premeditata.E soprattutto urlano che questi non sono raptus: sono fallimenti del sistema, segnali ignorati, allarmi rimasti inascoltati.
Che sollievo ne hanno ricavato le famiglie?
Il sollievo, quando perdi una figlia, non esiste. Esiste però un respiro. Una dignità restituita. Molte famiglie, leggendo il monologo, mi hanno detto: “Per un attimo l’hai riportata qui con noi.” Questa frase vale tutto. Perché le loro figlie non diventano un trafiletto, non diventano una statistica, non vengono archiviate. Diventano memoria. E la memoria è una forma di giustizia.
C’è una storia in cui ti riconosci?
Mi riconosco in tutte. Non perché io abbia vissuto quello che hanno vissuto loro, ma perché anch’io conosco il dolore, la fragilità, la paura di perdere chi ami. Mi riconosco nelle madri che stringono una foto, nelle sorelle costrette a essere forti, nelle donne che hanno chiesto aiuto e non sono state ascoltate. E mi riconosco nel bisogno di dare un senso al dolore.
Io ho trasformato il mio, quello vissuto con la malattia di mio marito Luigi, quello che ti cambia la prospettiva, in un atto di servizio. Per questo dico sempre che questo libro non l’ho scritto io: lo hanno scritto loro, attraverso me».
Come hai scelto le storie?
In realtà è stato più vero il contrario: sono state le storie a scegliere me. Alcune mi sono venute incontro da sole: da una foto, da un racconto, da un servizio televisivo. Gli occhi di Sofia mi si sono entrati dentro la prima volta che li ho visti: profondi, maturi, pieni di vita. Di Chiara ho visto subito il sorriso, un sorriso che apriva il mondo, e poi il suo arco con le frecce, la sua passione, il suo amore per il papà. Daniele aveva un sorriso pazzesco, un sorriso che ti entra dentro senza chiedere permesso. Di Giulia mi ha catturata la dolcezza, quella purezza che traspariva dallo sguardo. Carol mi parlava attraverso la solitudine dei suoi occhi. E Marisa, con quegli occhi che brillavano, era luce pura. Queste ragazze e questi ragazzi non sono numeri, non sono casi, non sono articoli di cronaca. Sono volti. Sono sguardi. Sono sorrisi. E quando quegli occhi ti guardano, anche solo in una foto, non puoi far finta di niente. Io non le ho scelte davvero. Le ho incontrate, ascoltate e accolte.
Cosa si può fare a livello personale per prevenire i femminicidi?
La prevenzione non comincia quando una donna denuncia. Comincia molto prima. A livello personale possiamo: credere alle donne quando parlano, non minimizzare gelosia, controllo, isolamento, smettere di romanticizzare il possesso, educare i ragazzi al rispetto, non alla conquista, insegnare alle ragazze che i confini del proprio corpo sono sacri e non devono essere giustificati.La prevenzione inizia nelle parole, nei gesti, nella cultura quotidiana.
E a livello istituzionale? Scuole, Stato, politica?
Occorre una rivoluzione culturale, non un cerotto.Servono:programmi obbligatori di educazione affettiva nelle scuole, dalle elementari, più centri antiviolenza e finanziamenti stabili, non emergenziali, formazione obbligatoria e continua per forze dell’ordine, magistrati, insegnanti, tempi rapidi per applicare le misure cautelari, una rete reale di protezione per chi denuncia: case rifugio, sostegno psicologico, indipendenza economica, una banca dati nazionale aggiornata e completa, campagne istituzionali permanenti, non solo il 25 novembre. Il femminicidio non è un’emergenza. È un sistema. E un sistema si cambia solo con educazione, cultura e coraggio politico.
L’autrice dell’intervista: Lucia Tilde Ingrosso è autrice di molti volumi ed è nota anche per la sua fortunata serie di gialli dell’ispettore Rizzo. Da poco sono usciti per Baldini e Castoldi I Monteleone e Le stagioni della verità. Nel 2022 ha pubblicato il romanzo biografico Anna Politkovskaja. Per left ha scritto Lo sguardo lungo di Anna Politkovskaja
foto d’apertura adobe