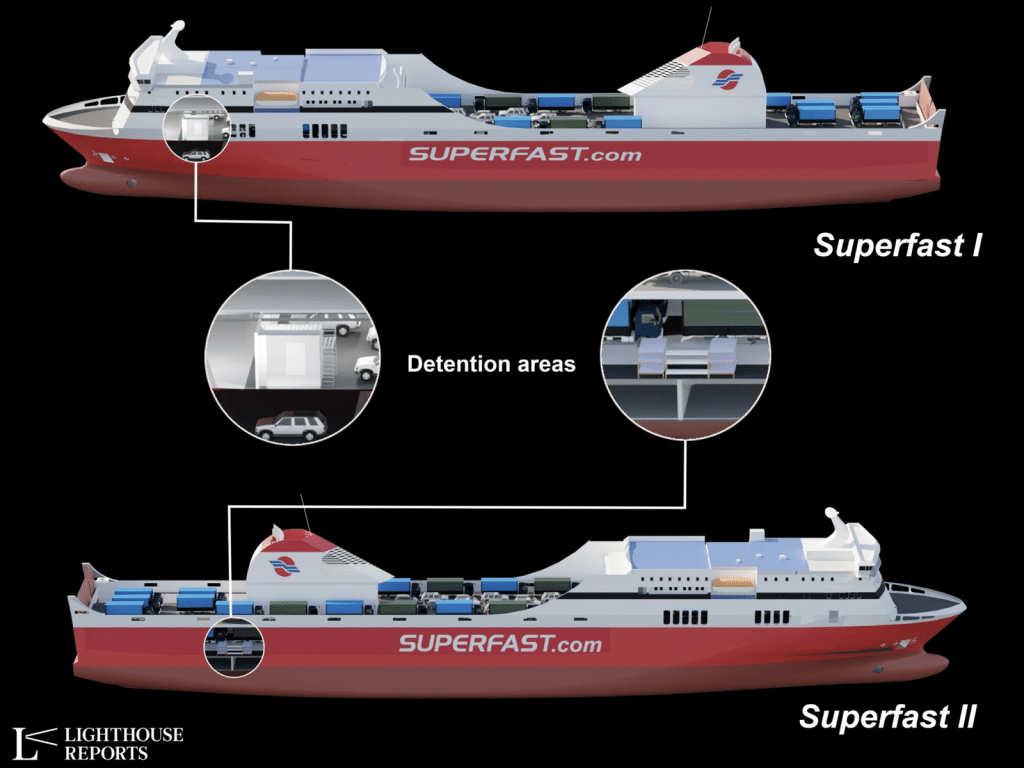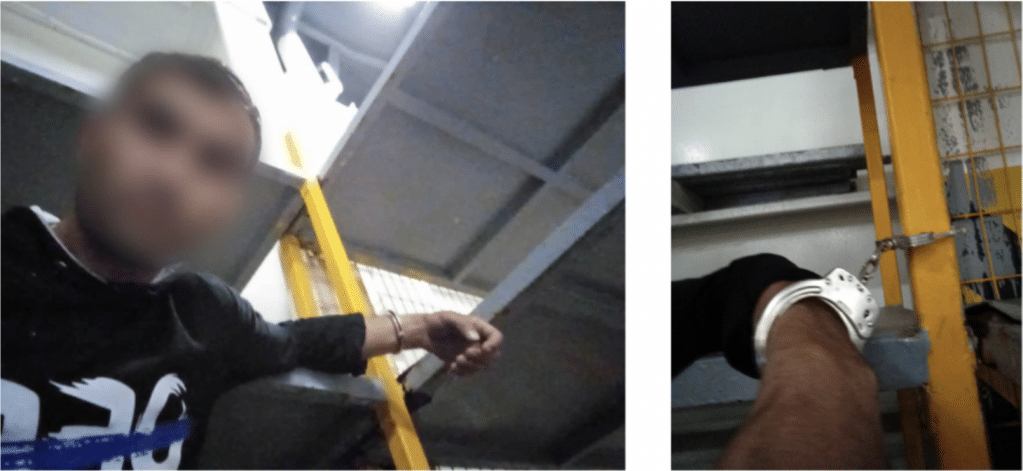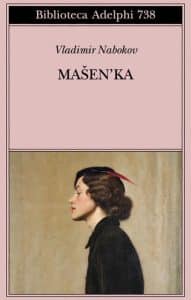Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha detto di recente che Dante è «il fondatore del pensiero di destra nel nostro Paese». Non sorprende, dato che spesso la politica prende la via della polemica, che questa affermazione, nata per polemizzare, sia finita al centro di un dibattito che si è sforzato di verificare o falsificare se davvero «quella visione dell’umano, della persona, delle relazioni interpersonali che troviamo in Dante Alighieri, ma anche la sua costruzione politica che è in saggi diversi dalla Divina Commedia, sia profondamente di destra».
Come si è sottolineato da più parti, è assurdo misurare con parametri contemporanei la visione politica di Dante, che non prevedeva categorie come la destra o la sinistra, ma ne aveva storicamente altre: i conflitti che contavano per lui erano quelli tra Guelfi e Ghibellini, tra Guelfi Bianchi e Neri, tra Chiesa ed Impero, tra monarchie come quella Angioina e quella Aragonese a cui guardava con mai celato sospetto. Tutte categorie che hanno in comune con quelle moderne di destra e di sinistra forse solo l’altrettanto spiccata fluidità nella pratica politica.
È forse più utile, dunque, e sicuramente più corretto dal punto di vista che accomuna chi scrive, riflettere su altre categorie, oltre «la visione dell’umano e la costruzione politica di Dante», per chiedersi se davvero lo si possa usare per articolare un “pensiero di destra” o di sinistra, guardando più direttamente alla categoria che è più propria a un intellettuale-poeta, cioè a qualcuno che ragiona sempre, anche quando fa politica, in termini di linguaggio.
Chi scrive poesia, in fondo, pensa al mondo sempre in termini di linguaggio. E sul linguaggio, su che cosa sia e a che cosa serva la lingua che parliamo e che scriviamo, ci sono idee di lungo periodo che possono, quelle sì, essere considerate di destra o di sinistra. Non è un caso, infatti, che spesso chi ha eletto Dante a nume tutelare di un pensiero di destra, facendone il campione di una visione individualista e nazionalista dell’esistenza, lo abbia fatto associandogli il titolo di padre della lingua italiana e profeta della patria – la Nazione con la lettera maiuscola che si trova nelle parole del ministro Sangiuliano.
Eleggere Dante al ruolo di padre della lingua italiana è una prassi non nuova nella destra nazionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad esempio, da deputata di opposizione proprio in occasione del Dantedì celebrato il 25 marzo 2021, aveva affidato a un video pubblicato su Facebook un messaggio che conteneva la netta rivendicazione di Dante come «autenticamente nostro, autenticamente italiano, autenticamente cristiano». Per l’attuale premier già allora Dante era «il padre della nostra identità» e questa identità si definisce per lei immediatamente su base linguistica. La “nostra” identità, continuava il messaggio, è «un’identità che noi vogliamo difendere a partire dalla nostra lingua».
A rafforzare il nesso tra identità nazionale e lingua veniva, infatti, menzionata nello stesso messaggio la proposta da parte di Fratelli d’Italia sia di una legge costituzionale sia di una mozione volte a riconoscere l’italiano come lingua ufficiale della nazione, e dunque a stipularne l’utilizzo esclusivo «negli atti del Parlamento, della pubblica amministrazione e degli enti locali». Esisterebbe, dunque, un’identità italiana, mono-linguistica e cristiana che si ritroverebbe in Dante, un’identità da recuperare correggendo i presunti errori commessi da lettori e lettrici del nostro tempo.
Rivendicare l’italianità di Dante, insistendo sull’idea che egli sia autenticamente “nostro”, è funzionale a una strategia di esclusione, questa sì marcatamente di Destra, che rifiuta di considerare valida una lettura delle sue opere in ogni altro contesto culturale che non sia quello italiano e che si sforza di tenere il mondo fuori da Dante e Dante fuori dal mondo. La rivendicazione di Dante come “nostro” è in realtà il frutto di un doppio anacronismo. Da un lato è un modo di negare in via di principio quanto è in realtà accaduto per la Commedia, la cui vitalità in un contesto internazionale è innegabile: le opere di Dante sono oggetto di insegnamento fuori dall’Italia, di continue traduzioni in una vasta gamma di lingue, e di sempre nuove pratiche di adozione e riuso artistico globali. Dall’altro lato, parlare di italianità per Dante implica l’illusione che niente sia cambiato nei sette secoli che ci separano dalla morte di Dante e che, anzi, la tanto vantata sua autenticità culturale si possa trovare proiettando il paradigma monolinguistico dello Stato nazionale moderno sulla situazione tardo medievale di quell’area geografica che adesso si chiama Italia, sia travisandone la natura sia retrodatandolo di più di cinque secoli.
Quando ci si avvicini alla questione della lingua in Dante con occhi non accecati dall’amor patrio, ci rendiamo conto di quanto poco nazionalista o localista fosse il poeta della Commedia nelle sue prese di posizione. Già nel De vulgari eloquentia, Dante aveva rivendicato un’identità cosmopolita, scrivendo: Nos autem cui mundus est patria velut piscibus equor. Come il mare per i pesci, così per me la mia patria e il mondo. Non contento, Dante aveva attaccato con un sarcasmo spietato, che anticipa quello della Commedia contro ogni campanilismo politico e culturale, tutti coloro che pensano che la loro lingua sia la stessa parlata da Adamo. Per lui questo errore di prospettiva, che impedisce di immaginare che esistano lingue diverse (Dante dice anche più nobili e più dolci) di quella con cui siamo nati, equivale alla miopia di coloro che, vivendo lì, pensano che il mondo inizi e finisca a Pietramala. Lo scherno con cui ipotizza che una frazione fuori Firenze viva in un’insularità così estrema da illudersi che il proprio idioletto sia il migliore che possa esistere è un meraviglioso antidoto, tutto dantesco, ad ogni politica basata su di un’astratta purezza linguistica e una restrittiva identità nazionale.
Anche in un momento di accentramento linguistico come quello che sembra emergere nel primo libro del De vulgari eloquentia, quando Dante rintraccia nella corte di Federico II e Manfredi le origini della tradizione poetica a cui dichiara di appartenere, l’italianità del volgare sovramunicipale che il trattato si sforza di definire è bilanciata dalla natura particolarmente multietnica e multiculturale di quel contesto politico. Se è vero che al centro della corte si trovano i due monarchi, degli illustres heroes che sanno coltivare nobiltà e rettitudine, non vivendo come bruti, ma seguendo virtù e conoscenza («humana secuti … brutalia dedignantes»), è anche chiaro che il prodotto della loro politica culturale non nasce dall’italianità dei soggetti che vi aderiscono. Casomai, la produce. «Coloro che erano nobili d’animo e ricchi di grazie si sforzavano», scrive Dante, «di associarsi alla grandezza di quei monarchi. Così avvenne che tutto ciò che in quel tempo veniva prodotto dai più eccellenti individui tra gli italiani, veniva alla luce in quella corte». È importante notare che gli individui che vengono attratti dai regnanti di Sicilia non sono chiamati “italiani” immediatamente: di loro si dice solo che sono tutti coloro che hanno cuori nobili e virtuosi; è solo dopo essere venuti a corte e aver prodotto le loro opere che vengono definiti «excellentes animi Latinorum». È un processo di acculturazione, questo, che rispecchia la natura multi-linguistica e multi religiosa della corte federiciana. Questo modello di società aperta, che ispira intellettuali di diversa formazione ad attraversare confini geografici e linguistici e collaborare nella creazione di cultura è esattamente quanto il pensiero della Destra si preclude costituzionalmente, quando insiste su di una definizione restrittiva dell’autenticità culturale. Parole come quelle dell’onorevole Meloni tendono infatti a rigettare la mescolanza linguistica che non è solo al cuore della poesia di Dante, ma anche, più in generale, della cultura in volgare nell’Italia medievale.
Di fronte all’insistenza che Dante sia “autenticamente” italiano per la lingua che usa, infine, è importante ricordare quanto ibrido e poliglotta sia in realtà il poema che ha scritto. Lo si può fare concentrandosi sui quei momenti di alterità linguistica e culturale che suggeriscono quanto Dante sia pronto a mescolare lingue diverse e valutare quanto questa pratica di ibridazione sia in linea con una prospettiva globale sul medioevo. Alla fine di Purgatorio 26, ad esempio, quando assegna al trovatore Arnaut Daniel otto versi in provenzale, Dante non solo dà voce a una tradizione lirica non toscana, ma si spinge fino a creare un neologismo in quella lingua, il termine “escalina”. Non diversamente, ma con un oltranzismo linguistico ancora più spiccato, all’inizio di Paradiso 7, Dante mescola ebraico, latino e italiano e, anche in quel caso, crea un neologismo in una lingua che, in teoria, non gli apparterrebbe: il participio ‘superillustrans’. Siamo, insomma, davvero troppo abituati a pensare a Dante come un padre fondatore di una tradizione letteraria e linguistica, ma quella tradizione è più variegata e complessa di quanto si tenda a farci credere.
Sarebbe un errore ritenere che questi momenti di ibridazione linguistica, che sono certamente localizzati nel tessuto linguistico della Commedia, siano un’eccezione o un’incoerenza nel pensiero linguistico di Dante. Per tutto il poema ci sono segnali che Dante considera la lingua che nel suo testo ha scelto come strumento di comunicazione un aspetto contingente e in nessun modo essenziale al messaggio che veicola. Basta guardare a tre canti che portano lo stesso numero nel poema, i Canti XXVI, per rendersi conto che quando Dante parla di lingua nostra, ha in mente un paradigma più vasto e più articolato di quanto appaia. Nel ventiseiesimo dell’Inferno, dove va in scena l’impossibile dialogo tra un personaggio come Ulisse, a cui Dante assegna un’identità linguistica ben definita (lui e Diomede “fuor greci”), e il protagonista che vari dannati hanno riconosciuto già più di una volta come fiorentino, Virgilio si offre come interprete linguistico prima ancora che culturale. Non possiamo leggere quell’episodio senza percepire sullo sfondo i continui scarti tra le tre lingue della poesia epica, che esiste allo stesso tempo e nello stesso spazio in greco, latino e volgare – un volgare che Dante non esita ad attribuire anche a Virgilio, dandogli nell’attacco del canto successivo una battuta in vernacolo lombardo: «Istra ten va, più non ti adizzo».
Nel ventiseiesimo del Paradiso, tornando ancora sulla questione della lingua, Dante fa i conti con l’idea che possa esistere un idioma migliore degli altri, una lingua che abbia uno statuto che va oltre la semplice contingenza, che sia naturalmente stabile, sempre uguale a se stessa, e mette in evidenza l’assurdità di ogni tentativo di fermare la sua naturale metamorfosi. Lo fa chiamando in causa nientemeno che il primo parlante, Adamo, che confessa che la lingua da lui fabbricata si esaurì completamente e naturalmente, prima ancora che fosse comminata al genere umano la punizione divina per la Torre di Babele. Al centro di questo trittico linguistico, infine, Dante mette l’episodio di Arnaut Daniel, in cui non solo decide di scrivere direttamente in provenzale, cioè in una lingua che, per i parametri della Destra di oggi, non sarebbe la sua, ma insiste anche sul fatto che quella alterità linguistica non è in nessun modo un impedimento alla comunicazione.
Anzi, come avrebbe detto Walter Benjamin, la comunicazione più riuscita è quella che si basa sul desiderio intrinseco a tutte le lingue di comunicare, un desiderio che nell’attività di traduzione si manifesta nella sua forma più pura come volontà reciproca di comunicare tra i parlanti. La Commedia si presenta, insomma, come testo costituzionalmente basato su di un dialogo tra le lingue, un’opera che aspira sempre ad essere aperta alla traduzione.
Non è, questa, certo una scoperta nostra. Il potenziale messaggio cosmopolita della Commedia lo aveva avvertito perfettamente già Primo Levi, quando, in Se questo è un uomo, aveva usato proprio Dante e proprio il Canto di Ulisse per rivendicare, in un momento di parziale libertà strappato alla violenza sistematica del Lager, la condivisa umanità con il compagno di prigionia Jean. Ed è proprio nel contesto di uno scambio tra parlanti di lingue diverse, un dialogo motivato dal desiderio di uno di loro di allargare il proprio orizzonte linguistico imparando una lingua nuova, che la lezione di Primo su cosa significhi essere esseri umani si svolge passando continuamente da una lingua all’altra, dando corpo perfettamente, attraverso la definizione più inclusiva immaginabile, all’espressione di Dante: lingua nostra.
Dantista, autore di numerosi saggi, Simone Marchesi insegna all’Università di Princeton. A sua volta studioso di Dante, Akash Kumar insegna all’Università della California, a Berkeley
Immagine di apertura: Dante, di Luca Signorelli – Opera propria Georges Jansoone (JoJan), 2008