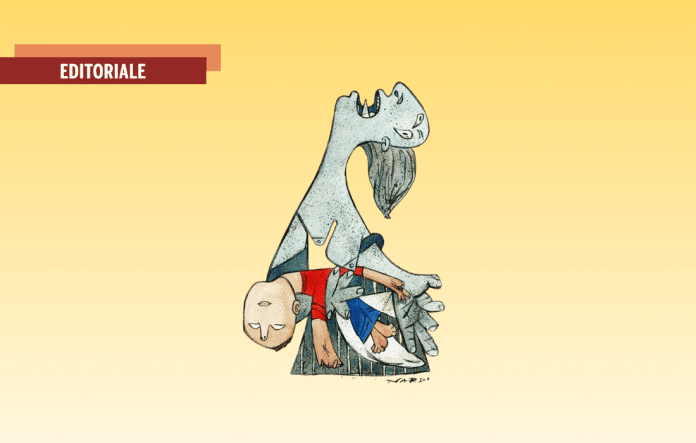Per la nave ong “Mediterranea” ci sarà nuovamente l’applicazione del decreto Piantedosi.
La nave era stata obbligata all’àncora al porto di Trapani da un fermo amministrativo, per essersi rifiutata di arrivare fino al porto assegnato di Genova per far sbarcare gli 11 migranti tratti in salvo in zona SARS libica.
Il fermo amministrativo era stato poi revocato dal Tribunale di Trapani il 9 ottobre scorso e la ong era potuta, finalmente, tornare a svolgere il suo compito in mare.
La missione di “ripresa” è stata impegnativa fin dal principio.
Venerdì scorso, al largo di Lampedusa, “Mediterranea” si era imbattuta in un respingimento fantasma: un barchino vuoto, predato dalle milizie libiche dopo aver catturato i naufraghi per riportarli in Libia.
Sabato 1 novembre, rispondendo ad un May Day Relay di Frontex, la nave ong ha tentato un salvataggio di 40 persone a 30 miglia dalla costa della Libia, che però sono state intercettate dalla guardia costiera libica, tratte in “salvo” e, anche in questo caso, li ha riportati nei centri di detenzione libici.
Domenica 2 novembre, in zona SAR italiana, “Mediterranea” trae in salvo 65 persone in due diverse operazioni.
I migranti, partiti da Zuara, erano in viaggio da quattro giorni, a disposizione poca acqua, niente cibo. Erano disidratati, avevano viaggiato in condizioni estreme e venivano da situazioni di violenze e abusi importanti.
Lunedì 3 novembre, un altro soccorso di 27 persone: a bordo di Mediterranea ci sono 92 persone, di cui 31 minori non accompagnati.
C’è anche una donna incinta di 4 mesi, che scopre da un’ecografia fatta dal medico di bordo, Gabriele “Mimmo” Risica, di aspettare un maschietto.
I naufragi sono di 19 nazionalità diverse ma con una storia comune di violenze, schiavitù e la comune speranza di una vita migliore, al sicuro.
La capo missione, Sheila Melosu, ed il capitano di “Mediterranea” chiedono che venga assegnato il porto di sbarco più vicino.
Dal Viminale assegnano Livorno, che equivale a quattro giorni di navigazione con mare grosso: le persone soccorse vomitano, non mangiano, non bevono, sono fortemente disidrate e con le condizioni di vulnerabilità in accrescimento.
Già nella giornata di Lunedì gli avvocati di “Mediterranea” si erano rivolti al Tribunale dei minori di Palermo che ha accordato lo sbarco dei minori a Porto Empedocle, a causa della precarietà delle condizioni di bordo e della promiscuità con gli adulti.
Ma l’MRCC ha concesso il trasbordo dei minori in mare e non ha assegnato una banchina alla nave. Una soluzione inaccettabile per l’equipaggio di “Mediterranea”, perché negare lo sbarco ed i soccorsi sanitari agli altri 61 naufragi in tempi brevi significa che il governo italiano si appresta a violare, ancora una volta, il diritto internazionale ed i diritti umani.
Così, alle 16.30 di martedì 5 novembre, “Mediterranea” è entrata ed ha ormeggiato alla banchina “Sciangula” di Porto Empedocle. La successiva visita dell’USMAF col medico della sanità marittima ha innalzato la tensione tra i naufraghi.
L’USMAF infatti effettua una vera e propria “selezione” – termine orribile che rievoca un momento storico in cui la disumanizzazione dell’uomo non ha avuto eguali – scegliendo in base a criteri di urgenza, chi può sbarcare e chi deve proseguire i viaggio verso Livorno. I naufraghi, temendo di essere rimpatriati in Libia, hanno iniziato a minacciare atti di autolesionismo.
Per l’equipaggio di “Mediterranea”, lo sbarco dei minori ed il proseguimento verso il porto assegnato non è un’opzione: non è un capriccio, non è nemmeno un atto di disobbedienza al decreto Piantedosi, è l’affermazione del diritto di sbarco per tutti, è l’obbedienza alle leggi internazionali e alla Convenzione di Amburgo. É un “no” di resistenza che, ad oggi, solo “Mediterranea” ha opposto ad un decreto inumano ed insensato.
Anche perché, i naufraghi sbarcati dalle navi ong al centro e al nord Italia, non infrequentemente vengono poi condotti via terra in centri al Sud Italia, a Reggio Calabria o in Puglia per esempio, via terra. Il vero scopo di assegnare un porto così distante è quello, scientifico, di riuscire a tenere le navi-soccorso più lontane possibile dal Mediterraneo, cosicchè le motovedette libiche possano agire indisturbate nel rintracciare i barconi e reimmettere i naufragi tratti “in salvo” nel circuito schiavista libico.
Intorno alle ore 18 di martedì è stata notificata una “diffida” da parte della Capitaneria di Porto Empedocle che intimava a nave MEDITERRANEA “successivamente allo sbarco dei soli minori, di riprendere la navigazione senza ritardo con i restanti migranti a bordo verso il POS originariamente assegnato e individuato nel porto di Livorno.”
“Siamo di fronte a un atteggiamento assurdo: da una parte sono state evidentemente riconosciute le condizioni di vulnerabilità fisiche e mentali che non avrebbero consentito ai naufraghi di affrontare altri tre giorni di navigazione e ulteriori sofferenze verso il lontano porto di Livorno.
Dall’altra, con questa diffida, le Autorità minacciano ingiustificate ritorsioni contro la nave MEDITERRANEA, colpevole solo di aver adempiuto al proprio dovere a tutela dei diritti fondamentali alla vita e alla cura delle persone soccorse e nel rispetto del diritto marittimo e umanitario, internazionale e nazionale”, dicono da Mediterranea.
Ma la ong non molla, sa che un altro fermo amministrativo non glielo toglie nessuno e sarà ancora più aspro dei 60 giorni inflitti a fine agosto, quando fece approdo nel porto di Trapani, perché “Mediterranea” è considerata recidiva.
Una recidiva che è resistenza, che a colpi di ricorsi sta facendo giurisprudenza in opposizione ad un decreto che punisce chi salva vite vite umane, una giurisprudenza che, come accade troppo spesso in Italia, arriva prima della politica.
“Mediterranea” non molla, e alle 19.35 di martedì tutte e 92 le persone salvate vengono sbarcate.
Ed ora a Sheila, a Mimmo, a Cecilia, Denny, Fatima ed ai membri della ong non resta che aspettare l’ennesima sanzione, l’ennesimo fermo che impedirà loro di salvare uomini e donne, di salvare vite umane che andranno perdute, inghiottite dal mare o dalla ferocia libica.
l’autrice: Valentina Colli è archeologa, attivista e collaboratrice TrapaniSI