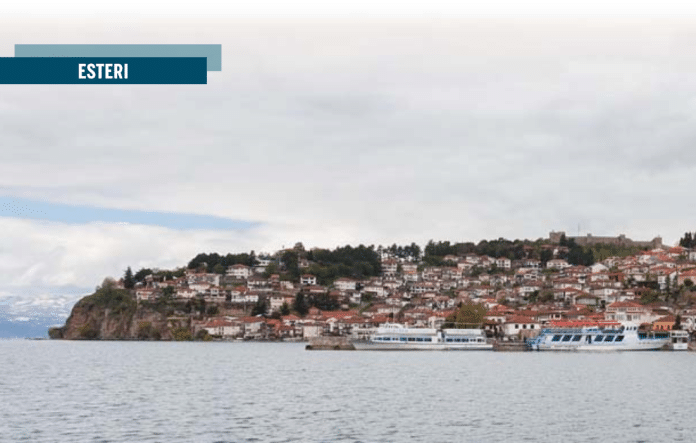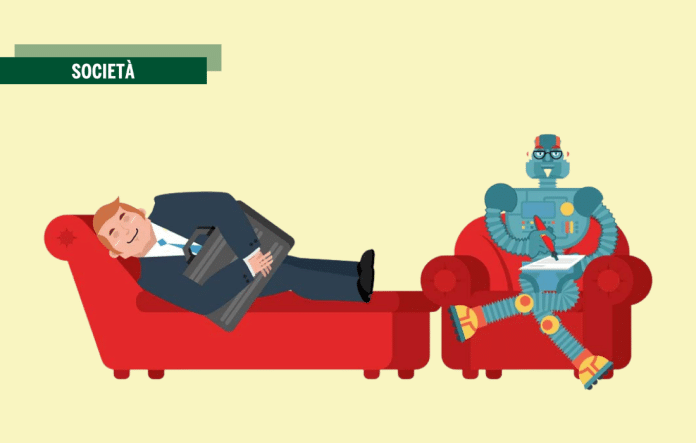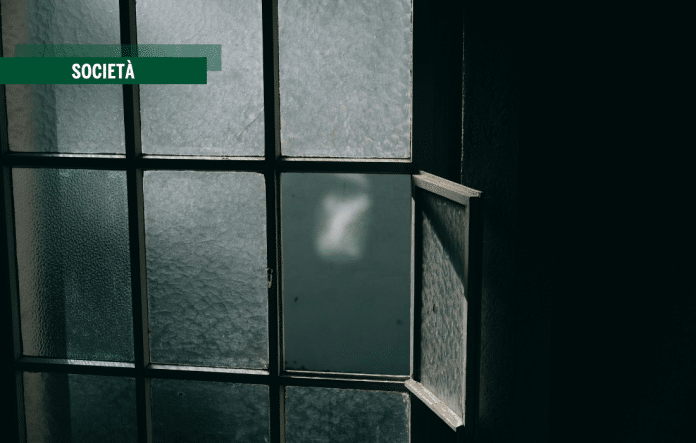“Perché leggere ancora?”. Con questo interrogativo si apre l’ultimo libro di Enrico Terrinoni, Leggere libri non serve. Sette brevi lezioni di letteratura, edito da Bompiani, che si presenta come una sorta di breviario laico focalizzato su sette grandi nomi di scrittori e scrittrici della letteratura mondiale, che per esplicita ammissione dell’autore richiama le Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, pubblicate da Adelphi.
L’agile libretto di Terrinoni mette al centro di tutto la lettura e la sua importanza, la letteratura e la sua utilità, e il suo servire. «Possiamo girarci attorno e scherzare a lungo, ma il punto resta sempre quello, e riguarda il binomio utilità-inutilità legato alla parola letteraria».
E non può non tornare in mente il nome di un grande studioso e intellettuale, scomparso qualche anno fa, che sulla questione scrisse un intero volume, anch’esso non a caso pubblicato da Bompiani: Nuccio Ordine, L’utilità dell’inutile. Terrinoni come Ordine afferma che la letteratura non può e non deve essere asservita al potere; serve, ma non è mai serva, perché una letteratura serva non è letteratura, e come la lettura è sempre libera e liberatrice.
«Noi leggiamo libri per non servire, e non servire significa capire altro per capire gli altri». Dunque, emerge con forza quel concetto di alterità, che nel caso della lettura per Enrico Terrinoni andrebbe chiamata “altritudine”, declinata alla Bergonzoni maniera: leggere come un “salto in altro”.
Le suggestioni e gli spunti di riflessione nel volumetto di Terrinoni sono molteplici; del resto, la molteplicità è una delle sue marche d’autore, così come la creatività artistica, che è immaginazione, genera moltitudini e insogna all’infinito. Le sette lezioni contenute nel libro sono infatti dedicate a sette concetti chiave, impersonate da altrettanti autori e autrici: la profezia (Oscar Wilde), il sogno (William Blake), l’infinito (James Joyce), l’eresia (Giordano Bruno), la coscienza (Italo Svevo), l’onda (Virginia Woolf) e infine in silenzio (William Shakespeare). La lezione numero 6 riservata a Virginia Woolf e all’onda si apre con una bella citazione del grande poeta irlandese e premio Nobel William Butler Yeats:«Quando suono il mio violino a Dooney/la gente danza come un’onda del mare».
Una citazione che rimanda letteralmente a The Waves della Woolf. Le sue sono